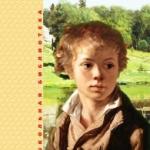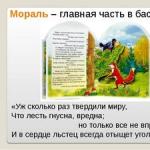Metodologia della ricerca scientifica. Ponomarev AB, Pikuleva EA
Il termine "metodologia" deriva dal greco "methodos" - via, via e "logos" - concetto, idea.
Ci sono una serie di definizioni generalizzate del concetto "metodologia":
1) questa è la dottrina dei principi, delle forme, dei metodi della conoscenza scientifica o della ricerca;
2) è la scienza dei metodi della cognizione e dei metodi della ricerca scientifica, cioè la scienza della scienza;
3) scienza, che determina la direzione generale dello sviluppo della ricerca, i suoi obiettivi, i suoi confini, i suoi principi; un metodo scientifico per stabilire le basi, sottolineando il significato dei concetti;
4) un campo della scienza che studia i metodi generali e particolari della ricerca scientifica, nonché i principi di approccio a vari tipi di oggetti della realtà ea diverse classi di problemi scientifici.
oggetto la metodologia è il processo della ricerca scientifica nella sua interezza, cioè tutta l'attività scientifica e cognitiva.
Nelle definizioni date sopra, la metodologia è associata solo al processo cognitivo. Secondo alcuni scienziati (Z.I. Ravkin, N.D. Nikandrov), è importante avere una chiara comprensione del fatto che la metodologia non è solo per la cognizione, ma anche per la trasformazione della realtà.
Da questo punto di vista, la definizione dell'attività di metodologia è data nel dizionario enciclopedico filosofico dell'edizione 1983. Questa definizione interpreta la metodologia come un sistema di principi e metodi per organizzare e costruire attività teoriche e pratiche, così come la dottrina di questo sistema.
Pertanto, ci sono, a loro volta, diversi approcci metodologici per comprendere la metodologia: 1) definendola solo a partire da posizioni teoriche; 2) definizione, tenendo conto dell'unità della sua essenza teorica e pratico-efficace.
Va notato che tutte queste definizioni e posizioni non si contraddicono a vicenda, ma si completano a vicenda.
La metodologia scientifica generale indirettamente, attraverso teorie, concetti di un particolare ramo della scienza, influenza la scelta di uno specialista in qualsiasi professione della sua posizione metodologica professionale. A partire da ciò, ogni branca della scienza formula una propria specifica definizione di metodologia, la cui base è una definizione scientifica generale. Ad esempio, la metodologia della pedagogia è definita come un sistema di conoscenza basato sulla metodologia generale della scienza sui punti di partenza della teoria pedagogica, sui principi di approccio alla considerazione dei fenomeni pedagogici e sui metodi di ricerca, nonché sui modi per introdurre le conoscenze acquisite nella pratica dell'educazione, della formazione e dell'istruzione (Kodzhaspirova GM ecc. Dizionario Pedagogico).
La questione della metodologia della pedagogia ha sempre suscitato polemiche scientifiche.
Dopo molti anni di discussioni, discussioni e sviluppi di ricerca specifici, si è formata una tale comprensione della metodologia della pedagogia, formulata da VV Kraevsky: la metodologia della pedagogia è un sistema di conoscenza sui fondamenti e sulla struttura della teoria pedagogica, sui principi di approccio e metodi per ottenere conoscenze che riflettano la realtà pedagogica, nonché un sistema di attività per ottenere tali conoscenze e sostanziare programmi, logiche, metodi e valutare la qualità del lavoro di ricerca.
L'argomento della metodologia della pedagogia, come notato da Kraevsky, funge da relazione tra la realtà pedagogica e la sua riflessione nella scienza pedagogica.
Evidenziando due funzioni della metodologia - descrittivo, cioè. descrittivo, che comporta anche la formazione di una descrizione teorica dell'oggetto, e prescrittivo, o normativa, che crea linee guida per il lavoro del ricercatore, è determinata, secondo lo scienziato, distinguendo tra due tipi di attività: ricerca metodologica e supporto metodologico. Il primo tipo riguarda un sistema di conoscenza, il secondo un sistema di attività di ricerca.
La presenza di queste due funzioni determina anche la divisione dei fondamenti della metodologia in due gruppi: i fondamenti della teoria e la normativa.
Quelli teorici lo sono: definizione della metodologia; una descrizione generale della metodologia della scienza, dei suoi livelli (filosofico generale, scientifico generale, scientifico concreto, livello dei metodi e delle tecniche di ricerca); metodologia come sistema di conoscenza e sistema di attività, fonti di supporto metodologico per attività di ricerca nel campo della pedagogia; oggetto e oggetto di analisi metodologica nel campo della pedagogia.
Basi normative coprire la seguente gamma di questioni: conoscenza scientifica in pedagogia tra le altre forme di esplorazione spirituale del mondo, che includono la conoscenza empirica spontanea e la riflessione artistica e figurativa della realtà; determinazione dell'appartenenza del lavoro nel campo della pedagogia alla scienza; la natura della definizione degli obiettivi, l'assegnazione di uno speciale oggetto di studio, l'uso di speciali mezzi di cognizione, l'univocità dei concetti; tipologia di ricerca pedagogica; caratteristiche della ricerca attraverso le quali uno scienziato può confrontare e valutare il proprio lavoro scientifico: problema, argomento, rilevanza, oggetto, soggetto, obiettivo, compiti, ipotesi, disposizioni protette, novità della ricerca, significato per la scienza, significato per la pratica; la logica della ricerca pedagogica; sistema delle discipline scientifiche pedagogiche, collegamento tra loro.
La metodologia della pedagogia, secondo lo scienziato, agisce come un campo di conoscenza e attività relativamente indipendente, soggetto alla propria logica di sviluppo e che riflette le fasi dell'evoluzione della pedagogia.
Nella scienza è riconosciuta l'esistenza di una gerarchia di metodologie e come tali spiccano:
Metodologia scientifica generale (dialettica materialistica, epistemologia (teoria della conoscenza), logica;
Metodologia scientifica privata (metodologia della pedagogia, metodologia della storia, metodologia delle scienze naturali, matematica, ecc.);
Soggetto-tematico (metodologia della didattica, metodologia del contenuto dell'educazione, metodologia della formazione matematica degli scolari, ecc.).
Riteniamo che una tale divisione non sia del tutto corretta. Quella che viene chiamata metodologia scientifica generale, cioè la dialettica materialistica, l'epistemologia e la logica formale sono più correttamente designate come fondamenti metodologici di ogni scienza. Di qui la necessità di individuare una particolare metodologia scientifica, dal nostro punto di vista, scompare. È invece più corretto designare “problemi metodologici”, “postulati metodologici” di un particolare ramo della scienza, per i quali le suddette sezioni della filosofia, nonché le forme logiche e le leggi logiche della conoscenza, sono la base metodologica.
Inoltre, la suddetta tradizionale suddivisione (singling out) delle metodologie non regge alle regole logiche di classificazione, ad esempio la vicinanza della sua nomenclatura. I concetti di "metodologia scientifica generale" e "metodologia scientifica particolare" non sono in fila, poiché il secondo è coperto dal primo. E la pratica di studiare la questione della metodologia di alcune materie accademiche indica che i loro problemi metodologici specifici sono considerati in unità con quelli scientifici generali, ad es. inizia con la comprensione dei fondamenti metodologici generali (dialettica, epistemologia, leggi della logica).
Ciò può essere confermato, ad esempio, dalla selezione di A.I. Kochetov di tre aspetti della metodologia della pedagogia: 1) la metodologia generale di qualsiasi scienza, le cui idee guida sono i concetti filosofici della conoscenza scientifica, le leggi della dialettica, il metodo dialettico di studio del mondo reale e la teoria della scienza creatività; 2) le idee guida della pedagogia e della psicologia stessa, su cui fanno affidamento il ricercatore e l'insegnante-professionista; 3) postulati e assiomi di uno specifico problema pedagogico.
Riteniamo necessario chiarire e integrare aspetti della metodologia generale della ricerca scientifica e della formazione.
Quindi, gli aspetti della metodologia della ricerca scientifica e dell'istruzione includono:
1) scientifico generale quadro metodologico qualsiasi scienza, le cui idee guida sono i concetti filosofici della conoscenza scientifica, le leggi della dialettica, il metodo dialettico di studio della realtà, il mondo reale, in altre parole, la dialettica materialistica, l'epistemologia (teoria della conoscenza), la logica e la teoria della creatività scientifica;
2) approcci metodologici alla ricerca scientifica e all'istruzione;
3) problemi metodologici ramo specifico della scienza;
4) postulati metodologici(assiomi) di un particolare ramo della scienza;
5) postulati metodologici specifico problema scientifico, che guida il ricercatore nella ricerca scientifica e nelle attività pratiche.
La base di questa divisione è il principio dell'ascesa dal generale al particolare.
Pertanto, parlando della metodologia della ricerca scientifica, individuiamo tali concetti come metodologici basi, metodologico approcci, metodologico I problemi, metodologico postulati. Qualsiasi disciplina scientifica, qualsiasi ricerca scientifica, qualsiasi materia accademica, il cui contenuto è una conoscenza scientifica pedagogicamente adattata, così come l'educazione all'unità dei contenuti e degli aspetti procedurali, si basa su tutti questi aspetti metodologici.
Questi aspetti metodologici saranno discussi di seguito. Ma prima, chiariamo i concetti la Fondazione(base), approccio (posizione), problema, postulato.
In alcuni dizionari filosofici, la base è intesa come un giudizio o un'idea, dalla cui realtà deriva necessariamente la validità di un altro giudizio o idea (conseguenza); base logica o base della conoscenza. Il vero fondamento ne differisce, il che rende l'idea dipendente dal contenuto sperimentale o dalla realtà metafisica.
Fondamento e conseguenza sono categorie filosofiche che esprimono il rapporto tra oggetti, in cui un fenomeno (il fondamento) dà origine necessariamente ad un altro (conseguenza). Ragione ed effetto fissano un lato nel rapporto di causa ed effetto, cioè che un fenomeno ne provoca un altro e non rivelano la dialettica di causa ed effetto, la causalità come forma complessa di interazione. Ogni fenomeno dà luogo ad una conseguenza, questa conseguenza a sua volta diventa fondamento e dà luogo ad un'altra azione, ecc. presenza di qualsiasi fenomeno.
Così, se le disposizioni filosofiche generali, le disposizioni della dialettica, la teoria della conoscenza (epistemologia), sono tradizionalmente la base (o base) metodologica della ricerca scientifica, anche se non sono esplicitamente indicate nell'introduzione della tesi, ma sono implicito, allora i modi, i metodi, le condizioni per risolvere il problema posto nei problemi di studio e le prove dell'ipotesi diventano una conseguenza di questo fondamento.
concetto "un approccio" in combinazione con il concetto di "metodologico" può essere interpretato come una direzione metodologica, come una posizione metodologica (dal latino Posizione - posizione, affermazione; punto di vista), che è una nuova formazione teorica in relazione ai fondamenti metodologici tradizionali. Se i fondamenti metodologici della ricerca scientifica e della formazione, anche se non esplicitamente indicati dall'autore della ricerca, rimangono stabili, necessari, invarianti per la ricerca in qualsiasi ramo della scienza, allora nel processo di sviluppo della scienza compaiono approcci metodologici, alcuni di essi diventano obsoleti, ne sorgono di nuovi, a volte contraddittori prima, esistenti.
EG Yudin definisce il concetto di "approccio" come un orientamento metodologico fondamentale dello studio, come il punto di vista da cui viene considerato l'oggetto di studio (il metodo di definizione dell'oggetto), come un concetto o principio che guida la strategia complessiva dello studio.
Esistono i seguenti approcci:
1) approccio sistema-strutturale;
2) approccio sinergico;
3) approccio assiologico;
4) approccio antropologico;
5) approccio ermeneutico;
6) approccio fenomenologico;
7) approccio umanistico;
8) approccio culturale;
9) approccio esoterico (paradigma esoterico).
Problema(dal greco problema - compito, compito) - una questione teorica o pratica che deve essere risolta.
I problemi metodologici sono tali problemi, la cui formulazione e soluzione sono necessarie per una formulazione e una soluzione ragionevoli di un altro problema: metodologico, teorico e pratico. Questa definizione riflette solo il lato esterno della questione. Pertanto, dato che qualsiasi problema è una contraddizione nota, il problema metodologico può essere, in aggiunta a quanto sopra, definito come una contraddizione tra l'oggetto della cognizione (ad esempio, pedagogico) e della trasformazione e il metodo di tale cognizione e trasformazione.
N. D. Nikandrov distingue tre gruppi di problemi metodologici di pedagogia dell'educazione:
Il primo gruppo di problemi si riferisce allo sviluppo del sistema educativo, questi sono problemi come l'ordine sociale della società al sistema educativo; integrazione delle influenze educative della scuola e dell'ambiente; l'informatizzazione nel sistema educativo e la scienza pedagogica; prevedere lo sviluppo del sistema educativo e della scienza pedagogica nel loro rapporto, il problema del livello unico dell'istruzione secondaria generale, ecc.
secondo gruppo i problemi metodologici sono un grande problema complesso: la logica dello sviluppo globale e armonioso dell'individuo come categoria pedagogica, che implica la soluzione di problemi più particolari sia metodologici che teorici: lo sviluppo globale dell'individuo come obiettivo universale e ideale di istruzione e formazione e istruzione in generale; la dialettica del rapporto tra formazione generale e formazione professionale nello sviluppo complessivo dell'individuo; sviluppo globale della personalità nell'ontogenesi e nelle istituzioni educative di vario tipo, ecc.
Il terzo grande blocco di problemi– problemi metodologici dello sviluppo della scienza pedagogica. Comprende problemi quali: la pedagogia nel sistema della moderna conoscenza scientifica; interazione tra scienza pedagogica e pratica pedagogica; leggi e modelli della pedagogia, loro sistema e identificazione; il problema della definizione di concetti e categorie di pedagogia; il problema della classificazione dei metodi didattici; miglioramento dei metodi, della metodologia e dell'organizzazione della ricerca pedagogica; il problema dell'integrazione in pedagogia delle conquiste di altre scienze; il problema del rapporto tra dialettica generale e particolare, ecc.
Postulato(dal latino postulatum - requisito) - un'esigenza, un presupposto, un provvedimento realmente necessario, che non necessita di prove rigorose, ma va fatto con peso e giustificazione, sulla base dei fatti o sulla base di spiegazioni sistematiche o pratiche; posizione accettata nella scienza come posizione di partenza senza prove.
Tra i principali postulati metodologici Gli scienziati della filosofia e della pedagogia mondiale includono quanto segue:
1) l'educazione è condizionata dalla natura stessa di una persona: per diventare persona, è necessaria un'educazione e un'autoeducazione a lungo termine;
2) l'educazione come disponibilità alla vita implica la sopravvivenza dell'individuo, e la sopravvivenza da sola è impossibile, quindi è necessario educare la collettività, la socialità, l'umanità, la filantropia, la capacità di cooperare, la democrazia, il compromesso, ecc. Quindi, la cultura della comunicazione e del comportamento è la componente principale dell'educazione di una persona;
3) una persona è una parte della natura, il suo tipico rappresentante per molti aspetti, quindi è importante osservare il principio di conformità alla natura nell'educazione; il principio di conformità alla natura non è solo la costruzione di un sistema pedagogico incentrato sui modelli di sviluppo del corpo e della psiche legati all'età, è anche l'apprendimento attraverso la vita reale, la comunicazione e l'interazione costanti con la natura, l'accumulo di esperienze in arricchirlo e preservarlo, in una parola - questa è educazione noosferica;
4) Il Novecento ha cambiato la tipologia del patrimonio culturale e storico, è finita l'era dei saperi sviscerati, nasce l'integrazione della formazione, pensata per educare una persona del futuro, peraltro, attenta ai pericoli e alle difficoltà, e non romanticismo e sogni, fantasia e sogni di un bel domani;
5) tutto nella società serve, dovrebbe servire all'educazione: economia, cultura, politica, vita privata. La società è pedagogizzata nel suo insieme e per sempre. L'esperienza mostra che laddove la produzione di valori spirituali precede la produzione di valori materiali, è possibile il massimo decollo economico;
6) l'individuo agisce come oggetto e soggetto del processo storico, delle relazioni sociali, dell'attività e dell'educazione. È caratterizzato da una base naturale (eredità), un'essenza sociale (educazione) e la massima adattabilità a un mondo che cambia (attività). L'uomo è un sistema attivo che si autoregola e si auto-sviluppa. L'educazione gioca un ruolo decisivo, poiché da essa dipende l'uso di tutti i fattori interni e il coordinamento, l'interconnessione delle condizioni esterne;
7) lo sviluppo del corpo e della psiche, l'autosviluppo e l'auto-miglioramento dell'individuo agiscono come fattori interni nella formazione dell'individuo e l'ambiente naturale e sociale, l'attività dell'individuo nel mondo esterno - come il condizioni principali per questo processo;
8) l'educazione e la scienza sono inutili o dannose se non servono alla moralità. Il valore dell'educazione non sta nella quantità di informazioni apprese (questo è il sacco di sistemi informativi che devi solo essere in grado di utilizzare), ma nello sviluppo della spiritualità umana, compresa la cultura, i valori spirituali e gli ideali morali.
In ogni scienza, così come nell'educazione, la metodologia svolge una serie di funzioni specifiche: regolamentazione, prescrizione, definizione degli obiettivi, regolamentazione, orientamento. Oltre a loro, alcuni scienziati distinguono funzioni riflessive, cognitive e critico-valutative. Tutte queste funzioni nel loro insieme forniscono una logica per l'attività scientifica.
Fino a poco tempo, nella metodologia della scienza pedagogica, queste funzioni erano presentate nella giustificazione filosofica, ideologica ed epistemologica dell'educazione solo dal punto di vista della dialettica materialistica e dell'interpretazione marxista-leninista, che era considerata l'unica vera, incrollabile metodologia, cioè le rigide leggi della scienza esatta classica furono trasferite, come notato da E.V. Bondarevskaya e Kulnevich, sulla scienza pedagogica.
Non c'è dubbio che la pedagogia e l'educazione, come ogni altro fenomeno, non possono esistere senza una certa base normativa filosofica. Ma, come giustamente affermano i suddetti scienziati, l'inibizione dello sviluppo della scienza, e dietro di essa la pratica, e soprattutto l'educazione, avviene quando il fondamento filosofico è proclamato assoluto, immutato. Allora, dai mezzi per raggiungere lo scopo, la proposizione fondamentale acquisisce segni di un fine in sé.
METODOLOGIA DI RICERCA
Il concetto di metodo e metodologia
L'attività scientifica, come qualsiasi altra, viene svolta con l'aiuto di determinati mezzi, nonché con tecniche e metodi speciali, ad es. metodi, il cui uso corretto determina in gran parte il successo nell'attuazione del compito di ricerca.
Metodo - è un insieme di tecniche e operazioni di sviluppo pratico e teorico della realtà. La funzione principale del metodo è l'organizzazione interna e la regolazione del processo di cognizione o trasformazione pratica di un oggetto.
A livello di attività pratica quotidiana, il metodo si forma spontaneamente e solo successivamente viene realizzato dalle persone. Nel campo della scienza, il metodo è formato consapevolmente e intenzionalmente.Il metodo scientifico corrisponde al suo status solo quando fornisce un'adeguata visualizzazione delle proprietà e dei modelli degli oggetti nel mondo esterno.
metodo scientifico è un sistema di regole e tecniche attraverso le quali si raggiunge la conoscenza oggettiva della realtà.
Il metodo scientifico ha le seguenti caratteristiche:
1) chiarezza o disponibilità pubblica;
2) mancanza di spontaneità nell'applicazione;
4) fecondità o capacità di raggiungere non solo i risultati collaterali attesi, ma non meno significativi;
5) affidabilità o capacità di fornire il risultato desiderato con un elevato grado di certezza;
6) economia o capacità di produrre risultati con il minor costo e tempo.
La natura del metodo è determinata essenzialmente da:
L'argomento dello studio;
Il grado di generalità dei compiti;
esperienza accumulata e altri fattori.
I metodi adatti a un'area della ricerca scientifica non sono adatti al raggiungimento di obiettivi in altri settori. Allo stesso tempo, stiamo assistendo a molti risultati eccezionali come conseguenza del trasferimento di metodi che si sono dimostrati validi in alcune scienze per altre scienze per risolvere i loro problemi specifici. Si osservano così tendenze opposte di differenziazione e integrazione delle scienze sulla base dei metodi applicati.
Qualsiasi metodo scientifico è sviluppato sulla base di una certa teoria, che, quindi, ne è la premessa. L'efficacia e la forza di un particolare metodo è dovuta al contenuto e alla profondità della teoria sulla base della quale è formato. A sua volta, il metodo viene utilizzato per approfondire ed espandere le conoscenze teoriche come sistema. Così, teoria e metodo sono strettamente interconnessi: la teoria, riflettendo la realtà, si trasforma in metodo attraverso lo sviluppo di regole, tecniche, operazioni che ne derivano - i metodi contribuiscono alla formazione, allo sviluppo, al perfezionamento della teoria, alla sua verifica pratica.
Il metodo scientifico contiene una serie di aspetti:
1) oggettivamente significativo (esprime la condizionalità del metodo da parte del soggetto della conoscenza attraverso la teoria);
2) operativo (fissa la dipendenza del contenuto del metodo non tanto dall'oggetto quanto dal soggetto della cognizione, la sua competenza e capacità di tradurre la teoria pertinente in un sistema di regole, tecniche che insieme compongono il metodo);
3) prasseologico (proprietà di affidabilità, efficienza, chiarezza).
Le principali funzioni del metodo:
Integrativo;
epistemologico;
Sistematizzazione.
Le regole sono centrali nella struttura di un metodo. regola è una prescrizione che stabilisce una procedura per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Una regola è una disposizione che riflette un modello in una determinata area disciplinare. Questo modello crea conoscenza di base regolamenti. Inoltre, la norma include un sistema di regole operative che assicurano il collegamento dei mezzi e delle condizioni con l'attività umana. Inoltre, la struttura del metodo ne include alcuni trucchi effettuata sulla base di norme operative.
Il concetto di metodologia.
In senso più generale, la metodologia è intesa come un sistema di metodi utilizzati in un determinato campo di attività. Ma nel contesto della ricerca filosofica, la metodologia è, prima di tutto, la dottrina dei metodi dell'attività scientifica, la teoria generale del metodo scientifico. I suoi compiti sono studiare le possibilità e le prospettive per lo sviluppo di metodi appropriati nel corso delle conoscenze scientifiche. La metodologia della scienza cerca di snellire, sistematizzare i metodi, per stabilire l'idoneità della loro applicazione in vari campi.
Metodologia della scienzaè una teoria della conoscenza scientifica, che esplora i processi cognitivi che si verificano nella scienza, le forme ei metodi della conoscenza scientifica. In questo senso agisce come conoscenza metascientifica di natura filosofica.
La metodologia come teoria generale del metodo si è formata in connessione con la necessità di generalizzare e sviluppare quei metodi sorti nella filosofia e nella scienza. Storicamente, inizialmente i problemi della metodologia della scienza si sono sviluppati nell'ambito della filosofia (il metodo dialettico di Socrate e Platone, il metodo induttivo di Bacone, il metodo dialettico di Hegel, il metodo fenomenologico di Husserl, ecc.). Pertanto, la metodologia della scienza è strettamente connessa con la filosofia, in particolare con una disciplina come la teoria della conoscenza.
Inoltre, la metodologia della scienza è strettamente correlata a una disciplina come la logica della scienza, che si è sviluppata dalla seconda metà del XIX secolo. La logica della scienza è una disciplina che applica i concetti e l'apparato tecnico della logica moderna all'analisi dei sistemi di conoscenza scientifica.
I principali problemi della logica della scienza:
1) lo studio delle strutture logiche delle teorie scientifiche;
2) lo studio della costruzione dei linguaggi artificiali della scienza;
3) lo studio di vari tipi di conclusioni deduttive e induttive utilizzate nelle scienze naturali, sociali e tecniche;
4) analisi delle strutture formali della fondamentale e delle derivate concetti scientifici e definizioni;
5) considerazione e miglioramento della struttura logica delle procedure e delle operazioni di ricerca e sviluppo di criteri logici per la loro efficienza euristica.
A partire dal XVII-XVIII secolo. le idee metodologiche sono sviluppate nell'ambito delle scienze particolari. Ogni scienza ha il suo arsenale metodologico.
Nel sistema delle conoscenze metodologiche si possono distinguere i principali gruppi, tenendo conto del grado di generalità e dell'ampiezza di applicazione dei singoli metodi in essi inseriti. Questi includono:
1) metodi filosofici (stabilire i regolatori più generali della ricerca - dialettica, metafisica, fenomenologica, ermeneutica, ecc.);
2) metodi scientifici generali (caratteristici di una serie di branche del sapere scientifico; non dipendono molto dalle specificità dell'oggetto di studio e dal tipo di problemi, ma allo stesso tempo dipendono dal livello e dalla profondità dello studio );
3) metodi scientifici privati (utilizzati nell'ambito delle singole discipline scientifiche speciali; caratteristica distintiva di questi metodi è la loro dipendenza dalla natura dell'oggetto di studio e dalle specificità dei compiti da risolvere).
A questo proposito, nell'ambito della metodologia della scienza, si distinguono l'analisi filosofica e metodologica della scienza, la metodologia scientifica generale e quella scientifica particolare.
Specificità dell'analisi filosofica e metodologica della scienza
In sostanza, ogni sistema filosofico ha una funzione metodologica. Esempi: dialettico, metafisico, fenomenologico, analitico, ermeneutico, ecc.
La specificità dei metodi filosofici sta nel fatto che non si tratta di un insieme di regole rigidamente fissate, ma di un sistema di regole, operazioni e tecniche universali e universali. I metodi filosofici non sono descritti in termini rigorosi di logica e di sperimentazione, non sono suscettibili di formalizzazione e matematizzazione. Stabiliscono solo le regole più generali della ricerca, la sua strategia generale, ma non sostituiscono metodi speciali e non determinano direttamente e direttamente il risultato finale della cognizione. In senso figurato, la filosofia è una bussola che aiuta a determinare la strada giusta, ma non una mappa su cui è tracciato in anticipo il percorso verso la meta finale.
I metodi filosofici svolgono un ruolo importante nella conoscenza scientifica, stabilendo una visione predeterminata dell'essenza di un oggetto. Qui si originano tutte le altre linee guida metodologiche, si comprendono le situazioni critiche nello sviluppo dell'una o dell'altra disciplina fondamentale.
La totalità delle norme filosofiche funge da mezzo efficace se è mediata da altri metodi più specifici. È assurdo affermare che, come conoscendo solo i principi della dialettica, sia possibile creare nuovi tipi di macchine. Il metodo filosofico non è una "chiave di scheletro universale", è impossibile ottenere direttamente da esso risposte a determinati problemi di scienze particolari attraverso un semplice sviluppo logico di verità generali. Non può essere un "algoritmo di scoperta", ma fornisce allo scienziato solo l'orientamento più generale della ricerca. Ad esempio, l'applicazione del metodo dialettico nella scienza - gli scienziati non sono interessati alle categorie "sviluppo", "causalità", ecc., ma ai principi regolatori formulati sulla loro base e come possono aiutare nella vera ricerca scientifica.
L'impatto dei metodi filosofici sul processo di conoscenza scientifica si svolge sempre non direttamente e direttamente, ma in modo complesso, indiretto. I regolamenti filosofici si traducono in ricerca scientifica attraverso regolamenti scientifici generali e specifici. I metodi filosofici non sempre si fanno sentire in forma esplicita nel processo di ricerca. Possono essere presi in considerazione e applicati spontaneamente o consapevolmente. Ma in ogni scienza ci sono elementi di significato universale (leggi, principi, concetti, categorie), dove si manifesta la filosofia.
Metodologia scientifica generale e scientifica privata.
Metodologia scientifica generaleè un corpus di conoscenze sui principi e sui metodi applicati in qualsiasi disciplina scientifica. Agisce come una sorta di "metodologia intermedia" tra la filosofia e le disposizioni teoriche e metodologiche fondamentali delle scienze speciali. I concetti scientifici generali includono concetti come "sistema", "struttura", "elemento", "funzione", ecc. Sulla base di concetti e categorie scientifiche generali, vengono formulati i metodi cognitivi corrispondenti, che assicurano l'interazione ottimale della filosofia con la conoscenza scientifica concreta e i suoi metodi.
I metodi scientifici generali si dividono in:
1) logica generale, applicata in ogni atto cognitivo ea qualsiasi livello. Sono analisi e sintesi, induzione e deduzione, generalizzazione, analogia, astrazione;
2) metodi di ricerca empirica applicati a livello empirico di ricerca (osservazione, sperimentazione, descrizione, misurazione, confronto);
3) metodi di ricerca teorici utilizzati a livello teorico di ricerca (idealizzazione, formalizzazione, assiomatica, ipotetico-deduttiva, ecc.);
4) metodi di sistematizzazione delle conoscenze scientifiche (tipologia, classificazione).
Tratti del carattere concetti e metodi scientifici generali:
La combinazione nel loro contenuto di elementi di categorie filosofiche e concetti di un certo numero di scienze particolari;
Possibilità di formalizzazione e perfezionamento con mezzi matematici.
A livello di metodologia scientifica generale, si forma un quadro scientifico generale del mondo.
Metodologia scientifica privataè un insieme di conoscenze sui principi e sui metodi utilizzati in una particolare disciplina scientifica. All'interno della sua struttura si formano speciali immagini scientifiche del mondo. Ogni scienza ha il suo specifico insieme di strumenti metodologici. Allo stesso tempo, i metodi di alcune scienze possono essere tradotti in altre scienze. Stanno emergendo metodi scientifici interdisciplinari.
Metodologia della ricerca scientifica.
L'attenzione principale nell'ambito della metodologia della scienza è rivolta alla ricerca scientifica come attività in cui si incarna l'applicazione di vari metodi scientifici.Ricerca scientifica- attività finalizzata all'acquisizione di una vera conoscenza della realtà oggettiva.
La conoscenza applicata al livello soggetto-sensoriale di alcune ricerche scientifiche ne costituisce la base metodi . In uno studio empirico, la metodologia prevede la raccolta e l'elaborazione primaria di dati sperimentali, regola la pratica del lavoro di ricerca - attività di produzione sperimentale. Il lavoro teorico richiede anche una propria metodologia. Qui le sue prescrizioni si riferiscono ad attività con oggetti espressi in forma di segni. Ad esempio, ci sono metodi di vari tipi di calcoli, decifrazione di testi, conduzione di esperimenti mentali, ecc.Allo stadio attuale dello sviluppo della scienza, sia nella sua forma empirica cheea livello teorico, la tecnologia informatica gioca un ruolo estremamente importante. Senza di essa, un esperimento moderno, la simulazione di situazioni, le varie procedure computazionali sono inconcepibili.
Qualsiasi metodologia viene creata sulla base di livelli di conoscenza più elevati, ma è un insieme di installazioni altamente specializzate, che include restrizioni abbastanza rigide: istruzioni, progetti, standard, specifiche eccetera. A livello di metodologia, le installazioni che esistono idealmente nei pensieri umani, per così dire, si fondono con operazioni pratiche, completando la formazione del metodo. Senza di loro, il metodo è qualcosa di speculativo e non esce mondo esterno. A sua volta, la pratica della ricerca è impossibile senza il controllo dal lato delle impostazioni ideali. Una buona padronanza della metodologia è un indicatore dell'elevata professionalità di uno scienziato.
Struttura di ricerca
La ricerca scientifica contiene una serie di elementi nella sua struttura.
Oggetto di studio- un frammento di realtà, a cui è diretta l'attività cognitiva del soggetto, e che esiste al di fuori e indipendentemente dalla coscienza del soggetto conoscente. Gli oggetti di studio possono essere di natura sia materiale che immateriale. La loro indipendenza dalla coscienza sta nel fatto che esistono indipendentemente dal fatto che le persone sappiano o non sappiano nulla di loro.
Oggetto di ricercaè una parte dell'oggetto direttamente coinvolto nello studio; queste sono le caratteristiche principali e più significative dell'oggetto dal punto di vista di un particolare studio. La specificità del tema della ricerca scientifica sta nel fatto che in un primo momento è impostato in termini generali, indefiniti, è anticipato e previsto in piccola parte. Infine, "incombe" alla fine dello studio. Quando si avvicina, lo scienziato non può immaginarlodisegni e calcoli. Ciò che deve essere "estratto" dall'oggetto e sintetizzato nel prodotto della ricerca - il ricercatore ha una conoscenza superficiale, unilaterale, non esaustiva al riguardo. Pertanto, la forma di fissare l'oggetto della ricerca è una domanda, un problema.
Trasformandosi gradualmente in prodotto di ricerca, il soggetto si arricchisce e si sviluppa a spese di segni e condizioni della sua esistenza inizialmente sconosciuti. Esternamente, questo si esprime in un cambiamento nelle domande che sorgono inoltre davanti al ricercatore, sono costantemente risolte da lui e sono subordinate all'obiettivo generale dello studio.
Possiamo dire che le singole discipline scientifiche sono impegnate nello studio di singole “sezioni” degli oggetti oggetto di studio. La varietà delle possibili "sezioni" dello studio degli oggetti dà origine alla natura multisoggettiva del sapere scientifico. Ciascuno dei soggetti crea il proprio apparato concettuale, i propri metodi di ricerca specifici, il proprio linguaggio.
Scopo dello studio - un'anticipazione ideale e mentale del risultato, per la quale vengono intraprese azioni scientifiche e cognitive.
Le caratteristiche dell'oggetto di ricerca influenzano direttamente il suo scopo. Quest'ultimo, compresol'immagine del soggetto di ricerca, è caratterizzata dall'incertezza insita nel soggetto all'inizio del processo di ricerca. Si concretizza man mano che si avvicina al risultato finale.
Gli obiettivi della ricercaformulare domande a cui è necessario rispondere per raggiungere gli obiettivi dello studio.
Gli scopi e gli obiettivi dello studio formano catene interconnesse, in cui ogni anello funge da mezzo per mantenere altri collegamenti. L'obiettivo finale dello studio può essere chiamato il suo compito generale e i compiti particolari che fungono da mezzo per risolvere quello principale possono essere chiamati obiettivi intermedi o obiettivi del secondo ordine.
Si distinguono anche i compiti principali e aggiuntivi dello studio: I compiti principali corrispondono al suo installazione di destinazione, altri sono previsti per preparare ricerche future, per testare ipotesi collaterali (possibilmente molto rilevanti) non correlate a questo problema, per risolvere alcuni problemi metodologici, ecc.
Modi per raggiungere l'obiettivo:
Se l'obiettivo principale è formulato come teorico, nello sviluppo del programma, l'attenzione principale è rivolta allo studio della letteratura scientifica su questo tema, una chiara interpretazione dei concetti iniziali, la costruzione di un ipotetico concetto generale dell'oggetto di ricerca , l'identificazione di un problema scientifico e l'analisi logica di ipotesi di lavoro.
Una logica diversa governa le azioni del ricercatore se si pone un obiettivo pratico diretto. Inizia a lavorare, partendo dalle specificità dell'oggetto dato e dalla comprensione dei problemi pratici da risolvere. Solo dopo si rivolge alla letteratura alla ricerca di una risposta alla domanda: esiste una soluzione "tipica" dei problemi sorti, cioè una teoria speciale relativa all'argomento? Se non esiste una soluzione "standard", viene distribuito ulteriore lavoro secondo lo schema della ricerca teorica. Se una tale soluzione esiste, le ipotesi ricerca applicata sono costruiti come diverse varianti di soluzioni tipiche di "lettura" in relazione a condizioni specifiche.
È molto importante tenere presente che qualsiasi ricerca orientata alla soluzione compiti teorici, puoi continuare come applicato. Nella prima fase, otteniamo una soluzione tipica al problema e poi la traduciamo in condizioni specifiche.
Anche un elemento della struttura della ricerca scientifica sonomezzi di attività scientifica e cognitiva. Questi includono:
Risorse materiali;
Oggetti teorici (costrutti ideali);
Metodi di ricerca e altri regolatori ideali della ricerca: norme, campioni, ideali dell'attività scientifica.
I mezzi di ricerca scientifica sono in costante mutamento e sviluppo. Il fatto che alcuni di essi siano applicati con successo in una fase dello sviluppo della scienza non è una garanzia sufficiente del loro accordo con nuovi regni della realtà e quindi richiedono miglioramenti o sostituzioni.
Approccio sistemico come programma metodologico scientifico generale e sua essenza.
Lavorare con problemi di ricerca complessi implica l'uso non solo vari metodi, ma anche diverse strategie di ricerca scientifica. Il più importante di essi, che svolge il ruolo di un programma metodologico scientifico generale di conoscenza scientifica, è un approccio sistematico.Approccio sistemicoè un insieme di principi metodologici scientifici generali, che si basano sulla considerazione degli oggetti come sistemi. Sistema - un insieme di elementi che sono in relazione e connessione tra loro, formando qualcosa di intero.
Gli aspetti filosofici dell'approccio sistemico sono espressi nel principio di sistemicità, il cui contenuto si rivela nei concetti di integrità, struttura, interdipendenza del sistema e ambiente, gerarchia, molteplicità di descrizioni di ciascun sistema.
Il concetto di integrità riflette la fondamentale irriducibilità delle proprietà di un sistema alla somma delle proprietà dei suoi elementi costitutivi e la non derivazione dalle proprietà di parti delle proprietà del tutto e, allo stesso tempo, la dipendenza di ogni elemento, proprietà e relazione del sistema al suo posto e funziona all'interno del tutto.
Il concetto di strutturalità fissa il fatto che il comportamento del sistema è determinato non tanto dal comportamento del suo singoli elementi, quante proprietà della sua struttura e che è possibile descrivere il sistema attraverso l'istituzione della sua struttura.
L'interdipendenza del sistema e dell'ambiente significa che il sistema forma e manifesta le sue proprietà in costante interazione con l'ambiente, pur rimanendo il principale componente attivo dell'interazione.
Il concetto di gerarchia si concentra sul fatto che ogni elemento del sistema può essere considerato come un sistema, e il sistema in esame in questo caso è uno degli elementi di un sistema più ampio.
La possibilità di molteplici descrizioni del sistema esiste a causa della complessità fondamentale di ciascun sistema, per cui una sua adeguata conoscenza richiede la costruzione di molti modelli differenti, ognuno dei quali descrive solo un certo aspetto del sistema.
La specificità dell'approccio sistemico è determinata dal fatto che focalizza lo studio sulla rivelazione dell'integrità dell'oggetto in via di sviluppo e dei meccanismi che lo assicurano, sull'identificazione dei diversi tipi di connessioni di un oggetto complesso e sulla loro integrazione in un unico sistema teorico . L'uso diffuso di un approccio sistematico nella pratica della ricerca moderna è dovuto a una serie di circostanze e, soprattutto, all'intenso sviluppo della moderna conoscenza scientifica oggetti complessi, la cui composizione, configurazione e principi di funzionamento sono tutt'altro che ovvi e richiedono un'analisi speciale.
Una delle forme di realizzazione più sorprendenti della metodologia dei sistemi èanalisi del sistema, che è una branca speciale della conoscenza applicata applicabile a sistemi di qualsiasi natura.
Recentemente, si è formata una metodologia cognitiva non lineare associata allo sviluppo di concetti scientifici interdisciplinari: la dinamica degli stati di non equilibrio e la sinergia. Nell'ambito di questi concetti si formano nuove linee guida per l'attività cognitiva, ponendo la considerazione dell'oggetto in studio come un sistema complesso autorganizzante e quindi storicamente autosviluppante.
Con un approccio sistematico come un programma metodologico scientifico generale è anche strettamente correlatoapproccio strutturale-funzionale, che è la sua varietà. È costruito sulla base della selezione in sistemi completi le loro strutture - un insieme di relazioni stabili e relazioni tra i suoi elementi e i loro ruoli (funzioni) l'uno rispetto all'altro.
La struttura è intesa come qualcosa di immutato sotto certe trasformazioni e la funzione come lo scopo di ciascuno degli elementi di questo sistema.
I principali requisiti dell'approccio strutturale-funzionale:
Studio della struttura, struttura dell'oggetto oggetto di studio;
Studio dei suoi elementi e delle loro caratteristiche funzionali;
Considerazione della storia del funzionamento e dello sviluppo dell'oggetto nel suo insieme.
I punti di riferimento dell'attività cognitiva, concentrati nel contenuto dei metodi scientifici generali, sono complessi distribuiti sistematicamente organizzati, caratterizzati da una struttura complessa. Inoltre, i metodi stessi hanno una relazione complessa tra loro. Nella pratica reale della ricerca scientifica, i metodi della cognizione vengono applicati in combinazione, stabilendo una strategia per risolvere i compiti. Allo stesso tempo, la specificità di uno qualsiasi dei metodi consente una considerazione significativa di ciascuno di essi separatamente, tenendo conto dell'appartenenza a un certo livello di ricerca scientifica.
Metodi logici generali della ricerca scientifica.
Analisi - smembramento di un soggetto olistico nelle sue parti costitutive (caratteristiche, proprietà, relazioni) ai fini del loro approfondimento.
Sintesi - collegamento di parti precedentemente distinte (lati, caratteristiche, proprietà, relazioni) di un oggetto in un unico insieme.
astrazione- una distrazione mentale da una serie di caratteristiche, proprietà e relazioni dell'oggetto in studio, evidenziando contemporaneamente in considerazione quelle che interessano il ricercatore. Di conseguenza, compaiono "oggetti astratti", che sono sia concetti e categorie individuali, sia i loro sistemi.
Generalizzazione - stabilire proprietà comuni e segni di oggetti. Generale - una categoria filosofica che riflette caratteristiche simili e ricorrenti, caratteristiche che appartengono a singoli fenomeni oa tutti gli oggetti questa classe. Ci sono due tipi generali:
Astratto-generale (semplice identità, somiglianza esterna, somiglianza di più oggetti singoli);
Concreto-generale (base interna, profonda, ripetitiva per un gruppo di fenomeni simili - essenza).
Di conseguenza, ci sono due tipi di generalizzazioni:
Identificazione di eventuali segni e proprietà degli oggetti;
Identificazione delle caratteristiche e delle proprietà essenziali degli oggetti.
In un'altra base, le generalizzazioni sono suddivise in:
Induttivo (dai fatti e gli eventi individuali alla loro espressione nei pensieri);
Logico (da un pensiero all'altro, più generale).
Metodo opposto alla generalizzazione − limitazione (passaggio da più concetto generale a uno meno generale).
Induzione - un metodo di ricerca in cui la conclusione generale si basa su premesse private.
Deduzione - un metodo di ricerca per mezzo del quale da premesse generali deriva una conclusione di natura particolare.
Analogia - un metodo cognitivo in cui, sulla base della somiglianza degli oggetti in alcune caratteristiche, concludono che sono simili in altre caratteristiche.
Modellazione - lo studio di un oggetto creando e studiando la sua copia (modello), sostituendo all'originale alcuni aspetti di interesse per la conoscenza.
Metodi di ricerca empirica
A livello empirico, metodi comeosservazione, descrizione, confronto, misurazione, esperimento.
Osservazione - questa è una percezione sistematica e mirata dei fenomeni, durante la quale acquisiamo conoscenza degli aspetti esterni, delle proprietà e delle relazioni degli oggetti oggetto di studio. L'osservazione non è sempre contemplativa, ma attiva, attiva. È subordinato alla soluzione di uno specifico problema scientifico e pertanto si distingue per intenzionalità, selettività e carattere sistematico.
I requisiti principali per l'osservazione scientifica sono: progettazione univoca, disponibilità di mezzi rigorosamente definiti (nelle scienze tecniche - dispositivi), obiettività dei risultati. L'obiettività è assicurata dalla possibilità di controllo attraverso l'osservazione ripetuta o l'uso di altri metodi di ricerca, in particolare la sperimentazione. Di solito, l'osservazione è inclusa come parte integrante della procedura sperimentale. Un punto importante l'osservazione è l'interpretazione dei suoi risultati - decodifica delle letture dello strumento, ecc.
L'osservazione scientifica è sempre mediata dalla conoscenza teorica, poiché è quest'ultima che determina l'oggetto e il soggetto dell'osservazione, lo scopo dell'osservazione e il metodo della sua attuazione. Nel corso dell'osservazione, il ricercatore è sempre guidato da una certa idea, concetto o ipotesi. Non si limita a registrare i fatti, ma ne seleziona consapevolmente quelli che confermano o confutano le sue idee. È molto importante selezionare il gruppo di fatti più rappresentativo nella loro relazione. L'interpretazione di un'osservazione viene sempre effettuata anche con l'ausilio di alcune proposizioni teoriche.
L'implementazione di forme avanzate di osservazione implica l'uso di mezzi speciali - e principalmente dispositivi, il cui sviluppo e attuazione richiede anche il coinvolgimento di concetti teorici della scienza. Nelle scienze sociali, la forma dell'osservazione è la domanda; per la formazione di strumenti di indagine (questionari, interviste) sono richieste anche particolari conoscenze teoriche.
Descrizione - fissazione mediante un linguaggio naturale o artificiale dei risultati di un esperimento (dati di osservazione o di esperimento) utilizzando alcuni sistemi di notazione adottati in ambito scientifico (diagrammi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi, ecc.).
Nel corso della descrizione, viene effettuato il confronto e la misurazione dei fenomeni.
Confronto - un metodo che rivela la somiglianza o la differenza di oggetti (o fasi di sviluppo dello stesso oggetto), ad es. loro identità e differenze. Ma questo metodo ha senso solo nell'aggregato di oggetti omogenei che formano una classe. Il confronto degli oggetti nella classe viene effettuato in base alle caratteristiche che sono essenziali per questa considerazione. Allo stesso tempo, i segni confrontati secondo un segno possono essere incomparabili secondo un altro.
Misurazione - un metodo di ricerca in cui viene stabilito il rapporto tra un valore e l'altro, che funge da standard. La misurazione trova la più ampia applicazione nelle scienze naturali e tecniche, ma dagli anni 20-30 del XX secolo. viene utilizzato anche nella ricerca sociale. La misurazione implica la presenza di: un oggetto su cui viene eseguita qualche operazione; proprietà di questo oggetto, che possono essere percepite, e il cui valore viene impostato utilizzando questa operazione; strumento attraverso il quale viene eseguita questa operazione. L'obiettivo generale di qualsiasi misurazione è ottenere dati numerici che consentano di giudicare non tanto la qualità quanto la quantità di determinati stati. In questo caso, il valore del valore ottenuto dovrebbe essere così vicino a quello vero da poterlo utilizzare a tale scopo al posto di quello vero. Sono possibili errori nei risultati della misurazione (sistematici e casuali).
Esistono procedure di misurazione dirette e indirette. Questi ultimi includono misurazioni di oggetti che sono lontani da noi o non sono percepiti direttamente. Il valore della grandezza misurata viene impostato indirettamente. Le misurazioni indirette sono possibili quando è nota la relazione generale tra le grandezze, che permette di ricavare il risultato desiderato da grandezze già note.
Sperimentare - un metodo di ricerca, con l'aiuto del quale esiste una percezione attiva e mirata di un determinato oggetto in condizioni controllate e controllate.
Le caratteristiche principali dell'esperimento:
1) un rapporto attivo con l'oggetto fino al suo cambiamento e trasformazione;
2) riproducibilità multipla dell'oggetto in studio su richiesta del ricercatore;
3) la possibilità di rilevare tali proprietà di fenomeni che non si osservano in vivo;
4) la possibilità di considerare il fenomeno "nella sua forma pura" isolandolo da influenze esterne, o modificando le condizioni dell'esperimento;
5) la capacità di controllare il "comportamento" dell'oggetto e di verificarne i risultati.
Possiamo dire che l'esperimento è un'esperienza idealizzata. Consente di seguire il corso di un cambiamento in un fenomeno, di influenzarlo attivamente, di ricrearlo, se necessario, prima di confrontare i risultati ottenuti. Pertanto, l'esperimento è un metodo più forte ed efficace dell'osservazione o della misurazione, in cui il fenomeno in esame rimane invariato. Questa è la forma più alta di ricerca empirica.
Un esperimento viene utilizzato per creare una situazione che consenta di studiare un oggetto nella sua forma pura, o per testare ipotesi e teorie esistenti, o per formulare nuove ipotesi e idee teoriche. Ogni esperimento è sempre guidato da qualche idea teorica, concetto, ipotesi. I dati sperimentali, così come le osservazioni, sono sempre caricati in teoria, dalla sua formulazione all'interpretazione dei risultati.
Fasi dell'esperimento:
1) progettazione e costruzione (il suo scopo, tipo, mezzi, ecc.);
2) controllo;
3) interpretazione dei risultati.
Struttura dell'esperimento:
1) l'oggetto di studio;
2) creazione delle condizioni necessarie (fattori materiali di influenza sull'oggetto di studio, eliminazione di effetti indesiderati - interferenza);
3) metodologia per condurre l'esperimento;
4) l'ipotesi o la teoria da verificare.
Di norma, la sperimentazione è associata all'uso di metodi pratici più semplici: osservazioni, confronti e misurazioni. Poiché l'esperimento non viene condotto, di norma, senza osservazioni e misurazioni, deve soddisfare i loro requisiti metodologici. In particolare, come per le osservazioni e le misurazioni, un esperimento può essere considerato conclusivo se può essere riprodotto da qualsiasi altra persona in un altro luogo nello spazio e in un altro momento e dà lo stesso risultato.
Tipi di esperimento:
A seconda degli obiettivi dell'esperimento, si distinguono esperimenti di ricerca (il compito è la formazione di nuove teorie scientifiche), esperimenti di verifica (testare ipotesi e teorie esistenti), esperimenti decisivi (conferma di uno e confutazione di un'altra delle teorie concorrenti).
A seconda della natura degli oggetti, si distinguono esperimenti fisici, chimici, biologici, sociali e di altro tipo.
Esistono anche esperimenti qualitativi volti a stabilire la presenza o meno del presunto fenomeno, ed esperimenti di misurazione che rivelano la certezza quantitativa di alcune proprietà.
Metodi di ricerca teorica.
Nella fase teorica,esperimento mentale, idealizzazione, formalizzazione,metodi assiomatici, ipotetico-deduttivi, il metodo di ascesa dall'astratto al concreto, nonché metodi di analisi storica e logica.
Idealizzazione - un metodo di ricerca consistente nella costruzione mentale di un'idea su un oggetto eliminando le condizioni necessarie alla sua esistenza reale. In effetti, l'idealizzazione è una sorta di procedura di astrazione, specificata tenendo conto delle esigenze della ricerca teorica. I risultati di tale costruzione sono oggetti idealizzati.
La formazione delle idealizzazioni può avvenire in diversi modi:
Astrazione a più stadi costantemente eseguita (in questo modo si ottengono oggetti matematici: un piano, una linea retta, un punto, ecc.);
Isolamento e fissazione di una certa proprietà dell'oggetto in studio in isolamento da tutti gli altri (oggetti ideali delle scienze naturali).
Gli oggetti idealizzati sono molto più semplici degli oggetti reali, il che ti consente di applicarli metodi matematici descrizioni. Grazie all'idealizzazione, i processi sono considerati nella loro forma più pura, senza aggiunte accidentali dall'esterno, il che apre la strada alla rivelazione delle leggi attraverso le quali questi processi procedono. Un oggetto idealizzato, in contrasto con uno reale, è caratterizzato non da un infinito, ma da un tutto un certo numero proprietà e quindi il ricercatore ottiene la possibilità di un completo controllo intellettuale su di essa. Gli oggetti idealizzati modellano le relazioni più essenziali negli oggetti reali.
Poiché le disposizioni della teoria parlano delle proprietà degli oggetti ideali, e non reali, si pone il problema di verificare e accettare queste disposizioni sulla base della correlazione con il mondo reale. Pertanto, al fine di tener conto delle circostanze introdotte che incidono sulla deviazione degli indicatori inerenti alla datità empirica dalle caratteristiche di un oggetto ideale, vengono formulate le regole di concretizzazione: verifica del diritto, tenuto conto delle condizioni specifiche del suo funzionamento .
Modellazione (un metodo strettamente correlato all'idealizzazione) è un metodo per lo studio di modelli teorici, cioè analoghi (schemi, strutture, sistemi segnici) di alcuni frammenti di realtà, che sono chiamati originali. Il ricercatore, trasformando questi analoghi e gestendoli, amplia e approfondisce la conoscenza degli originali. La modellazione è un metodo di funzionamento indiretto di un oggetto, durante il quale non viene indagato direttamente l'oggetto che ci interessa, ma un sistema intermedio (naturale o artificiale), che:
È in una corrispondenza oggettiva con l'oggetto conosciuto (il modello è, prima di tutto, ciò con cui viene confrontato - è necessario che ci sia una somiglianza tra il modello e l'originale in alcune caratteristiche fisiche, o nella struttura, o in funzioni);
Nel corso della cognizione, in determinate fasi, è in grado di sostituire l'oggetto oggetto di studio in determinati casi (nel processo di ricerca, la sostituzione temporanea dell'originale con un modello e il lavoro con esso consente in molti casi non solo di rilevare, ma anche per prevederne le nuove proprietà);
Per fornire informazioni sull'oggetto di nostro interesse nel processo del suo studio.
La base logica del metodo di modellazione sono le conclusioni per analogia.
Esistere diversi tipi modellazione. Principale:
Soggetto (diretto) - modellazione, durante la quale lo studio viene svolto su un modello che riproduce alcune caratteristiche fisiche, geometriche, ecc. dell'originale. La modellazione di oggetti viene utilizzata come metodo pratico conoscenza.
Modellazione dei segni (i modelli sono diagrammi, disegni, formule, frasi in linguaggio naturale o artificiale, ecc.). Poiché le azioni con segni sono allo stesso tempo azioni con alcuni pensieri, nella misura in cui qualsiasi modellazione di segni è intrinsecamente una modellazione mentale.
Negli studi storici si distinguono i modelli di misurazione riflessiva ("come era") e quelli prognostici di simulazione ("come potrebbe essere").
esperimento mentale- un metodo di ricerca basato su una combinazione di immagini, la cui realizzazione materiale è impossibile. Questo metodo è formato sulla base dell'idealizzazione e della modellazione. Il modello risulta quindi essere un oggetto immaginario, trasformato secondo regole adatte ad una data situazione. Gli stati inaccessibili a un esperimento pratico vengono rivelati con l'aiuto della sua continuazione: un esperimento mentale.
A titolo illustrativo, possiamo prendere il modello costruito da K. Marx, che gli ha permesso di esplorare a fondo il modo di produzione capitalistico a metà del diciannovesimo secolo. La costruzione di questo modello è stata associata a una serie di ipotesi idealizzanti. In particolare, si presumeva che non vi fosse monopolio nell'economia; sono state abolite tutte le norme che impediscono lo spostamento del lavoro da un luogo o da una sfera di produzione all'altra; il lavoro in tutte le sfere della produzione è ridotto a lavoro semplice; il saggio del plusvalore è lo stesso in tutte le sfere della produzione; la composizione organica media del capitale è la stessa in tutti i rami della produzione; la domanda di ogni bene è uguale alla sua offerta; la durata della giornata lavorativa e il prezzo in denaro della forza lavoro sono costanti; l'agricoltura svolge la produzione allo stesso modo di qualsiasi altro ramo della produzione; non c'è capitale commerciale e bancario; le esportazioni e le importazioni sono equilibrate; ci sono solo due classi: capitalisti e salariati; il capitalista è costantemente alla ricerca del massimo profitto, agendo sempre in modo razionale. Il risultato fu un modello di una sorta di capitalismo “ideale”. La sperimentazione mentale con esso ha permesso di formulare le leggi della società capitalista, in particolare la più importante di esse: la legge del valore, secondo la quale la produzione e lo scambio di beni vengono effettuati sulla base dei costi socialmente necessari lavoro.
Un esperimento mentale permette di introdurre nuovi concetti nel contesto della teoria scientifica, formulando i principi fondamentali di un concetto scientifico.
Recentemente, per l'implementazione della modellazione e la conduzione di un esperimento mentale, è sempre più utilizzatoesperimento computazionale. Il principale vantaggio di un computer è che con il suo aiuto, quando si studiano sistemi molto complessi, è possibile analizzare in profondità non solo il loro presente, ma anche possibile, compresi gli stati futuri. L'essenza di un esperimento computazionale è che un esperimento viene eseguito su un determinato modello matematico di un oggetto utilizzando un computer. In base ad alcuni parametri del modello vengono calcolate le sue altre caratteristiche e su questa base si traggono conclusioni sulle proprietà dei fenomeni rappresentati dal modello matematico. Le fasi principali dell'esperimento computazionale:
1) costruzione di un modello matematico dell'oggetto in studio in determinate condizioni (di norma, è rappresentato da un sistema di equazioni di ordine superiore);
2) determinazione dell'algoritmo computazionale per la risoluzione del sistema di equazioni di base;
3) costruire un programma per l'attuazione dell'attività per un computer.
Un esperimento computazionale basato sull'esperienza accumulata nella modellazione matematica, una banca di algoritmi e software computazionali consente di risolvere in modo rapido ed efficiente problemi in quasi tutte le aree della conoscenza scientifica matematica. Il ricorso a un esperimento computazionale in alcuni casi consente di ridurre drasticamente il costo degli sviluppi scientifici e di intensificare il processo di ricerca scientifica, assicurato dalla multivarianza dei calcoli eseguiti e dalla semplicità delle modifiche per simulare determinate condizioni sperimentali.
Formalizzazione - un metodo di ricerca basato sull'esibizione di conoscenze significative in forma segnica-simbolica (linguaggio formalizzato). Quest'ultimo è creato per esprimere accuratamente i pensieri al fine di escludere la possibilità di una comprensione ambigua. Nella formalizzazione, il ragionamento sugli oggetti viene trasferito sul piano dell'operare con i segni (formule), che è associato alla costruzione di linguaggi artificiali. L'uso di simboli speciali consente di eliminare la polisemia e l'imprecisione, la figuratività delle parole del linguaggio naturale. Nel ragionamento formale, ogni simbolo è rigorosamente inequivocabile. La formalizzazione serve come base per i processi di algoritmizzazione e programmazione dei dispositivi informatici, e quindi per l'informatizzazione della conoscenza.
La cosa principale nel processo di formalizzazione è che è possibile eseguire operazioni sulle formule dei linguaggi artificiali, per ricavarne nuove formule e relazioni. Così, le operazioni con i pensieri sono sostituite da operazioni con segni e simboli (limiti del metodo).
Il metodo di formalizzazione apre opportunità per utilizzarne di più metodi complessi ricerca teorica, per esempiometodo delle ipotesi matematiche, dove alcune equazioni che rappresentano una modifica di stati precedentemente noti e verificati fungono da ipotesi. Modificando quest'ultimo, costituiscono una nuova equazione che esprime un'ipotesi che si riferisce a nuovi fenomeni.Spesso la formula matematica originale è presa in prestito da un campo di conoscenza adiacente e anche non adiacente, in essa vengono sostituiti valori di natura diversa e quindi controllano se il comportamento calcolato e reale dell'oggetto corrisponde. Naturalmente, l'applicabilità di questo metodo è limitata da quelle discipline che hanno già accumulato un arsenale matematico abbastanza ricco.
Metodo assiomatico- un metodo di costruzione di una teoria scientifica, in cui si prendono a base alcune disposizioni che non richiedono prove particolari (assiomi o postulati), da cui tutte le altre disposizioni sono derivate mediante prove logiche formali. L'insieme degli assiomi e le disposizioni da essi derivate formano una teoria costruita assiomaticamente, che include modelli di segni astratti. Tale teoria può essere utilizzata per la rappresentazione del modello non di una, ma di più classi di fenomeni, per la caratterizzazione non di una, ma di più aree tematiche. Per derivare disposizioni dagli assiomi, vengono formulate regole speciali di inferenza: le disposizioni della logica matematica. Trovare le regole per correlare gli assiomi di un sistema di conoscenza formalmente costruito con una specifica area disciplinare è chiamato interpretazione. Nelle scienze naturali moderne, esempi di teorie assiomatiche formali sono le teorie fisiche fondamentali, che comportano una serie di problemi specifici della loro interpretazione e giustificazione (soprattutto per le costruzioni teoriche della scienza non classica e post-classica).
Per la specificità dei sistemi di conoscenze teoriche costruiti assiomaticamente, i criteri intrateorici di verità rivestono particolare importanza ai fini della loro fondatezza: il requisito di coerenza e completezza della teoria e il requisito di fondamenti sufficienti per provare o confutare qualsiasi posizione formulata all'interno del quadro di una tale teoria.
Questo metodo è ampiamente utilizzato in matematica, così come in quelle scienze naturali in cui viene utilizzato il metodo di formalizzazione. (La limitazione del metodo).
Metodo ipotetico-deduttivo- un metodo di costruzione di una teoria scientifica, che si basa sulla creazione di un sistema di ipotesi interconnesse, da cui poi si deduce un sistema di ipotesi particolari mediante dispiegamento deduttivo, soggetto a verifica sperimentale. Pertanto, questo metodo si basa sulla deduzione (derivazione) di conclusioni da ipotesi e altre premesse, il cui vero significato è sconosciuto. E questo significa che la conclusione ottenuta sulla base di questo metodo avrà inevitabilmente un carattere probabilistico.
La struttura del metodo ipotetico-deduttivo:
1) avanzare un'ipotesi sulle cause e sui modelli di questi fenomeni utilizzando una varietà di tecniche logiche;
2) valutazione della validità delle ipotesi e selezione di quella più probabile dal loro insieme;
3) deduzione dall'ipotesi per via deduttiva delle conseguenze con specificazione del suo contenuto;
4) verifica sperimentale delle conseguenze derivate dall'ipotesi. Qui l'ipotesi o riceve conferma sperimentale o viene confutata. Tuttavia, la conferma delle singole conseguenze non garantisce la sua verità o falsità nel suo insieme. L'ipotesi che si basa meglio sui risultati del test va in teoria.
Metodo di ascesa dall'astratto al concreto- un metodo che trova inizialmente l'astrazione originaria (la principale connessione (relazione) dell'oggetto in studio), e poi, passo dopo passo, attraverso fasi successive di approfondimento ed ampliamento della conoscenza, viene tracciato come si trasforma in varie condizioni, si aprono nuove connessioni, si stabiliscono le loro interazioni e, così, l'essenza dell'oggetto in studio viene mostrata nella sua interezza.
Metodo di analisi storica e logica. Il metodo storico richiede una descrizione della storia effettiva dell'oggetto in tutta la diversità della sua esistenza. Metodo Booleano- si tratta di una ricostruzione mentale della storia dell'oggetto, sgomberata da tutto ciò che è accidentale, insignificante e incentrata sull'identificazione dell'essenza. Unità di analisi logica e storica.
Procedure logiche per sostanziare la conoscenza scientifica
Tutti i metodi specifici, sia empirici che teorici, sono accompagnati da procedure logiche. L'efficacia dei metodi empirici e teorici dipende direttamente dalla corretta costruzione del corrispondente ragionamento scientifico dal punto di vista logico.
Fondamento logico - una procedura logica associata alla valutazione di un determinato prodotto della conoscenza come componente di un sistema di conoscenze scientifiche in termini di conformità con le funzioni, i fini e gli obiettivi di tale sistema.
I principali tipi di giustificazione:
Prova - una procedura logica in cui un'espressione con valore incognito è derivata da affermazioni la cui verità è già stata stabilita. Ciò consente di eliminare ogni dubbio e riconoscere la verità di questa espressione.
Struttura della prova:
Tesi (espressione, verità, che si stabilisce);
Argomenti, argomentazioni (dichiarazioni con cui si stabilisce la verità della tesi);
Presupposti aggiuntivi (espressioni di natura ausiliaria, introdotte nella struttura della dimostrazione ed eliminate nel passaggio al risultato finale);
Dimostrazione (forma logica di questa procedura).
Un tipico esempio di dimostrazione è qualsiasi ragionamento matematico che porti all'adozione di qualche nuovo teorema. In esso, questo teorema funge da tesi, teoremi e assiomi precedentemente provati come argomenti e la dimostrazione è una forma di deduzione.
Tipi di prove:
Diretto (la tesi segue direttamente dalle argomentazioni);
Indiretto (la tesi è dimostrata indirettamente):
Apagogico (prova per contraddizione - accertamento della falsità dell'antitesi: si presume che l'antitesi sia vera, e ne derivano conseguenze, se almeno una delle conseguenze ottenute è in conflitto con i giudizi veri disponibili, allora la conseguenza è riconosciuta come falso, e dopo di esso l'antitesi stessa - si riconosce la verità della tesi);
Dividere (la verità della tesi si stabilisce escludendo tutte le alternative contrarie).
La prova è strettamente correlata a una procedura logica come la confutazione.
Confutazione - un procedimento logico che stabilisca la falsità della tesi di un enunciato logico.
Tipi di confutazione:
Prova dell'antitesi (un'affermazione è provata in modo indipendente che contraddice la tesi confutata);
Stabilire la falsità delle conseguenze derivanti dalla tesi (si fa un presupposto sulla verità della tesi confutata e ne derivano le conseguenze; se almeno una conseguenza non corrisponde alla realtà, cioè è falsa, allora l'assunzione sarà falsa - la tesi confutata).
Pertanto, con l'aiuto di una confutazione, si ottiene un risultato negativo. Ma ha anche un effetto positivo: il cerchio della ricerca della vera posizione si restringe.
Conferma - giustificazione parziale della veridicità di alcune affermazioni. Svolge un ruolo speciale in presenza di ipotesi e in assenza di argomenti sufficienti per la loro accettazione. Se la prova ottiene una completa sustanziazione della verità di qualche affermazione, allora la conferma ottiene una giustificazione parziale.
La proposizione B conferma l'ipotesi A se e solo se la proposizione B è una vera conseguenza di A. Questo criterio è vero in quei casi in cui il confermato e il confermante appartengono allo stesso livello di conoscenza. Pertanto, è affidabile in matematica o nella verifica di generalizzazioni elementari riducibili ai risultati delle osservazioni. Tuttavia, ci sono riserve significative, se il confermato e il confermante sono a livelli conoscitivi diversi - la conferma di previsioni teoriche da parte di dati empirici. Questi ultimi si formano sotto l'influenza di vari fattori, anche casuali. Solo la loro contabilizzazione e riduzione a zero può portare conferma.
Se l'ipotesi è confermata dai fatti, ciò non significa affatto che debba essere accettata immediatamente e incondizionatamente. Secondo le regole della logica, la verità di conseguenza B non significa la verità della ragione A. Ogni nuova conseguenza rende l'ipotesi sempre più probabile, ma per diventare un elemento del corrispondente sistema di conoscenza teorica, deve andare attraverso un lungo percorso di test per l'applicabilità in questo sistema e la capacità di soddisfare la sua definita la natura della funzione.
Pertanto, nel confermare la tesi:
Le sue conseguenze servono come argomenti;
La dimostrazione non è di natura necessaria (deduttiva).
Obiezione è la procedura logica opposta alla conferma. Ha lo scopo di indebolire alcune tesi (ipotesi).
Tipi di obiezioni:
Diretto (considerazione diretta delle carenze della tesi; di norma, dando una vera antitesi, o utilizzando un'antitesi non sufficientemente motivata e con un certo grado di probabilità);
Indiretto (diretto non contro la tesi stessa, ma contro le argomentazioni addotte nella sua giustificazione o la forma logica del suo collegamento con le argomentazioni (dimostrazioni).
Spiegazione - un procedimento logico che riveli le caratteristiche essenziali, le relazioni causali o le relazioni funzionali di qualche oggetto.
Tipi di spiegazione:
1) Obiettivo (dipende dalla natura dell'oggetto):
Essenziale (mirato a rivelare le caratteristiche essenziali di qualche oggetto). Gli argomenti sono teorie e leggi scientifiche;
Causale (le disposizioni sulle cause di certi fenomeni fungono da argomenti;
Funzionale (viene considerato il ruolo svolto da qualche elemento nel sistema)
2) Soggettivo (dipende dalla direzione del soggetto, dal contesto storico - lo stesso fatto può ricevere una spiegazione diversa a seconda delle condizioni specifiche e della direzione del soggetto). È usato nella scienza non classica e post-classica: il requisito di fissare chiaramente le caratteristiche dei mezzi di osservazione, ecc. Non solo la rappresentazione, ma anche la selezione dei fatti reca tracce di attività soggettiva.
Oggettivismo e soggettivismo.
La differenza tra spiegazione e dimostrazione: la prova stabilisce la verità della tesi; nello spiegare, una certa tesi è già stata dimostrata (a seconda della direzione, lo stesso sillogismo può essere sia una prova che una spiegazione).
Interpretazione - una procedura logica che attribuisce un significato o significato significativo ai simboli o alle formule di un sistema formale. Di conseguenza, il sistema formale si trasforma in un linguaggio che descrive una particolare area disciplinare. Questa stessa area tematica, così come i significati attribuiti a formule e segni, è anche chiamata interpretazione. Una teoria formale non è motivata finché non ha un'interpretazione. Può anche essere dotato di un nuovo significato e di una nuova interpretazione di una teoria del contenuto precedentemente sviluppata.
Un classico esempio di interpretazione è trovare un frammento di realtà, le cui proprietà sono state descritte dalla geometria di Lobachevsky (superfici di curvatura negativa). L'interpretazione è usata principalmente nelle scienze più astratte (logica, matematica).
Metodi di sistematizzazione delle conoscenze scientifiche
Classificazione - un metodo per dividere l'insieme degli oggetti oggetto di studio in sottoinsiemi basati su somiglianze e differenze rigorosamente fissate. La classificazione è un modo per organizzare una serie empirica di informazioni. Lo scopo della classificazione è determinare il posto nel sistema di qualsiasi oggetto, e quindi stabilire la presenza di alcuni collegamenti tra gli oggetti. Il soggetto, che possiede il criterio di classificazione, ha l'opportunità di navigare nella varietà di concetti e (e) oggetti. La classificazione riflette sempre la disponibilità questo momento livello di conoscenza nel tempo, riassume. D'altra parte, la classificazione consente di rilevare le lacune nelle conoscenze esistenti e fungere da base per procedure diagnostiche e prognostiche. Nella cosiddetta scienza descrittiva, era il risultato (obiettivo) della conoscenza (sistematica in biologia, tentativi di classificare le scienze per vari motivi, ecc.), e l'ulteriore sviluppo veniva presentato come il suo miglioramento o la proposta di una nuova classificazione.
Distinguere tra classificazioni naturali e artificiali, a seconda del significato della caratteristica che ne è alla base. Le classificazioni naturali implicano la ricerca di un criterio significativo per distinguere; quelli artificiali possono in linea di principio essere costruiti sulla base di qualsiasi caratteristica. variante Isku C Le classificazioni principali sono varie classificazioni ausiliarie del tipo indici alfabetici eccetera. Inoltre, esistono classificazioni teoriche (in particolare, genetiche) ed empiriche (all'interno di queste ultime, la definizione di un criterio di classificazione è ampiamente problematica).
Tipologia - un metodo per dividere un certo insieme di oggetti in studio in gruppi ordinati e sistematizzati con determinate proprietà utilizzando un modello o tipo idealizzato (ideale o costruttivo). La tipologia si basa sul concetto di insiemi fuzzy, cioè insiemi che non hanno confini chiari, quando il passaggio dall'appartenenza all'insieme alla non appartenenza all'insieme avviene in modo graduale, non brusco, cioè elementi di una determinata area disciplinare le appartengono solo con un certo grado di appartenenza.
La tipologizzazione viene effettuata secondo un criterio (criteri) scelto e concettualmente motivato, oppure secondo una base (grounds) empiricamente scoperta e teoricamente interpretata, che consente di distinguere rispettivamente tra tipologie teoriche ed empiriche. Si presume che le differenze tra le unità che compongono il tipo nella relazione di interesse per il ricercatore siano di natura casuale (dovuta a fattori che non possono essere presi in considerazione) e siano insignificanti rispetto a differenze simili tra oggetti assegnati a tipi diversi .
Il risultato della tipologia è una tipologia sostanziata al suo interno. Quest'ultima può essere considerata in alcune scienze come una forma di rappresentazione della conoscenza, o come un precursore della costruzione di una teoria di qualsiasi area disciplinare, o come una conclusiva quando è impossibile (o impreparato per la comunità scientifica) formulare una teoria adeguata al campo di studio.
Relazione e differenza tra classificazione e tipologia:
La classificazione consiste nel trovare un posto chiaro per ogni elemento (oggetto) in un gruppo (classe) o serie (sequenza), con confini chiari tra classi o serie (un singolo elemento non può appartenere contemporaneamente a classi diverse (serie) o non essere incluso in nessuno o nessuno di essi). Inoltre, si ritiene che il criterio di classificazione possa essere casuale e il criterio della tipologia sia sempre essenziale. La tipologia individua insiemi omogenei, ciascuno dei quali è una modificazione della stessa qualità (caratteristica essenziale, "radice", più precisamente "idea" di questo insieme). Naturalmente, in contrasto con la caratteristica della classificazione, l'"idea" della tipologia è tutt'altro che visiva, manifestata all'esterno e rilevabile. La classificazione è più debole della tipologia relativa al contenuto
Allo stesso tempo, alcune classificazioni, specie quelle empiriche, possono essere interpretate come tipologie preliminari (primarie), o come una procedura transitoria per ordinare elementi (oggetti) sulla via della tipologia.
Il linguaggio della scienza. Specificità della terminologia scientifica
Sia empiricamente che studio teorico un ruolo speciale è svolto dal linguaggio della scienza, che rivela una serie di caratteristiche rispetto al linguaggio della conoscenza quotidiana. Ci sono diversi motivi per cui il linguaggio ordinario non è sufficiente per descrivere gli oggetti della ricerca scientifica:
Il suo vocabolario non consente di fissare informazioni su oggetti che vanno oltre la sfera dell'attività pratica diretta di una persona e della sua conoscenza quotidiana;
I concetti del linguaggio quotidiano sono vaghi e ambigui;
Le costruzioni grammaticali del linguaggio ordinario si formano spontaneamente, contengono strati storici, sono spesso ingombranti e non consentono di esprimere chiaramente la struttura del pensiero, la logica dell'attività mentale.
Per queste caratteristiche, la conoscenza scientifica implica lo sviluppo e l'uso di linguaggi artificiali specializzati. Il loro numero è in costante aumento con lo sviluppo della scienza. Il primo esempio di creazione di special strumenti linguistici serve come introduzione di Aristotele di designazioni simboliche nella logica.
La necessità di un linguaggio accurato e adeguato ha portato nel corso dello sviluppo della scienza alla creazione di una terminologia speciale. Insieme a questo, la necessità di migliorare i mezzi linguistici nella conoscenza scientifica ha portato all'emergere di linguaggi della scienza formalizzati.
Caratteristiche del linguaggio della scienza:
Chiarezza e non ambiguità dei concetti;
La presenza di regole chiare che determinano il significato dei termini originari;
Mancanza di strati culturali e storici.
Il linguaggio della scienza distingue tra linguaggio degli oggetti e metalinguaggio.
Linguaggio oggetto (soggetto).- una lingua le cui espressioni si riferiscono a una determinata area di oggetti, alle loro proprietà e relazioni. Ad esempio, il linguaggio della meccanica descrive le proprietà del moto meccanico dei corpi materiali e l'interazione tra di essi; il linguaggio dell'aritmetica parla dei numeri, delle loro proprietà, delle operazioni sui numeri; il linguaggio della chimica sostanze chimiche e reazioni, ecc. In generale, qualsiasi lingua viene solitamente utilizzata principalmente per parlare di alcuni oggetti extralinguistici e, in questo senso, ogni lingua è un linguaggio oggettuale.
Metalinguaggio è una lingua usata per esprimere giudizi su un'altra lingua, la lingua-oggetto. Con l'aiuto di M., studiano la struttura delle espressioni del linguaggio-oggetto, le sue proprietà espressive, la sua relazione con altre lingue, ecc. Esempio: nel libro di testo in inglese per i russi, il russo è un metalinguaggio e l'inglese è un linguaggio oggetto.Insieme a questo, la necessità di migliorare i mezzi linguistici nella conoscenza scientifica ha portato all'emergere di linguaggi della scienza formalizzati.
Naturalmente, nel linguaggio naturale, linguaggio degli oggetti e metalinguaggio sono combinati: in questo linguaggio si parla sia di oggetti che di espressioni del linguaggio stesso. Tale linguaggio è chiamato semanticamente chiuso. L'intuizione linguistica di solito ci aiuta a evitare i paradossi che derivano dalla chiusura semantica del linguaggio naturale. Ma quando si costruiscono linguaggi formalizzati, si fa attenzione a garantire che il linguaggio oggetto sia chiaramente separato dal metalinguaggio.
Terminologia scientifica- un insieme di parole con un significato unico e preciso nell'ambito di una determinata disciplina scientifica.
La base della terminologia scientifica è scientifica definizioni.
Ci sono due significati del termine "definizione":
1) definizione: un'operazione che consente di selezionare un determinato oggetto tra altri oggetti, distinguendolo in modo inequivocabile da essi; ciò si ottiene indicando una caratteristica inerente a questo, e solo questo, oggetto (una caratteristica distintiva) (ad esempio, per selezionare un quadrato dalla classe dei rettangoli, si punta a tale caratteristica che è inerente ai quadrati e non inerente in altri rettangoli, come l'uguaglianza dei lati);
2) definizione - operazione logica che permette di svelare, chiarire o formare il significato di alcune espressioni linguistiche utilizzando altre espressioni linguistiche (ad esempio una decima è un'area pari a 1,09 ettari - poiché una persona comprende il significato dell'espressione "1,09 ettari", poiché diventa chiaro il significato della parola "decima".
Si dice reale una definizione che attribuisce una caratteristica distintiva a qualche oggetto. Si chiama nominale una definizione che rivela, chiarisce o forma il significato di alcune espressioni linguistiche con l'aiuto di altre. Questi due concetti non si escludono a vicenda. La definizione di un'espressione può essere allo stesso tempo la definizione dell'oggetto corrispondente.
Valutato:
Esplicito (classico e genetico o induttivo);
Contestuale.
Nella scienza, le definizioni giocano un ruolo essenziale. Dando una definizione, abbiamo l'opportunità di risolvere una serie di compiti cognitivi legati, in primo luogo, alle procedure di denominazione e riconoscimento. Queste attività includono:
Stabilire il significato di un'espressione linguistica non familiare utilizzando espressioni familiari e già significative (registrazione delle definizioni);
Chiarimento dei termini e, nel contempo, sviluppo di una caratteristica univoca della materia in esame (definizioni chiarificatrici);
Introduzione alla circolazione scientifica di nuovi termini o concetti (definizioni postulanti).
In secondo luogo, le definizioni consentono di costruire procedure di inferenza. Grazie alle definizioni, le parole acquisiscono accuratezza, chiarezza e non ambiguità.
Tuttavia, l'importanza delle definizioni non dovrebbe essere esagerata. Va tenuto presente che non rispecchiano l'intero contenuto dell'argomento in questione. Lo studio vero e proprio di una teoria scientifica non si riduce alla padronanza della somma delle definizioni che essa contiene. Domanda sull'accuratezza dei termini.
1. Il concetto di metodologia e metodi della ricerca scientifica.
2. Metodologia della ricerca teorica.
3. Fondamenti della metodologia di ricerca a livello empirico.
4. Tecniche cognitive e forme di ricerca scientifica.
1. Il concetto di metodologia e metodi della ricerca scientifica
Il processo cognitivo, come base di ogni ricerca scientifica, è complesso e richiede un approccio concettuale basato su una metodologia specifica.
La metodologia deriva dalle parole greche menthoges - conoscenza e logos - insegnamento. Quindi, questi sono insegnamenti sui metodi di ricerca, sulle regole del pensiero quando si crea una teoria della scienza. Il concetto di metodologia è complesso ed è spiegato in modo diverso nelle diverse fonti letterarie. In molte fonti letterarie straniere i concetti di metodologia e tecniche di ricerca non sono differenziati. Gli scienziati domestici considerano la metodologia come una dottrina dei metodi scientifici di cognizione e come un sistema di principi scientifici sulla base dei quali si basa la ricerca e viene effettuata la scelta dei mezzi cognitivi, dei metodi e dei metodi di ricerca. La più appropriata è la definizione di metodologia come teoria delle tecniche di ricerca, la creazione di concetti scientifici come sistema di conoscenze sulla teoria della scienza o un sistema di tecniche di ricerca. Secondo la definizione degli autori del libro di testo "Organizzazione e metodi delle attività di ricerca" V. Sheiko e N. Kushnarenko, la metodologia è una dichiarazione concettuale dello scopo, del contenuto, delle tecniche di ricerca che forniscono le informazioni più obiettive, accurate e sistematizzate su processi e fenomeni. Quindi, in questa definizione, vengono formulate con precisione le principali funzioni della metodologia, che si riducono a quanto segue:
Determinazione di metodi per ottenere conoscenze scientifiche che riflettano processi e fenomeni dinamici;
Determinazione di un percorso specifico in cui l'obiettivo della ricerca viene raggiunto;
Fornire informazioni complete sul processo o fenomeno oggetto di studio;
Introduzione di nuove informazioni alla fondazione della teoria della scienza;
Affinamento, arricchimento, sistematizzazione di termini e concetti nella scienza;
Creazione di un sistema di informazione scientifica, basato su fatti oggettivi, e di uno strumento logico e analitico per la conoscenza scientifica.
Metodologia - è la scienza della struttura, dell'organizzazione logica, dei mezzi e dei metodi di attività in generale. Di solito, la metodologia è intesa principalmente come la metodologia della conoscenza scientifica, che è un insieme di disposizioni teoriche sui principi di costruzione, le forme e i metodi dell'attività scientifica e cognitiva.
La metodologia può anche essere vista come un certo sistema di idee fondamentali.
L'insieme dei metodi utilizzati per condurre la ricerca scientifica entro i confini di una particolare scienza costituisce la sua metodologia. Questo concetto ha due significati: in primo luogo, la metodologia è un insieme di mezzi, metodi, tecniche utilizzati in una particolare scienza e, in secondo luogo, è un campo di conoscenza che studia i mezzi, i principi dell'organizzazione cognitiva e la trasformazione pratica dell'attività umana.
Quindi, la metodologia è una dottrina filosofica dei metodi di cognizione e della trasformazione della realtà, l'uso dei principi della visione del mondo nel processo di cognizione e pratica.
Lo sviluppo della metodologia è uno degli aspetti dello sviluppo della scienza nel suo insieme. Ogni scoperta scientifica ha un contenuto non solo sostanziale, ma anche metodologico, poiché è associata a un ripensamento critico dell'esistente apparato di concetti, prerequisiti e approcci all'interpretazione dell'oggetto, fenomeno che si sta studiando.
La metodologia è un insieme di regole per definire concetti, derivare alcune conoscenze da altre, metodi, tecniche, operazioni della ricerca scientifica in tutti i campi della scienza e in tutte le fasi della ricerca.
Al giorno d'oggi, la metodologia agisce come una disciplina scientifica separata che studia la tecnologia per condurre la ricerca scientifica; descrizione e analisi delle fasi della ricerca e di una serie di altri problemi.
La metodologia è la dottrina di un sistema di principi scientifici e metodi di attività di ricerca. Include principi scientifici fondamentali e generali che servono come base, in particolare principi scientifici che sono alla base della teoria di una particolare disciplina o campo scientifico e di un sistema di metodi e tecniche specifici utilizzati per risolvere problemi di ricerca speciali.
L'obiettivo principale della metodologia della scienza è lo studio e l'analisi di metodi, mezzi, tecniche, con l'aiuto dei quali si ottengono nuove conoscenze nella scienza, sia a livello empirico che teorico della conoscenza. La metodologia è uno schema, un piano per risolvere i compiti della ricerca scientifica.
La metodologia della ricerca scientifica considera le caratteristiche e le caratteristiche più significative dei metodi di ricerca, le rivela per la generalità e la profondità dell'analisi. Ad esempio, studiando modi specifici di condurre un esperimento, osservazioni, misurazioni, la metodologia della scienza mette in evidenza quelle caratteristiche che sono inerenti a qualsiasi esperimento.
Il più importante per la metodologia della scienza è la definizione del problema, la costruzione del tema della ricerca e della teoria scientifica, la verifica della verità dei risultati.
La comprensione dei metodi della conoscenza scientifica, lo sviluppo della sua metodologia sono stati effettuati da eminenti scienziati sia del passato che del presente: Aristotele, F. Bacon, G. Galileo, I. Newton, G. Leibniz, M. Lomonosov, C. Darwin, D. Mendeleev, I. Pavlov, A. Einstein, N. Bor, Y. Drogobych e altri.
Durante il periodo della cultura antica apparvero i primi germogli della metodologia per ottenere nuove conoscenze. Pertanto, gli antichi greci riconoscevano nelle discussioni il modo più conveniente per scoprire nuove verità, a seguito delle quali si rivelava una contraddizione sull'argomento di discussione, un'incoerenza di interpretazioni che consentiva di difendere ipotesi inaffidabili e improbabili.
La formazione delle idee principali della metodologia della scienza iniziò nel Rinascimento, che fu in gran parte facilitata dai successi nelle scienze naturali e dall'inizio della demarcazione della filosofia e delle scienze speciali, sia fondamentali che applicate. A questo proposito, metodi di ricerca che sono parte integrale processo cognitivo e svolgono un ruolo importante nella scienza.
Nella struttura della scienza, tutte le discipline scientifiche che costituiscono il sistema delle scienze sono divise in tre gruppi principali: scienze naturali, umanitarie e tecniche.
Discipline scientifiche diverse differiscono tra loro non solo per la natura e il contenuto dell'oggetto di studio, ma anche per metodi scientifici specifici, cosiddetti specifici. Nella scienza, i risultati finali dello studio nel suo insieme dipendono spesso dalla categoria, dai metodi di ricerca e dalla generalizzazione.
La complessità, la versatilità e l'interdisciplinarietà di qualsiasi problema scientifico richiedono una certa metodologia di ricerca. Una metodologia è uno studio delle peculiarità dell'applicazione di un particolare metodo o sistema di metodi. La metodologia è un insieme sistemico di tecniche di ricerca, è un sistema di regole per l'utilizzo di metodi, tecniche e tecniche di ricerca. Se questo insieme è strettamente sequenziale dall'inizio dello studio alla ricezione dei risultati, allora questo è chiamato algoritmo. La scelta di metodi di ricerca specifici è dettata dalla natura del materiale, dalle condizioni e dallo scopo di un particolare studio. I metodi sono un sistema ben organizzato in cui il loro posto è determinato in base a una fase specifica della ricerca, all'uso di tecniche e operazioni con materiale teorico e pratico in una certa sequenza.
La creazione di metodologia scientifica e metodologia di ricerca è una grande vittoria per la mente umana.
La dottrina del sistema di queste tecniche, metodi e regole è chiamata metodologia. Tuttavia, il concetto di "metodologia" in letteratura è usato in due significati:
- 1) un insieme di metodi utilizzati in qualsiasi campo di attività (scienza, politica, ecc.);
- 2) la dottrina del metodo scientifico della cognizione.
Ogni scienza ha la sua metodologia. Secondo altri autori, la metodologia è la dottrina dei metodi utilizzati nelle scienze giuridiche per studiare la loro materia. In definitiva, la metodologia della ricerca scientifica è intesa come la dottrina dei metodi (metodo) della cognizione, cioè sul sistema di principi, regole, metodi e tecniche destinati alla soluzione di successo dei compiti cognitivi.
Esistono i seguenti livelli di metodologia:
- 1. Metodologia generale, che è universale in relazione a tutte le scienze e il cui contenuto include metodi di cognizione filosofici e scientifici generali.
- 2. Metodologia privata della ricerca scientifica per un gruppo di scienze correlate, che è formato da metodi cognitivi filosofici, scientifici generali e privati.
- 3. Metodologia della ricerca scientifica di una scienza specifica, il cui contenuto comprende metodi cognitivi filosofici, scientifici generali, privati e speciali.
La metodologia - come dottrina dei metodi e delle tecniche di ricerca - considera le caratteristiche essenziali di metodi specifici di cognizione, che costituiscono l'indirizzo generale della ricerca. Questi metodi includono tecniche e metodi delle fasi empiriche e teoriche dello studio.
Il significato della metodologia della conoscenza scientifica risiede nel fatto che consente di sistematizzare l'intero volume delle conoscenze scientifiche e creare le condizioni per lo sviluppo di ulteriori ed efficaci aree di ricerca. Il compito principale della metodologia della conoscenza scientifica è la sintesi delle conoscenze scientifiche accumulate, che consente di utilizzare i risultati dello sviluppo della scienza per scopi pratici. La metodologia studia i metodi, i mezzi e le tecniche con cui vengono acquisiti, definiti e costruiti vari sistemi di conoscenza.
L'apparato metodologico comprende:
- - principi di organizzazione e conduzione della ricerca scientifica;
- - metodi di ricerca scientifica e modalità per determinarne la strategia;
- - apparato scientifico: le basi concettuali e categoriali della ricerca scientifica (rilevanza, novità scientifica, valore euristico, significato teorico e pratico, problemi, oggetto, soggetto, ipotesi, obiettivo e compito).
Tutte le componenti della ricerca scientifica insieme servono come base dell'apparato metodologico, pertanto la ricerca scientifica è intesa come conoscenza mirata, i cui risultati sono presentati sotto forma di un sistema di concetti, leggi, teorie.
Principi di base della metodologia della conoscenza:
- - il principio di unità di teoria e pratica, che sono pratiche interdipendenti - il criterio di verità di una posizione teorica. Una teoria che non si basa sulla pratica si rivela speculativa e infruttuosa. La teoria è progettata per illuminare il percorso verso la pratica. La pratica che non è guidata dalla teoria scientifica soffre di spontaneità, mancanza di un'adeguata determinazione e inefficienza;
- - il principio di oggettività, che richiede di tener conto di tutti i fattori che caratterizzano un determinato fenomeno.L'arte del ricercatore è trovare modi e mezzi per penetrare l'essenza del fenomeno senza introdurre nulla di esterno, di soggettivo;
- - il principio di specificità, che indica gli aspetti e gli schemi essenziali dei processi oggettivi e gli approcci specifici alla loro valutazione;
- - il principio di sviluppo, che consiste nella formazione della conoscenza scientifica con l'esibizione di differenze, cambiamenti quantitativi e qualitativi nell'oggetto della conoscenza;
- - il principio di regolarità, che necessita della condizionalità dei fenomeni, tenendo conto delle relazioni e delle connessioni tra loro.
- - il principio di coerenza, ovvero un approccio sistematico agli oggetti oggetto di studio. Si tratta di considerare l'oggetto di studio come un sistema: identificare un certo insieme dei suoi elementi (è impossibile individuarli e tenerne conto tutti, e questo non è necessario), stabilire una classificazione e snellire i collegamenti tra questi elementi , individuando quelli che formano il sistema dall'insieme dei collegamenti, ovvero fornendo una connessione di diversi elementi nel sistema.
- - il principio dello studio globale dei processi e dei fenomeni. Ogni fenomeno è connesso da molti fili con altri fenomeni, e la sua considerazione isolata e unilaterale porta inevitabilmente a una conclusione distorta ed errata. Per esempio, processo educativo in un ateneo è complesso, dinamico e indissolubilmente legato a molti fattori, questo approccio permette di modellare i fenomeni studiati e studiarli in uno stato di sviluppo e in diverse condizioni. Consente di effettuare uno studio multilivello e sfaccettato di un particolare processo, durante il quale vengono costruiti non uno, ma una serie di modelli che riflettono questo fenomeno a diversi livelli e sezioni. Allo stesso tempo, è possibile sintetizzare questi modelli in un nuovo modello olistico generalizzante e, in definitiva, in una teoria olistica che rivela l'essenza del problema in esame. Il principio metodologico di completezza implica un approccio integrato allo studio dei processi e dei fenomeni pedagogici.Uno dei requisiti più importanti di un approccio integrato è stabilire tutte le relazioni del fenomeno in esame, tenere conto di tutte le influenze esterne che lo influenzano, ed eliminare tutti i fattori casuali che distorcono il quadro del problema in esame. Un altro requisito essenziale è l'uso di vari metodi nelle loro varie combinazioni nel corso della ricerca. L'esperienza mostra che è impossibile investigare con successo questo o quel problema con l'aiuto di un metodo universale.
- - il principio di unità di storico e logico. La logica di cognizione di un oggetto, di un fenomeno riproduce la logica del suo sviluppo, cioè la sua storia. La storia dello sviluppo della personalità, ad esempio, serve come una sorta di chiave per comprendere una particolare personalità, prendere decisioni pratiche sulla sua educazione e educazione. Nella storia dello sviluppo di una personalità, si riflette la sua essenza, poiché una persona è solo una persona nella misura in cui ha la propria storia, percorso di vita, biografia.
Esistono diversi livelli di analisi metodologica, in particolare:
- - livello dinamico: interpretazione ideologica dei risultati della scienza, analisi forme generali e metodi del pensiero scientifico, il suo approccio categorico;
- - livello statico; principi, approcci, forme di ricerca di carattere scientifico generale;
- - livello analitico-sintetico, ovvero una specifica metodologia scientifica come insieme di metodi e principi di ricerca che vengono utilizzati in un particolare campo della scienza;
- - livello disciplinare, ovvero metodologia disciplinare come insieme di metodi e principi di ricerca utilizzati nell'una o nell'altra disciplina scientifica in un particolare campo della scienza o all'intersezione delle scienze, in cui la disciplina scientifica stessa è la forma principale di organizzazione conoscenza scientifica;
- - livello interdisciplinare - la metodologia della ricerca complessa interdisciplinare, che, secondo la logica della ricerca scientifica, è la sfera di interazione tra diverse scienze, quando l'acquisizione di conoscenze sull'oggetto della ricerca è possibile solo nell'interazione di diversi sottosistemi, tenendo conto rendere conto di conoscenze complesse sull'argomento.
AGENZIA FEDERALE PER L'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ REGIONALE DELLO STATO DI MOSCA
Krivshenko LP,
Weindorf-Sysoeva ME, Yurkina LV
METODOLOGIA E METODI DELLA RICERCA SCIENTIFICA
MOSCA 2007
Metodologia e metodi della ricerca scientifica
Esercitazione
Revisore: Ph.D., prof. Lyamzin MA
annotazione
Il manuale racconta la metodologia ei metodi di organizzazione della ricerca scientifica per risolvere i problemi di miglioramento dell'apprendimento degli scolari e degli studenti dell'istruzione professionale primaria e secondaria. I metodi di ricerca, gli esperimenti, il più delle volte, tra un pubblico impreparato sono associati alle scienze tecniche e naturali, e in queste aree esistono infatti teoriche e linee guida. Questo manuale svela le specificità delle attività sperimentali in ambito umanitario, disegnando Attenzione speciale sulla psicologia e la pedagogia - come il principale toolkit dell'insegnante - il leader dell'esperimento. L'appendice fornisce metodi per studiare la personalità. Il manuale può interessare sia gli insegnanti che gli studenti e i genitori.
Argomento 1. La scienza come sistema di conoscenza della realtà. 4
Argomento 2. Il concetto di ricerca scientifica 10
Tema 3. Metodologia della ricerca scientifica 25
Tema 4. Caratteristiche della ricerca scientifica in psicologia e pedagogia 38
Tema 5. La psicologia nel sistema del sapere scientifico 53
Tema 6. Metodi di ricerca in psicologia 59
Tema 7. La pedagogia nel sistema del sapere scientifico 68
Argomento 8. Metodi di ricerca in pedagogia 75
Argomento 1. La scienza come sistema di conoscenza della realtà.
Principi scientifici
Formazione della conoscenza scientifica
Il sistema della conoscenza scientifica
La scienza come istituzione sociale
Per dimostrare abilmente qualcosa, una mente non è sufficiente.
F. Chesterfield
Sin dai tempi antichi, l'umanità ha cercato di identificare i modelli di funzionamento della realtà circostante e, sulla base di essi, di riprodurre l'immagine del mondo. Le esigenze della società dettavano l'acquisizione di nuove conoscenze e il loro utilizzo per correggere la realtà. Per soddisfare queste esigenze, le idee sul mondo dovevano soddisfare diversi requisiti. : obiettività, generalità, affidabilità e capacità di tradurre le conoscenze. Durante lo sviluppo della civiltà, si sono formate istituzioni sociali che hanno contribuito alla ricezione e alla trasmissione di idee sul mondo, ma non sono state immediatamente realizzate. livello scientifico. IN varie epoche istituzioni religiose, scuole filosofiche e mediche fungevano da istituzioni sociali per la produzione, conservazione e trasmissione della conoscenza. Contemporaneamente a loro esisteva un sistema di conoscenza prescientifica e quotidiana, all'interno del quale iniziarono ad emergere vari sistemi di conoscenza scientifica del mondo.
La prima scienza, nell'antichità, era la filosofia, tuttavia, la sua comprensione allora era significativamente diversa da quella moderna: la filosofia era considerata una saggezza globale che univa tutta la conoscenza del mondo conosciuta in un'era particolare. Poi, con l'espansione della conoscenza, dalla filosofia iniziarono gradualmente ad emergere sistemi scientifici separati.
Nei secoli ХУ11-ХУ111. iniziò la formazione della scienza come istituzione sociale, specificamente progettata per ottenere idee affidabili e affidabili sul mondo. Durante questo periodo furono create università, accademie nazionali, nonché periodici scientifici, che assicuravano l'apertura della conoscenza scientifica, in contrasto con la caratteristica occulta delle epoche precedenti.
Dove ogni scienza ha avuto inizio - con il fatto che qualche saggio ha visto un problema per la ricerca e la conoscenza. Il problema è tradizionalmente considerato uno scontro di conoscenza e ignoranza. Se parliamo dello scontro tra conoscenza personale e ignoranza, questo è un problema educativo, cioè un problema per un individuo o un gruppo di persone, ma non per l'umanità nel suo insieme. E se la conoscenza generale si scontra con l'ignoranza generale, allora possiamo parlarne
problema scientifico. Lo schema 1 mostra il livello del problema.
Tuttavia, la stessa selezione di un'area problematica dalla massa della conoscenza filosofica non parla ancora dell'emergere della scienza. Se i ricercatori trasformano un certo livello di fenomeni in un argomento di conoscenza scientifica, inclusa una descrizione di fatti e la loro possibile spiegazione, ciò non conferisce ancora lo status di scienza. Ma cosa gli dà? Nella scienza non c'è posto per la conoscenza soggettiva, la conoscenza quotidiana e non solo. È noto che il mestiere, sebbene l'apprendimento richieda duro lavoro, tempo, studio e talvolta talento, non è una scienza, in quanto è un'abilità senza basi teoriche. Ma anche una religione che ha schemi teorici non è una scienza, dal momento che il suo ragionamento non è mai stato verificato dalla pratica, tanto meno da essa confermato. Cosa comprende la ricerca scientifica? Per quanto strano possa sembrare, la scienza inizia nella fase descrittiva, ma in quella fase non è ancora una scienza. In questa fase, i fatti vengono descritti, quindi sistematizzati e spiegati. Su questa base sorge una base teorica: un sistema di conoscenza affidabile della realtà (è qui che appare la verifica mediante la pratica). La base teorica sarà imperfetta se non consentirà di derivare determinate leggi: connessioni stabili e ripetitive di fenomeni. La funzione prognostica è molto importante per lo status della scienza, senza di essa anche la scienza è insostenibile. Quanto sopra può essere riassunto nella Figura 2.
Gli scienziati definiscono il concetto di diritto e regolarità in modi diversi. Siamo più vicini all'idea che la legge sia una connessione incondizionata, ripetitiva, stabile di fenomeni ed eventi. Naturalmente, ogni legge ha un certo ambito di applicazione in cui opera. Parlare di leggi universali è piuttosto condizionale. Inoltre, si parla più spesso di leggi nel sistema delle scienze naturali ed esatte, mentre nel sistema della conoscenza umanitaria è consuetudine parlare di schemi: connessioni ripetute, stabili, ma condizionate di fenomeni ed eventi. Questa convenzione è determinata, in primo luogo, dalla diversità e complessità - di una persona - del campo di studio.
Schema 2.

Oggi la scienza è definita come una sfera dell'attività umana, le cui funzioni sono: lo sviluppo e la sistematizzazione teorica della conoscenza oggettiva della realtà; uso pratico degli sviluppi teorici; la possibilità di prevedere lo sviluppo della ricerca ei loro risultati. La possibilità di implementare queste funzioni esiste a causa della multidimensionalità del fenomeno scientifico:
la scienza come istituzione sociale (una comunità di scienziati, un insieme di istituzioni scientifiche e strutture ausiliarie);
scienza come risultato - conoscenza scientifica, un sistema di idee sul mondo;
la scienza come processo - ricerca scientifica diretta, il processo per ottenere informazioni generalizzate, affidabili, obiettive e trasmesse;
Formazione della scienza come istituzione sociale. L'obiettivo più importante della scienza è l'acquisizione di nuove conoscenze in accordo con le esigenze future già formulate e solo possibili della società. Per soddisfare queste esigenze, la conoscenza deve possedere proprietà quali generalizzazione, affidabilità, comunicazione, obiettività.
Nel corso della storia della società umana, si sono formate istituzioni sociali che forniscono queste proprietà della conoscenza. Istituzione sociale - un concetto che denota un sistema di valori, norme, regole (formali e informali), principi che si riproduce costantemente; l'inizio che organizza i membri della società in un sistema di relazioni, ruoli e status. Le istituzioni sociali dovrebbero essere distinte dalle organizzazioni concrete. Tuttavia, la scienza come istituzione sociale unisce organizzazioni specifiche che conducono lavori di ricerca: queste sono, prima di tutto, le più alte istituti scolastici(accademie, università, istituti), istituti di settore, istituti di alta formazione, ecc.
Nessun lavoro scientifico è possibile senza l'infrastruttura adeguata. Questi sono i cosiddetti organismi e organizzazioni di servizio scientifico: case editrici scientifiche, riviste scientifiche, strumentazione scientifica, ecc., che sono, per così dire, sottorami della scienza come istituzione sociale.
La scienza come istituzione sociale può funzionare solo se c'è personale scientifico qualificato appositamente formato. La formazione del personale scientifico è svolta attraverso studi post-laurea o concorsi a livello grado candidato di scienze. Tra i candidati di scienze, attraverso studi di dottorato o co-ricerca, viene formato personale scientifico di altissima qualificazione - a livello del grado scientifico di dottore in scienze. A livello della comunità scientifica mondiale, il grado di dottorato corrisponde al grado di Dottore in Filosofia e il grado di Dottore in Scienze corrisponde al grado di Dottore in Ingegneria o Filosofia, rispettivamente, in scienze tecniche o umane .
Insieme ai titoli accademici, vengono assegnati insegnanti di istituti di istruzione superiore, istituti di formazione avanzata titoli accademici come tappe della loro qualificazione pedagogica: Professore Associato di Dipartimento (prevalentemente tra i dottorandi in scienze, con esperienze di insegnamento all'università e pubblicazioni scientifiche) e docenti (prevalentemente tra i dottori in scienze in presenza di importanti pubblicazioni scientifiche - libri di testo, monografie, ecc.) . Negli istituti scientifici di filiale, il titolo di professore associato nel dipartimento corrisponde al titolo di ricercatore senior o professore associato nella specialità e il titolo di professore nel dipartimento corrisponde al titolo di professore nella specialità.
Attualmente, molte istituzioni di istruzione secondaria invitano personale scientifico e pedagogico di università o organizzazioni scientifiche. Questa tendenza è estremamente promettente, così come la formazione del personale scientifico e pedagogico tra i dirigenti e gli insegnanti delle stesse istituzioni educative. Il fatto che sempre più candidati e dottori in scienze lavorino in scuole di istruzione generale, palestre, istituti di istruzione professionale primaria e secondaria suggerisce che queste istituzioni educative saranno sempre più coinvolte nelle attività di ricerca.
Argomento 2. Il concetto di ricerca scientifica
presentazione della ricerca scientifica
esigenze di ricerca scientifica
terminologia della ricerca scientifica
“Tutto ciò che esiste ne ha abbastanza
base per la sua esistenza
G. Leibniz
Le specificità della ricerca scientifica dipendono in gran parte dal campo della scienza in cui viene svolta. Ma c'è caratteristiche comuni, permettendoti di capire che si tratta di uno studio scientifico. La ricerca scientifica è collegata, in primo luogo, con la ricerca creativa indipendente del ricercatore. Tuttavia, questa ricerca creativa si basa su uno studio dettagliato e approfondito dell'esperienza scientifica passata. Come accennato di seguito, è importante comprendere il livello di ricerca problematica. Se poni un problema senza studiare i precedenti risultati della scienza, puoi ottenere un compito di apprendimento, in altre parole, l'invenzione di una bicicletta. C'è bisogno di continuità nello sviluppo di teorie scientifiche, idee e concetti, metodi e mezzi di conoscenza scientifica. Ogni stadio superiore nello sviluppo della scienza sorge sulla base dello stadio precedente, con la conservazione di tutto ciò che è prezioso accumulato prima.
Tuttavia, la scienza si sviluppa in modi diversi, la continuità non è un'opzione obbligatoria, indispensabile per lo sviluppo. Nello sviluppo della scienza, periodi di sviluppo relativamente calmo (evolutivo) e rottura violenta (rivoluzionaria) dei fondamenti teorici della scienza, si può distinguere il sistema dei suoi concetti e delle sue idee. Lo sviluppo evolutivo della scienza è il processo di accumulazione graduale di nuovi fatti, dati sperimentali nell'ambito delle visioni teoriche esistenti, in relazione alle quali vi è un'espansione, un perfezionamento e un perfezionamento di teorie, concetti, principi precedentemente accettati. Le rivoluzioni nella scienza arrivano quando inizia una rottura radicale e una ristrutturazione di opinioni precedentemente stabilite, una revisione di disposizioni, leggi e principi fondamentali come risultato dell'accumulo di nuovi dati, la scoperta di nuovi fenomeni che non rientrano nel quadro delle opinioni precedenti . Ma non è il contenuto stesso delle conoscenze pregresse che è soggetto a rottura e scarto, ma la loro errata interpretazione, ad esempio, l'errata universalizzazione di leggi e principi, che in realtà hanno solo un carattere relativo e limitato.
Inoltre, la conoscenza deve essere vera. È caratteristico della conoscenza scientifica che non si tratta solo di riferire sulla verità di un determinato contenuto, ma si forniscono i motivi per cui tale contenuto è vero (ad esempio, i risultati di un esperimento, la dimostrazione di un teorema, una conclusione logica , eccetera.). Pertanto, come segno caratterizzante la verità della conoscenza scientifica, indicano l'esigenza della sua sufficiente validità. Pertanto, è possibile differenziare i sistemi scientifici e religiosi, supponendo che questi siano due modi diversi di conoscere il mondo. Una - la scienza - si basa sulla prova della verità, e l'altra - la religione - sulla fede nella verità, che non richiede prove per definizione. Tra questi poli c'è un altro sistema di cognizione del mondo, principalmente il mondo spirituale e sensuale dell'uomo: questa è l'arte. L'arte, ci sembra, è una sorta di giunzione di prove e credenza nella verità di certe idee su una persona. Questo può essere illustrato con un diagramma.
Schema 3. Metodi per ottenere idee sulla realtà

Naturalmente, bisogna immaginare che i componenti di questo schema non si escludono a vicenda: si tratta di visioni diverse del mondo e di una persona, ed è chiaro a chiunque abbia incontrato attività di ricerca che la capacità di valutare lo stesso soggetto con occhi diversi e da diverse angolazioni rende l'immagine più affidabile. . Questo schema dice solo che la scienza non può fare affidamento sulla fede cieca o sul culto delle autorità, e per la religione questa è la norma.
La condizionalità dello sviluppo della scienza rispetto alle esigenze della pratica socio-storica detta le principali direzioni della ricerca scientifica. Questa è la principale forza trainante o fonte dello sviluppo della scienza. Allo stesso tempo, sottolineiamo che essa è condizionata non semplicemente dalle esigenze della pratica, ad esempio pedagogica, educativa, ma proprio dalla pratica storico-sociale. Ogni specifica ricerca può non essere determinata dalle esigenze specifiche della pratica, ma seguire dalla logica dello sviluppo della scienza stessa o, ad esempio, essere determinata dagli interessi personali di uno scienziato. Tuttavia, non è necessario semplificare eccessivamente l'immagine. La ricerca scientifica può essere progettata sia per l'immediato (applicato) che per il lungo termine (fondamentale). La questione del loro primato è insolubile, ciascuna delle aree è necessaria. La competenza scientifica di uno scienziato dipende in gran parte dalla sua capacità di vedere i benefici della ricerca che non sono evidenti a uno spettatore impreparato. Qui si manifesta la relativa indipendenza dello sviluppo della scienza. Qualunque compiti specifici Non importa come la pratica anteponga la scienza, la soluzione di questi problemi può essere effettuata solo quando la scienza raggiunge un certo livello corrispondente, determinati stadi di sviluppo del processo stesso di cognizione della realtà. Allo stesso tempo, a uno scienziato è spesso richiesto un certo coraggio quando le sue opinioni scientifiche, le sue costruzioni scientifiche vanno contro tradizioni e atteggiamenti consolidati.
Nella ricerca scientifica, si dovrebbe prestare attenzione all'interazione e all'interconnessione di tutti i rami della scienza, per cui l'argomento di un ramo della scienza può e deve essere studiato con i metodi e le tecniche di un'altra scienza. Come risultato di questo, le condizioni necessarie per una più completa e profonda divulgazione dell'essenza e delle leggi di fenomeni qualitativamente differenti.
Condizione indispensabile per la ricerca scientifica è la libertà di critica, la discussione senza ostacoli delle questioni scientifiche, l'espressione aperta e libera di opinioni diverse. Poiché la natura dialetticamente contraddittoria dei fenomeni e dei processi in natura, nella società e nell'uomo non viene rivelata nella scienza immediatamente e non direttamente, solo aspetti contraddittori separati dei processi oggetto di studio si riflettono nelle opinioni e nei punti di vista combattivi. Come risultato di tale lotta, viene superata l'iniziale inevitabile unilateralità di diverse visioni sull'oggetto di studio e si sviluppa una visione unica, che oggi è il riflesso più adeguato della realtà stessa.
Infine, il ricercatore alle prime armi deve prestare attenzione al linguaggio della scienza. Molti termini sono da noi compresi a livello quotidiano in modo diverso rispetto alla conoscenza scientifica. Consideriamo i principali.
Fatto (sinonimo: evento, risultato). Un fatto scientifico include solo tali eventi, fenomeni, le loro proprietà, connessioni e relazioni che sono fissate in un certo modo, registrate. I fatti costituiscono il fondamento della scienza. Senza un certo insieme di fatti, è impossibile costruire una teoria scientifica efficace. La dichiarazione di I.P. Pavlov che i fatti sono l'aria di uno scienziato. Il fatto come categoria scientifica differisce dal fenomeno. Un fenomeno è una realtà oggettiva, un evento separato, e un fatto è un insieme di molti fenomeni e connessioni, la loro generalizzazione. Un fatto è in larga misura il risultato di una generalizzazione di tutti i fenomeni analoghi, di ridurli a una determinata classe di fenomeni;
Posizione - dichiarazione scientifica, pensiero formulato;
P nozione - un pensiero che riflette in una forma generalizzata e astratta oggetti, fenomeni e connessioni tra di loro fissando caratteristiche generali e specifiche - proprietà di oggetti e fenomeni. Ad esempio, il concetto di "studenti" include gli studenti delle scuole di istruzione generale e degli istituti di istruzione professionale: studenti, cadetti, ascoltatori, ecc.
Nella scienza, si parla spesso di un concetto in via di sviluppo, implicando che il contenuto del concetto, man mano che i dati scientifici si accumulano e si sviluppano le teorie scientifiche, acquisisce sempre più caratteristiche e proprietà. Quindi, ad esempio, il concetto di "processo pedagogico" è stato recentemente integrato con nuovi contenuti: tecnologie pedagogiche, diagnostica, test, ecc. Il concetto va distinto dal termine, che è solo un vettore, un modo per designare il concetto. Ad esempio, il termine "processo pedagogico". Il concetto di "processo pedagogico" è tutto ciò che è noto alla scienza pedagogica sugli obiettivi, i contenuti, le forme, i metodi e i mezzi per insegnare e educare gli studenti, ecc.
Il concetto tra le altre forme di organizzazione della conoscenza scientifica occupa un posto speciale, poiché fatti, disposizioni, principi, leggi, teorie sono espressi attraverso parole-concetti e connessioni tra di loro, poiché la forma più alta del pensiero umano è il pensiero concettuale, verbale-logico . (AM Novikov 2006). Come ha scritto G. Hegel, comprendere significa esprimere sotto forma di concetti.
Termine "prova" può essere usato in diversi significati. In primo luogo, sotto la prova comprendere i fatti, con l'aiuto dei quali si sostanzia la verità o la falsità di un particolare giudizio.
In secondo luogo, prove significa fonti di informazione.
sui fatti: cronache, testimonianze oculari, memorie, documenti, ecc. In terzo luogo, la prova è un processo di pensiero. In logica, il termine è usato in questo senso.
Quindi, la prova è un ragionamento logico, nel processo del quale la verità o falsità di qualsiasi pensiero si sostanzia con l'aiuto di altre disposizioni verificate dalla scienza e dalla pratica concreta.
La prova è connessa con la credenza, ma non è identica ad essa: la prova deve basarsi sui dati della scienza e della pratica concreta.Le credenze possono basarsi, ad esempio, sulla fede, sui pregiudizi, sull'ignoranza delle persone su determinate questioni, su vari tipi di errori logici.
La prova come modo logico speciale di sostanziare la verità ha una sua struttura. Ogni prova include tesi, argomentazioni, dimostrazione. Ciascuno di questi elementi nella struttura logica della dimostrazione svolge le proprie funzioni speciali, quindi nessuno di essi può essere ignorato quando si costruisce una dimostrazione logicamente corretta.
Diamo una descrizione logica di ciascuno di questi elementi.
tesi prova è la posizione la cui verità o falsità deve essere dimostrata. Se non c'è tesi, allora non c'è nulla da dimostrare. Pertanto, ogni ragionamento basato sull'evidenza è del tutto subordinato alla tesi e serve a confermarla (o confutarla). In prova: l'obiettivo principale di ogni ragionamento è la tesi, la sua conferma o confutazione.
La tesi può essere formulata sia all'inizio della dimostrazione, sia in qualsiasi altro momento della stessa. La tesi è spesso espressa sotto forma di giudizio categorico, ad esempio: “La proposizione che sto dimostrando è la seguente”, “Ecco la mia tesi”, “Ho il compito di provare”, “Ecco la mia posizione” , "Sono profondamente convinto che ... ", ecc. Spesso la tesi è formulata sotto forma di domanda.
Le prove sono semplici o complesse. La loro principale differenza sta nel fatto che in una dimostrazione complessa c'è una tesi principale e una tesi parziale.
Tesi principale - questa è la disposizione alla quale è subordinata la giustificazione di alcune altre disposizioni. tesi privata - questa è una posizione che diventa tesi solo perché con il suo aiuto si dimostra la tesi principale. La tesi privata, essendo provata, diventa allora essa stessa un argomento per suffragare la tesi principale.
argomenti (o motivi) di prova sono quei giudizi che vengono dati per confermare o confutare la tesi. Dimostrare una tesi significa formulare giudizi tali che sarebbero sufficienti a sostanziare la verità o la falsità della tesi avanzata.
Come argomenti per dimostrare la tesi, qualsiasi pensiero vero può essere dato, purché connesso con la tesi, lo sostanzia. I principali tipi di argomenti sono fatti, leggi, assiomi, definizioni, prove documentali, ecc.
Gli assiomi sono usati anche come basi di prova. Assioma - questa è una posizione che non richiede prove. La verità degli assiomi alla base della dimostrazione non è verificata caso per caso, perché la verifica di tale verità è stata più volte effettuata in precedenza, confermata dalla pratica. Gli assiomi sono ampiamente utilizzati come fondamenti in giurisprudenza. Il ruolo degli assiomi qui è giocato dalle presunzioni.
Presunzione - questa è una posizione che si considera consolidata e non necessita di prove. Non è ovvio ed è accettato come vero non perché la sua correttezza sembri indiscutibile e derivi proprio dalla posizione che costituisce il contenuto della presunzione. Una presunzione è una disposizione che formula alcuni degli atteggiamenti più comuni e più comuni.
Dimostrazione (o la forma dell'evidenza) è il metodo di connessione logica della tesi con le argomentazioni. La tesi e gli argomenti della prova sono giudizi nella loro forma logica. Espressi in frasi grammaticali, sono da noi percepiti direttamente: la tesi e gli argomenti si vedono se sono scritti; ascolta se sono parlati.
Directory Internetlivello macro e metodo identificazione degli strati sociali in base alla strategia di spesa. IN scientificoricerca T.P.Pritvorova ha sviluppato ... . - Almaty: Palestra, 2004. - 216 pag. 2. Metodologia e metodologia scientificoricerca. - Almaty: Palestra, 2005. - 353 p. 3. ...