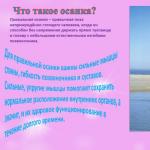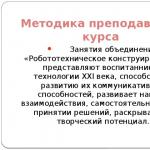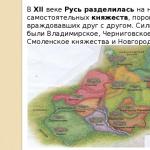coscienza individuale e sociale. La loro relazione
100 r bonus del primo ordine
Scegli il tipo di lavoro Lavoro di laurea Corso Abstract Tesi di Master Report sulla pratica Article Report Review Test Monografia Problem solving Business plan Rispondere alle domande Lavoro creativo Saggio Disegno Composizioni Traduzione Presentazioni Dattilografia Altro Accrescere l'unicità del testo Tesi del candidato Lavoro di laboratorio Aiuto in linea
Chiedi un prezzo
La coscienza sociale è un insieme di idee, teorie, punti di vista, idee, sentimenti, credenze, emozioni delle persone, stati d'animo, che riflettono la natura, la vita materiale della società e l'intero sistema di relazioni sociali. La coscienza sociale si forma e si sviluppa con l'emergere dell'essere sociale, poiché la coscienza è possibile solo come prodotto delle relazioni sociali. Ma una società può anche essere chiamata società solo quando i suoi elementi principali, inclusa la coscienza sociale, si sono sviluppati.
La società è una realtà materiale-ideale. Un insieme di idee, idee, teorie, sentimenti, costumi, tradizioni generalizzate, ad es. tutto ciò che costituisce il contenuto coscienza pubblica, forma una realtà spirituale, agisce parte integrale vita sociale. Ma sebbene il materialismo affermi un certo ruolo dell'essere sociale in relazione alla coscienza sociale, è impossibile parlare in modo semplificato del primato del primo e della secondaria natura dell'altro. La coscienza sociale sorse non qualche tempo dopo l'emergere dell'essere sociale, ma nello stesso tempo in unità con esso. Senza la coscienza pubblica, la società semplicemente non sarebbe potuta nascere e svilupparsi, perché esiste, per così dire, in due manifestazioni: riflessiva e attivamente creativa. L'essenza della coscienza sta proprio nel fatto che essa può riflettere l'essere sociale solo a condizione della sua simultanea trasformazione attiva e creativa.
Ma, sottolineando l'unità dell'essere sociale e della coscienza sociale, non bisogna dimenticare la loro differenza, la disunione specifica, la relativa indipendenza.
Una caratteristica della coscienza sociale è che nella sua influenza sull'essere, può, per così dire, valutarlo, rivelarne il significato nascosto, prevederlo e trasformarlo attraverso l'attività pratica delle persone. E così la coscienza pubblica dell'epoca può non solo riflettere l'essere, ma anche contribuire attivamente alla sua trasformazione. Questa è la funzione storicamente stabilita della coscienza sociale, che la rende un elemento necessario e realmente esistente di qualsiasi struttura sociale. Nessuna riforma, se non supportata dalla consapevolezza pubblica del loro significato e necessità, non darà i risultati sperati, ma resterà solo nell'aria.
La relazione tra essere sociale e coscienza sociale è sfaccettata e varia.
Così, le cose create dall'uomo sono l'oggettivazione delle idee corrispondenti, contengono organicamente, quindi, gli elementi della coscienza sociale. Riflettendo l'essere sociale, la coscienza sociale è in grado di influenzarlo attivamente attraverso l'attività trasformativa delle persone.
La relativa indipendenza della coscienza sociale si manifesta nel fatto che ha continuità. Le nuove idee non nascono da zero, ma come risultato naturale della produzione spirituale, basata sulla cultura spirituale delle generazioni passate.
Essendo relativamente indipendente, la coscienza sociale può essere in anticipo rispetto all'essere sociale o essere in ritardo rispetto ad esso. Ad esempio, l'idea di utilizzare l'effetto fotoelettrico è nata 125 anni prima che la fotografia fosse inventata da Daguerre. Le idee per l'uso pratico delle onde radio sono state implementate quasi 35 anni dopo la loro scoperta, e così via.
La coscienza sociale è un fenomeno sociale speciale, caratterizzato da caratteristiche proprie, peculiari solo ad essa, modelli specifici di funzionamento e sviluppo.
Anche la coscienza pubblica, che riflette tutta la complessità e l'incoerenza della vita sociale, è contraddittoria e ha una struttura complessa. Con l'avvento delle società di classe, ha acquisito una struttura di classe. Le differenze nelle condizioni socio-economiche della vita delle persone trovano naturalmente la loro espressione nella coscienza pubblica.
Negli stati multinazionali c'è una coscienza nazionale di vari popoli. Le relazioni tra nazioni diverse si riflettono nella mente delle persone. In quelle società in cui la coscienza nazionale prevale sulla coscienza universale, il nazionalismo e lo sciovinismo prendono il sopravvento.
Secondo il livello, la profondità e il grado di riflessione della vita sociale nella coscienza pubblica, si distingue la coscienza ordinaria e quella teorica. Dal punto di vista dei suoi portatori materiali, si dovrebbe parlare di coscienza sociale, di gruppo e individuale e, in termini storici e genetici, si considera la coscienza sociale nel suo insieme o le sue caratteristiche nelle varie formazioni socio-economiche.
Iniziamo la nostra analisi dell'essenza e della struttura della coscienza sociale esaminando la coscienza individuale e la sua relazione dialettica con la coscienza sociale.
La coscienza individuale è il mondo spirituale dell'individuo, che riflette l'esistenza sociale attraverso il prisma delle condizioni specifiche di vita e di attività di una determinata persona. Questo è un insieme di idee, punti di vista, sentimenti inerenti a una persona particolare, in cui si manifesta la sua individualità, originalità, che lo distingue dalle altre persone.
La dialettica del rapporto tra individuo e coscienza sociale è la dialettica del rapporto tra individuo e generale. La coscienza sociale si forma sulla base della coscienza delle singole persone, ma non è la loro semplice somma. Questo è un fenomeno sociale qualitativamente nuovo, una sintesi organica e rielaborata di quelle idee, punti di vista, sentimenti che sono inerenti alla coscienza individuale.
La coscienza individuale di una persona è più varia e luminosa della coscienza sociale. Tuttavia, non raggiunge la profondità che è inerente alla coscienza sociale, coprendo tutti gli aspetti della vita spirituale della società.
Allo stesso tempo, la coscienza individuale delle singole persone, a causa dei loro meriti speciali in determinate aree della conoscenza, può salire al livello del pubblico. Ciò è possibile quando la coscienza individuale acquisisce un significato scientifico universale, esprime idee che coincidono con i bisogni sociali. D. Watt e N. Polzunov hanno creato quasi contemporaneamente macchine a vapore. Ma in Inghilterra, le idee di Watt erano richieste dalla società e sviluppate, mentre nella Russia arretrata non c'era bisogno sociale di motori a vapore e il loro uso fu rallentato. D'altra parte, parlando del rapporto tra individuo e coscienza sociale, va sottolineato che la coscienza individuale porta l'impronta del pubblico, poiché è e sarà sempre un prodotto della società. Ogni individuo è portatore di visioni sociali, abitudini, tradizioni, che provengono dalla profondità dei secoli. A loro volta, tutte le persone, in una certa misura, portano nella mente idee, punti di vista, ecc. Una persona non può essere isolata dalla società e dalle idee sociali. Trasformandosi attraverso l'esistenza delle singole persone, la loro coscienza sociale forma la coscienza individuale. Newton fece le sue brillanti scoperte perché, secondo lui, stava sulle spalle di giganti del pensiero come Galileo, Keplero e molti altri. La società è una formazione materiale complessa, composta da molti gruppi sociali differenti. Tali gruppi sono classi, proprietà, integrali (lavoratori del lavoro mentale e fisico, residenti della città e del villaggio), gruppi etnografici, demografici e professionali. Ogni gruppo è soggetto di una certa coscienza, e in questo senso si può parlare di coscienza di gruppo. La coscienza di gruppo è dialetticamente connessa con la coscienza sociale e la coscienza individuale come speciale. Si forma sulla base dell'individuo, ma, come la coscienza sociale, non è una semplice somma dell'individuo, sebbene rifletta l'esistenza delle condizioni socio-economiche e politiche di vita di ogni gruppo di persone. Allo stesso tempo, la coscienza di gruppo è mediata dalla coscienza sociale e agisce come un elemento o sottosistema della coscienza sociale, entrandovi con parte dei suoi elementi.
La coscienza ordinaria è il livello più basso della coscienza sociale, la sua parte integrante, un sottosistema della coscienza sociale. Riflette le relazioni semplici e visibili tra le persone, tra le persone e le cose, tra l'uomo e la natura. La pratica quotidiana delle persone permette di installarlo livello empirico separare le relazioni causali tra i fenomeni, consente di trarre conclusioni semplici, introdurre nuovi concetti, scoprire verità semplici. Tuttavia, a livello della coscienza quotidiana è impossibile penetrare in profondità nell'essenza delle cose, dei fenomeni, per elevarsi a profonde generalizzazioni teoriche. Nel primo periodo della vita delle persone, la coscienza ordinaria era l'unica e principale cosa. man mano che la società si sviluppa, sorge la necessità di generalizzazioni più profonde e la coscienza ordinaria diventa insufficiente per soddisfare i bisogni crescenti. Poi c'è la coscienza teorica. Sorgendo sulla base della coscienza quotidiana, dirige l'attenzione delle persone sul riflesso dell'essenza dei fenomeni della natura e della società, sollecitandone un'analisi più approfondita. Attraverso la coscienza ordinaria, la coscienza teorica è connessa con l'essere sociale.
La coscienza teorica rende la vita delle persone più consapevole, contribuisce a uno sviluppo più profondo della coscienza sociale, poiché rivela la connessione naturale e l'essenza dei processi materiali e spirituali.
La coscienza ordinaria è costituita dalla conoscenza ordinaria e dalla psicologia sociale. La coscienza teorica porta la conoscenza scientifica sulla natura e sulla società. La conoscenza ordinaria è la conoscenza delle condizioni elementari dell'esistenza delle persone, che consente a una persona di navigare nel suo ambiente immediato. Questa è la conoscenza dell'uso di strumenti semplici, dei semplici fenomeni naturali, delle norme delle relazioni reciproche.
Ci siamo formati un'idea limitata e scorretta della coscienza di massa, che è stata interpretata come una parte primitiva e di basso grado della coscienza quotidiana di una certa parte dei lavoratori, e soprattutto dei giovani. Ma la coscienza di massa è un fenomeno più complesso. Secondo i sociologi, ogni persona è membro di almeno 5-6 solo piccoli gruppi e almeno 10-15 grandi e "medi" gruppi formali e informali. Questa massa di persone, essendo una comunità reale e naturale, è unita da un processo sociale reale (anche se a breve termine), svolge attività comuni e dimostra comportamenti comuni. Inoltre, il fenomeno della massa in sé non si verifica se non esiste una tale attività comune, articolare o un comportamento simile.
Associato alla coscienza di massa opinione pubblica, che lo rappresenta caso speciale. L'opinione pubblica esprime l'atteggiamento (nascosto o esplicito) delle varie comunità sociali nei confronti di determinati eventi della realtà. Determina il comportamento degli individui, dei gruppi sociali, delle masse e degli stati.
L'opinione pubblica può riflettere la verità o essere falsa. Può sorgere spontaneamente o può essere formato come parte della coscienza di massa da istituzioni statali, organizzazioni politiche e media. Ad esempio, negli anni '30, attraverso la propaganda, si è formata nel nostro Paese una coscienza di massa dell'intolleranza verso i dissidenti. E l'opinione pubblica chiedeva la morte di tutti coloro che, per le loro convinzioni, non rientravano nel quadro della coscienza di massa.
Un'idea corretta di coscienza sociale non può essere formata senza analizzare le forme specifiche attraverso le quali si realizza effettivamente la riflessione dell'esistenza sociale e azione inversa coscienza pubblica sulla vita della società.
Le forme di coscienza sociale sono intese come varie forme di riflessione nella mente delle persone del mondo oggettivo e dell'essere sociale, sulla base delle quali sorgono nel processo dell'attività pratica. La coscienza pubblica esiste e si manifesta nelle forme di coscienza politica, coscienza giuridica, coscienza morale, coscienza religiosa e atea, coscienza estetica, coscienza delle scienze naturali.
L'esistenza di varie forme di coscienza sociale è determinata dalla ricchezza e dalla diversità del mondo oggettivo stesso: la natura e la società. Varie forme di coscienza riflettono le relazioni tra classi, nazioni, comunità e gruppi sociali, stati e servono come base di programmi politici. Nella scienza si conoscono leggi concrete della natura. L'arte riflette il mondo in immagini artistiche, ecc. Avendo un peculiare oggetto di riflessione, ogni forma di coscienza ha una sua speciale forma di riflessione: un concetto scientifico, una norma morale, un dogma religioso, un'immagine artistica.
Ma la ricchezza e la complessità del mondo oggettivo creano solo la possibilità dell'emergere di varie forme di coscienza sociale. Questa possibilità si realizza sulla base di una specifica esigenza sociale. Così, la scienza sorge quando la semplice accumulazione empirica di conoscenza diventa insufficiente per lo sviluppo produzione sociale. Le opinioni e le idee politiche e legali sorsero insieme alla stratificazione di classe della società.
Si distinguono le seguenti forme di coscienza sociale: coscienza politica, coscienza giuridica, coscienza morale, coscienza estetica, coscienza religiosa e atea, coscienza delle scienze naturali, coscienza economica, coscienza ecologica.
A prima vista, la separazione tra coscienza individuale e coscienza sociale, la loro implicita opposizione reciproca, possono sembrare incomprensibili. L'uomo, l'individuo, non è un essere sociale e, poiché è così, la sua coscienza individuale non è al tempo stesso una coscienza sociale? Sì, nel senso che è impossibile vivere in società ed essere liberi dalla società, la coscienza dell'individuo ha davvero un carattere sociale, perché il suo sviluppo, contenuto e funzionamento sono determinati dalle condizioni sociali in cui vive. L'essere sociale si riflette nella mente dell'individuo principalmente non direttamente, ma è passato attraverso il "secondo schermo" - attraverso "limitatori" socioculturali (associati al livello di cultura della società nel suo insieme, inclusa l'immagine dominante del mondo ) e ideologico (associato alle peculiarità della percezione dell'essere sociale inerente a grandi gruppi sociali separati). Notiamo che un individuo può gravitare verso la coscienza di questi gruppi sia per la sua attuale posizione sociale, sia per la sua origine, sia per la sua educazione.
Eppure la coscienza dell'individuo è lungi dall'essere identica né alla coscienza della società nel suo insieme, né alla coscienza dei grandi gruppi che dominano l'individuo dato.
La coscienza individuale è un riflesso dell'essere sociale di un individuo attraverso il prisma delle condizioni specifiche della sua vita e delle sue caratteristiche psicologiche. Ciò significa che nella coscienza di un individuo coesistono (in alcuni casi combinandosi armoniosamente tra loro, in altri essendo in contraddizioni antagonistiche) vari strati ed elementi spirituali. Quindi, la coscienza individuale è una sorta di fusione del generale, del particolare e del singolare nella coscienza dell'individuo. Il generale e lo speciale in questa lega sono già stati menzionati un po' più in alto, e l'individuo è tutto ciò che è connesso con l'individualità di una data persona.
L'interazione, il rapporto tra coscienza sociale e coscienza individuale sono dialetticamente contraddittori. Da un lato, la coscienza individuale è permeata e, di regola, per la maggior parte organizzata dalla coscienza sociale, ne è “saturata”. Ma d'altra parte, il contenuto stesso della coscienza sociale ha la coscienza individuale come unica fonte. E ciò che per me e per i miei contemporanei appare come assolutamente transpersonale, non personalizzato, è stato infatti introdotto nella coscienza pubblica da individui specifici: e quelli di cui ricordiamo i nomi - Epicuro e Kant, Shakespeare e Ciajkovskij, Tommaso d'Aquino e Agostino Aurelio, F Bacone e Marx, Copernico ed Einstein - e quelle migliaia e centinaia di migliaia i cui nomi non sono stati conservati nella stessa coscienza pubblica. E. V. Tarle, un eccezionale storico russo, ha scritto: “È improbabile che qualcosa possa essere più difficile per uno storico di un noto movimento ideologico che cercare e determinare l'inizio di questo movimento. Come è nato il pensiero nella coscienza individuale, come si è compreso, come è passato agli altri, ai primi neofiti, come è cambiato via via...”1. Tracciando questo percorso (principalmente attraverso le fonti primarie), lo storico riproduce su materiale concreto il meccanismo per incorporare le innovazioni della coscienza individuale nei contenuti del pubblico.
Un'altra importante regolarità: il funzionamento di un'idea già inclusa nel contenuto della coscienza sociale, la sua “vita” o, al contrario, l'eventuale “morire” sono anch'essi inseparabili dalla coscienza individuale. Se un'idea non funziona per molto tempo in nessuna coscienza individuale, entra nella "circolazione della redenzione" nella coscienza pubblica, cioè muore.
Per una corretta comprensione della natura, del contenuto, del livello e della direzione della coscienza individuale Grande importanza ha sviluppato con successo dalle nostre scienze sociali negli ultimi decenni, la categoria del "microambiente sociale". L'utilizzo di questa categoria consente di individuarne un frammento specifico ed estremamente importante dall'idea generale di “ambiente sociale”. Il fatto è che l'ambiente sociale che forma il mondo spirituale dell'individuo non è qualcosa di unico e unidimensionale. Quello e il megaambiente - enorme mondo moderno intorno a una persona con il suo confronto politico, economico e ideologico-psicologico e insieme unità. Questo è anche il macroambiente, diciamo, la nostra società recentemente ancora sovietica e ora post-sovietica. Questo è anche il microambiente - l'ambiente sociale immediato di una persona, i cui componenti principali (gruppi di riferimento) sono la famiglia, l'équipe primaria - educativa, sindacale, militare, ecc. - e ambiente amichevole. È possibile comprendere il mondo spirituale di questo particolare individuo solo tenendo conto dell'impatto sulla sua coscienza del mega, macro e microambiente, e l'impatto non è uniforme in ogni caso specifico.
Oggi, la categoria "microambiente sociale" ha ricevuto diritti di cittadinanza in molte scienze - in giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia sociale, ecc. E ciascuna di queste scienze sul materiale più ricco conferma il ruolo estremamente importante del microambiente nella formazione della personalità e nella sua ulteriore vita. Nonostante l'importanza delle oggettive condizioni socio-economiche di vita, il clima ideologico e socio-psicologico nell'ambiente familiare, lavorativo, collettivo e conviviale è spesso molto importante, forse addirittura determinante per la formazione di atteggiamenti normativi dell'individuo. Sono loro che creano direttamente il nucleo intellettuale e morale della personalità, su cui poi si baserà il comportamento morale e lecito, o immorale e persino criminale. Naturalmente, le caratteristiche individuali della coscienza non sono determinate solo dal microambiente: è necessario tenere conto, in misura non minore, delle caratteristiche antropologiche (biologiche e psicologiche) dell'individuo stesso, delle circostanze della sua vita personale.
Come già accennato, il momento centrale della vita spirituale della società (il suo nucleo) è la coscienza pubblica delle persone. Quindi, ad esempio, un bisogno spirituale non è altro che un certo stato di coscienza e si manifesta come una motivazione consapevole di una persona alla creatività spirituale, alla creazione e al consumo di valori spirituali. Questi ultimi sono l'incarnazione della mente e dei sentimenti delle persone. La produzione spirituale è la produzione di certi punti di vista, idee, teorie, norme morali e valori spirituali. Tutte queste formazioni spirituali agiscono come oggetti di consumo spirituale. Le relazioni spirituali tra le persone sono relazioni sui valori spirituali in cui è incarnata la loro coscienza.
coscienza pubblicaè una raccolta di sentimenti, stati d'animo, immagini artistiche e religiose, vari punti di vista, idee e teorie che riflettono determinati aspetti vita pubblica. Va detto che il riflesso della vita sociale nella coscienza pubblica non è una sorta di immagine speculare meccanica, così come un paesaggio naturale situato lungo le sue sponde si riflette sulla superficie speculare di un fiume. In questo caso, in un fenomeno naturale, le caratteristiche di un altro si riflettevano puramente esteriormente. La coscienza pubblica riflette non solo esteriore, ma anche lati interni vita della società, la loro essenza e contenuto.
La coscienza pubblica ha una natura sociale. Nasce dalla pratica sociale delle persone come risultato della loro produzione, famiglia, famiglia e altre attività. È nel corso di un'attività pratica congiunta che le persone comprendono il mondo che li circonda per usarlo nei propri interessi. Vari fenomeni sociali e il loro riflesso in immagini e concetti, idee e teorie sono due facce dell'attività pratica delle persone.
Essendo un riflesso dei fenomeni della vita sociale, vari tipi di immagini, punti di vista, teorie mirano a una conoscenza più approfondita di questi fenomeni da parte delle persone per i loro scopi pratici, anche ai fini del loro consumo diretto o del loro altro uso, diciamo, per lo scopo della loro fruizione estetica, ecc. d. In definitiva, il contenuto della pratica sociale, l'intero realtà sociale, compreso dalle persone, diventa il contenuto della loro coscienza sociale.
Pertanto, la coscienza sociale può essere interpretata come il risultato di una comprensione congiunta della realtà sociale da parte di persone che interagiscono praticamente. Questa è la natura sociale della coscienza sociale e la sua caratteristica principale.
Si può, forse, essere d'accordo in una certa misura con l'affermazione che, a rigor di termini, non è l'uomo che pensa, ma l'umanità. Un individuo pensa in quanto è incluso nel processo di pensiero di una data società e umanità, cioè:
- è incluso nel processo di comunicazione con altre persone e padroneggia il discorso;
- è coinvolto in vari tipi di attività umana e ne comprende il contenuto e il significato;
- assimila oggetti di cultura materiale e spirituale delle generazioni passate e presenti e li usa secondo il loro scopo sociale.
Assimilando in una certa misura la ricchezza spirituale del suo popolo e dell'umanità, padroneggiando la lingua, impegnandosi in varie attività e relazioni sociali, un individuo acquisisce le capacità e le forme di pensiero, diventa un soggetto sociale pensante.
È giusto parlare della coscienza individuale di una persona, se la sua coscienza è direttamente o indirettamente condizionata dalla società e dalla cultura di tutta l'umanità? Sì, è legale. Del resto, non c'è dubbio che le stesse condizioni di vita sociale sono percepite dai singoli individui in qualcosa di più o meno uguale, e in qualcosa di diverso. Per questo motivo, hanno opinioni sia generali che individuali su determinati fenomeni sociali, a volte differenze significative nella loro comprensione.
coscienza individuale le singole persone sono, prima di tutto, le caratteristiche individuali della loro percezione dei vari fenomeni della vita sociale. In definitiva, queste sono le caratteristiche individuali delle loro opinioni, interessi e orientamenti di valore. Tutto ciò dà origine a determinate caratteristiche nelle loro azioni e comportamenti.
Nella coscienza individuale di una persona, le caratteristiche della sua vita e attività nella società, la sua esperienza di vita personale, nonché le caratteristiche del suo carattere, temperamento, il livello della sua cultura spirituale e altre circostanze oggettive e soggettive della sua esistenza sociale si manifestano. Tutto ciò forma l'unico mondo spirituale delle singole persone, la cui manifestazione è la loro coscienza individuale.
Eppure, pur rendendo omaggio alla coscienza individuale e creando opportunità per il suo sviluppo, va tenuto presente che essa non funziona in alcun modo autonomamente dalla coscienza sociale, non è assolutamente indipendente da essa. È necessario vedere la sua interazione con la coscienza pubblica. È vero che la coscienza individuale di molte persone arricchisce significativamente la coscienza pubblica con immagini, esperienze e idee vivide, contribuisce allo sviluppo della scienza, dell'arte e così via. Allo stesso tempo, la coscienza individuale di ogni persona si forma e si sviluppa sulla base della coscienza sociale.
Nella mente degli individui, il più delle volte ci sono idee, punti di vista e pregiudizi che hanno appreso, anche se in una speciale rifrazione individuale, mentre vivevano nella società. E la personalità è più ricca spiritualmente più ha imparato dalla cultura spirituale del suo popolo e di tutta l'umanità.
Sia la coscienza pubblica che quella individuale, essendo un riflesso dell'esistenza sociale delle persone, non la copiano ciecamente, ma hanno una relativa indipendenza, a volte abbastanza significativa.
In primo luogo, la coscienza sociale non segue solo l'essere sociale, ma lo comprende, rivela l'essenza dei processi sociali. Pertanto, è spesso in ritardo rispetto al loro sviluppo. Dopotutto, una loro comprensione più profonda è possibile solo quando hanno assunto forme mature e si sono manifestate nella massima misura. Allo stesso tempo, la coscienza sociale può precedere l'essere sociale. Sulla base dell'analisi di alcuni fenomeni sociali, si possono scoprire le tendenze più importanti nel loro sviluppo e quindi prevedere il corso degli eventi.
La relativa indipendenza della coscienza sociale si manifesta anche nel fatto che nel suo sviluppo fa affidamento sulle conquiste del pensiero umano, della scienza, dell'arte, ecc., deriva da queste conquiste. È chiamato continuità nello sviluppo della coscienza pubblica, grazie alla quale viene preservato e ulteriormente sviluppato il patrimonio spirituale delle generazioni accumulato nei vari ambiti della vita pubblica. Tutto ciò mostra che la coscienza sociale non solo riflette la vita sociale delle persone, ma ha una sua logica interna di sviluppo, i suoi principi e le sue tradizioni. Questo è chiaramente visibile nello sviluppo della scienza, dell'arte, della moralità, della religione e della filosofia.
Infine, la relativa indipendenza della coscienza sociale si manifesta nella sua influenza attiva sulla vita sociale. Ogni sorta di idee, concetti teorici, dottrine politiche, principi morali, tendenze nel campo dell'arte e della religione possono svolgere un ruolo progressista o, al contrario, reazionario nello sviluppo della società. Ciò è determinato dal fatto che contribuiscano al suo arricchimento, rafforzamento e sviluppo spirituale, o se portino alla distruzione e al degrado dell'individuo e della società.
È importante considerare fino a che punto certe opinioni, teorie scientifiche, principi morali, opere d'arte e altre manifestazioni della coscienza pubblica corrispondono ai veri interessi dei popoli di questo o quel paese e agli interessi del suo futuro. Le idee progressiste in tutti i settori della vita pubblica sono un potente fattore di sviluppo, perché contribuiscono a una profonda comprensione del presente e alla previsione del futuro, ispirano fiducia nelle azioni delle persone, migliorano il loro benessere sociale e ispirano nuove azioni creative. Costituiscono la spiritualità stessa senza la quale la società e gli individui non possono vivere e agire normalmente. Tutto suggerisce che il ruolo della coscienza pubblica nella vita della società moderna è molto significativo ed è in costante aumento.
Non ci soffermeremo sulle definizioni di coscienza individuale e sociale e ci concentreremo sulla natura della loro relazione, soprattutto in termini di comprensione del modo di esistenza e di funzionamento della coscienza sociale.
La coscienza sociale è un aspetto necessario e specifico della vita sociale, non è solo un riflesso del cambiamento della vita sociale, ma allo stesso tempo svolge funzioni organizzative, regolatrici e trasformatrici. Come l'essere sociale, la coscienza sociale ha un carattere storico concreto. Questo è un certo insieme di idee, idee, valori, norme di pensiero e attività pratica.
Senza entrare nell'analisi della complessa struttura della coscienza sociale e delle sue forme, notiamo che i fenomeni della coscienza sociale sono caratterizzati principalmente dal loro contenuto specifico e dal loro specifico soggetto sociale. Cosa sono esattamente queste idee, insegnamenti, atteggiamenti, qual è il loro significato sociale, cosa in essi si afferma e si nega, quali obiettivi sociali si pongono, contro cosa e in nome di cosa sono chiamati a combattere, i cui interessi e la cui visione del mondo esprimono , chi è il loro portatore: che tipo di gruppo sociale, classe, nazione, che tipo di società - queste sono approssimativamente le domande principali, le cui risposte caratterizzano determinati fenomeni della coscienza sociale, rivelano il loro ruolo nella vita pubblica, le loro funzioni sociali.
Tuttavia, le domande di cui sopra ne determinano ancora solo una, sebbene, forse, il piano principale per l'analisi dei fenomeni della coscienza sociale. Un altro progetto teorico per l'analisi della coscienza sociale, particolarmente importante per lo sviluppo del problema dell'ideale, è posto dalle seguenti domande: come e dove esistono questi fenomeni di coscienza sociale; quali sono le caratteristiche del loro statuto ontologico rispetto ad altri fenomeni sociali; quali sono le modalità della loro "vita", l'efficacia sociale; quali sono i "meccanismi" specifici della loro formazione, sviluppo e morte?
I due piani teorici di descrizione e analisi dei fenomeni di coscienza sociale sopra delineati sono, ovviamente, strettamente correlati. Tuttavia, esse formano diverse "valenze" logiche del concetto di "coscienza pubblica", che devono essere prese in considerazione quando si studia il problema che ci interessa. Chiamiamoli, per brevità, una descrizione del contenuto e una descrizione del modo di esistenza dei fenomeni della coscienza sociale.
La distinzione tra questi piani descrittivi è giustificata dal fatto che logicamente appaiono relativamente autonomi. Così, idee pubbliche, norme, opinioni, ecc., che sono opposte nel loro contenuto. possono avere lo stesso "meccanismo" specifico della loro formazione dei fenomeni di coscienza sociale e lo stesso modo di esistenza e di trasformazione. Pertanto, nello studio del contenuto e del significato sociale di certe idee sociali, è lecito divagare in un modo o nell'altro dal "meccanismo" della loro formazione e dal modo della loro esistenza, così come viceversa. Inoltre, la distinzione tra questi piani descrittivi è molto importante quando si considera il rapporto tra coscienza individuale e coscienza sociale.
La coscienza individuale è la coscienza di un individuo, che, ovviamente, è impensabile al di fuori della società. Pertanto, la sua coscienza è primordialmente sociale. Tutte le astrazioni usate per descrivere la coscienza individuale, in un modo o nell'altro, la fissano direttamente o indirettamente. entità sociale. Ciò significa che nasce e si sviluppa solo nel processo di comunicazione con altre persone e in attività pratiche congiunte. La coscienza di ogni persona include necessariamente come suo contenuto principale idee, norme, atteggiamenti, punti di vista, ecc., Che hanno lo status di fenomeni di coscienza sociale. Ma anche quella peculiare, originale, che è nel contenuto della coscienza individuale, è anche, naturalmente, una proprietà sociale e non un'altra proprietà. "Coscienza individuale", notano V. Zh. Kelle e M. Ya. tratti individuali dovuti all'educazione, alle capacità e alle circostanze della vita personale dell'individuo.
Il generale e il particolare nella coscienza individuale non sono fondamentalmente altro che fenomeni interiorizzati della coscienza sociale che "vivono" nella coscienza di un dato individuo nella forma della sua realtà soggettiva. Osserviamo qui una profonda interconnessione dialettica e interdipendenza di socialmente significativo e personalmente significativo, che si esprime nel fatto che le idee sociali, le norme, gli atteggiamenti di valore fanno parte della struttura della coscienza individuale. Come dimostrano studi speciali, l'ontogenesi di una personalità è un processo di socializzazione, l'appropriazione di valori spirituali socialmente significativi. Allo stesso tempo, è un processo di individualizzazione: la formazione di strutture di valori immanenti che determinano le posizioni interne dell'individuo, il sistema delle sue convinzioni e la direzione della sua attività sociale.
Quindi, ogni coscienza individuale è sociale nel senso che è permeata, organizzata, "satura" di coscienza sociale, altrimenti non esiste. Il contenuto principale della coscienza individuale è il contenuto di un certo complesso di fenomeni della coscienza sociale. Questo, naturalmente, non significa che il contenuto di una data coscienza individuale contenga l'intero contenuto della coscienza sociale e, al contrario, che il contenuto della coscienza sociale contenga l'intero contenuto di una data coscienza individuale. Il contenuto della coscienza sociale è estremamente vario, e comprende sia componenti umane universali (regole logiche, linguistiche, matematiche, le cosiddette norme semplici di moralità e giustizia, valori artistici generalmente riconosciuti, ecc.), sia di classe, nazionali , professionale, ecc. Naturalmente, nessuna coscienza individuale può accogliere tutta questa diversità di contenuti, una parte significativa della quale, inoltre, rappresenta idee, punti di vista, concetti e atteggiamenti di valore che si escludono a vicenda.
Allo stesso tempo, una data coscienza individuale può essere più ricca sotto diversi aspetti della coscienza sociale. È capace di contenere tali nuove idee, rappresentazioni, valutazioni che sono assenti nel contenuto della coscienza sociale e solo con il tempo possono entrarvi, o non entrare mai. Ma è particolarmente importante notare che la coscienza individuale è caratterizzata da molti stati mentali e proprietà che non possono essere attribuite alla coscienza sociale.
In quest'ultimo, naturalmente, ci sono alcuni analoghi di questi stati, che sono espressi in certi concetti sociali, forme ideologiche, nella psicologia sociale di certe classi e strati sociali. Tuttavia, ad esempio, lo stato di ansia di un individuo è molto diverso da quello che viene descritto come lo "stato di ansia" di un ampio strato sociale.
Le proprietà della coscienza sociale non sono isomorfe alle proprietà della coscienza individuale. Tuttavia, c'è una connessione indubbia tra la descrizione delle proprietà della coscienza individuale e la descrizione delle proprietà della coscienza sociale, perché non esiste una coscienza sociale che esisterebbe al di fuori e in aggiunta alla moltitudine delle coscienze individuali. le proprietà della coscienza individuale e sociale danno origine a due estremi. Uno di essi rappresenta una tendenza alla personificazione del soggetto collettivo, cioè al trasferimento in essa delle proprietà di un singolo soggetto, personalità. L'incoerenza di ciò è stata mostrata da K. Marx sull'esempio della critica di Proudhon: “Il signor Proudhon personifica la società; ne fa una società-persona, una società che è tutt'altro che una società di persone, perché ha le sue leggi speciali che non hanno nulla a che vedere con le persone che compongono la società, e le sue "proprie mente" - non una mente umana ordinaria, ma una mente priva di buon senso. M. Proudhon rimprovera agli economisti di non aver compreso il carattere personale di questo essere collettivo.
Come si vede, K. Marx si oppone a tale descrizione della società, che «non ha alcuna relazione con le persone che compongono la società». Egli mostra che la personificazione della società di Proudhon porta alla sua completa spersonalizzazione, all'ignoranza della composizione personale della società. Si scopre che la "ragione" della società è una specie di entità speciale che "non ha alcuna relazione" con le menti degli individui che formano la società.
L'altro estremo si esprime in un atteggiamento formalmente opposto alla personificazione della coscienza sociale. Comincia dove finisce la personificazione del tipo Proudhon. Qui, la coscienza sociale appare nella forma di alcuni abstract che vivono le proprie vite speciali, al di fuori delle coscienze individuali dei membri della società e le manipolano pienamente.
Abbiamo volutamente rappresentato il secondo estremo in una forma appuntita, poiché, a nostro avviso, esprime un comune filone di pensiero che ha le sue radici nei sistemi filosofici di Platone e di Hegel. Come il primo estremo, porta a una simile mistificazione soggetto sociale e coscienza sociale (gli estremi convergono!), ma a differenza del primo, si basa su una serie di premesse molto reali che riflettono le specificità della cultura spirituale. Abbiamo in mente l'importante circostanza che il quadro categoriale-normativo della cultura spirituale e, di conseguenza, dell'attività spirituale (assunta in qualsiasi sua forma: scientifico-teorica, morale, artistica, ecc.) è una formazione transpersonale. Transpersonale nel senso che è data a ogni nuova personalità che entra nella vita sociale e ne forma le proprietà fondamentali proprio come personalità. Transpersonale nel senso che è oggettivato e continua ad essere costantemente oggettivato nell'organizzazione stessa della vita sociale, nel sistema di attività degli individui sociali, e quindi un individuo non può arbitrariamente modificare o cancellare strutture categoriali storicamente stabilite, norme di attività spirituale e pratica .
Tuttavia, questa circostanza reale non può essere assolutizzata, trasformata in un astratto morto, non storico. Il transpersonale non può essere interpretato come. assolutamente impersonale, in quanto completamente indipendente dalle personalità reali (ora esistenti e viventi). Le strutture esistenti dell'attività spirituale, le norme, ecc. agire per me e per i miei contemporanei come formazioni transpersonali che formano la coscienza individuale. Ma queste stesse formazioni sono state formate, ovviamente, non da un essere superpersonale, ma da persone viventi che hanno creato prima di noi.
Inoltre, queste formazioni transpersonali non rappresentano una sorta di struttura rigida, ordinata in modo univoco e chiusa, cioè una tale struttura che chiude strettamente in sé la coscienza individuale e la tiene prigioniera dei suoi percorsi di movimento e schemi di connessione una volta per tutte predeterminati. Si tratta infatti di una struttura flessibile, sotto diversi aspetti, multivalutata e aperta. Presenta alla coscienza individuale un ampio campo di scelta, la possibilità di nuove formazioni e trasformazioni creative. È di natura storica. Ma questa essenza storica (e quindi creativa) non è visibile quando è assunta in forma “reificata”, come una sorta di struttura “finita”. Si rivela solo nell'esistenza attiva, cioè nella coscienza viva della moltitudine persone reali, e qui è già impossibile non tener conto della connessione dialettica del transpersonale con il personale. Altrimenti cadiamo nel feticismo della conoscenza “ready-made”, “reificata”, che rende una persona schiava degli algoritmi disponibili di pensiero e attività, uccidendo il suo spirito creativo. La conoscenza non può essere ridotta solo ai risultati della cognizione. Come sottolinea S. B. Krymsky, implica anche “una certa forma di possesso di questi risultati”. "Una tale forma può essere solo coscienza dei risultati della cognizione." Di conseguenza, non c'è conoscenza al di fuori della coscienza delle persone reali, e questo elimina immediatamente la “pretesa di oggettivismo astratto, sovrumano”, indica l'importanza fondamentale degli aspetti socio-culturali e personali della ricerca epistemologica.
Siamo pienamente d'accordo con la critica di G.S. Batishchev alla feticizzazione della conoscenza "reificata" e ai modelli semplificati di cultura spirituale. “Solo restituendo al processo attivo le forme oggettivate dal loro isolamento dal mondo del soggetto, solo restituendo tutta la multidimensionalità di questo processo vivente, si può creare quell'atmosfera cognitiva in cui il soggetto acquisisce la capacità di vedere la vera conoscenza in la sua dinamica”. Diversamente, la statica del sapere “ready-made” (e, aggiungiamo, i valori “ready-made”) non è più “un momento rimosso, subordinato del processo dinamico, ma esso stesso lo domina, lo sopprime, lasciando il suo ritmo e multidimensionalità al di fuori dei limiti delle sue strutture congelate, delle loro forme."
Queste parole colgono correttamente le premesse di quel modo di pensare che porta alla separazione delle strutture della coscienza sociale dalle strutture della coscienza individuale e della sua attività, per cui le prime risultano essere nient'altro che forze coercitive esterne in relazione a quest'ultimo.
Quando si considerano le norme sociali, si rivela chiaramente una connessione inseparabile tra coscienza sociale e individuale, transpersonale e personale, oggettivata e soggettivizzata, oggettivata e de-oggettivata. Il sistema normativo come "forma strutturale" della coscienza sociale "diventa realmente normativo" solo nella misura in cui è assimilato da una moltitudine di coscienze individuali. Senza questo, non può essere "realmente normativo". Se esiste solo in una forma oggettivata, oggettivata e non esiste come struttura valoriale della coscienza individuale, se per lui è solo “esterna”, allora questa non è più una norma sociale, ma un testo morto, non un sistema normativo , ma semplicemente un sistema di segni contenente alcune informazioni. Ma in questo modo non è più una "forma strutturale" di coscienza sociale, ma qualcosa di completamente "esterno" ad essa. È possibile che questa sia una precedente "forma strutturale" di coscienza sociale, morta da tempo, il cui contenuto mummificato si trova solo nelle fonti storiche.
Quella che può essere definita una norma sociale per contenuto non è una "forma strutturale" di coscienza sociale, e se questo contenuto è noto alle persone, appare nella coscienza individuale come "giusta conoscenza", che non ha una qualità effettiva di valore, stato motivazionale, privato, secondo O.G. Drobnitsky, "il momento della forza di volontà vincolante".
Qui vogliamo passare a un articolo breve ma molto informativo di V. S. Barulin, che rivela la dialettica della coscienza sociale e individuale dal punto di vista del problema dell'ideale. Crede che "sollevare la questione della coscienza sociale come esterna alla coscienza individuale sia in linea di principio erroneo", "il fenomeno della coscienza - sia sociale che individuale - si fissa solo dove c'è un ideale". “L'essere oggettivo della cultura spirituale è, per così dire, un essere falso, è solo la sua forma esteriore, un altro essere, niente di più. Questi oggetti acquistano la loro essenza, il loro vero significato sociale solo quando si riproducono idealmente nella percezione dell'individuo o degli individui sociali. Quindi tutto ciò che non è "presente", non si riproduce nella coscienza individuale, non è nemmeno coscienza sociale.
Resta solo da aggiungere che qui si apre un aspetto importante del problema dell'ideale. Stiamo parlando del tempo di "vita" di un'idea nella coscienza pubblica e dell'intensità di questa "vita" (alcune idee sono estremamente "influenti", abbracciano milioni di persone, nelle cui menti sono costantemente aggiornate e funzionano; altre idee appena "covate", sempre meno attualizzate nella mente di un numero sempre minore di persone, ecc.), su come le idee "muoiono" (quando non funzionano più nella coscienza individuale da molto tempo, escono dal pubblico coscienza), su come a volte "risorgono" o rinascono (richiamano la storia dell'idea della macchina a vapore) e, infine, sulla comparsa di tali nuove idee, che in realtà si rivelano molto antiche , esistono da tempo, ma sono stati dimenticati. Queste e molte altre questioni simili sono di notevole interesse per l'analisi della dinamica del "contenuto" della coscienza sociale, dei cambiamenti storici in atto nella sua composizione, della sua variabilità e dell'invarianza dei contenuti che si è protratta per molti secoli e anche per tutta la sua storia.
Quindi, la coscienza sociale esiste solo in connessione dialettica con la coscienza individuale. Rendere conto della necessaria rappresentazione della coscienza sociale nella moltitudine delle coscienze individuali è un prerequisito per spiegare il modo di esistenza e il funzionamento della coscienza sociale. Inoltre, è estremamente importante ricordare l'esistenza di contraddizioni tra la coscienza individuale e il pubblico, per non perdere di vista l'"attività" del rapporto della coscienza individuale con il pubblico. A. K. Uledov lo rileva correttamente, sottolineando allo stesso tempo la necessità di studiare un fattore come "caratteristiche individuali dell'assimilazione del contenuto della coscienza sociale".
La connessione della coscienza sociale con l'individuo esprime chiaramente la dialettica del generale e del separato, che mette in guardia contro la mistificazione del "generale" e del "pubblico" (derivante dalla loro rottura con il "separato" e l'"individuo"). Se "la vera connessione sociale... delle persone è la loro essenza umana", ha scritto K. Marx, "allora le persone nel processo di attuazione attiva della loro essenza creano, producono una connessione sociale umana, un'essenza sociale che non è una sorta di forza universale astratta che si oppone al singolo individuo, ma è l'essenza di ogni individuo, la propria attività, la propria vita...».
La "forma strutturale" della coscienza sociale "non è una sorta di forza universale astratta che si oppone all'individuo". Riteniamo necessario sottolinearlo ancora una volta, poiché nella nostra letteratura c'è una feticizzazione dello stato transpersonale della coscienza sociale, a causa della quale il ruolo dell'individuo nella vita spirituale della società viene sminuito. In tali costruzioni, una persona vivente, unico creatore di idee, valori culturali, unico portatore di ragione, coscienza, spirito creativo e responsabilità consapevole, “evapora”, le sue capacità e “autorità” sono alienate a favore dell'uno o dell'altro” forza astratto-universale”.
Gli atteggiamenti concettuali, in cui la coscienza pubblica è eccessivamente contrapposta all'individuo, “spersonalizzano” i processi e le forme della vita spirituale della società, rivelano incongruenze sia in termini ideologici che metodologici. Tali atteggiamenti concettuali impediscono lo studio della coscienza sociale proprio come “sistema storicamente stabilito e storicamente in via di sviluppo”, perché eliminano fattori e “meccanismi” specifici per cambiare la coscienza sociale (nel migliore dei casi li lasciano in ombra).
Pensiamo che un tale modo di pensare teoretico sia il risultato di un eccessivo tributo alla Logica di Hegel, in cui è la “forza astratto-universale” a regnare sovrana su una persona viva, reale: l'Idea Assoluta ad ogni passo dimostra un singola persona la sua assoluta insignificanza. Da qui il tono arrogantemente condiscendente di Hegel quando parla dell'anima individuale: «Le anime individuali differiscono l'una dall'altra per un numero infinito di modificazioni casuali. Ma questo infinito è una specie di infinito cattivo. L'originalità di una persona non dovrebbe, quindi, avere un'importanza eccessiva.
A tal proposito, giustamente T. I. Oizerman scrive: «In Hegel l'individuo è molto spesso dissolto nel sociale. E il grado di questa dissoluzione è interpretato da Hegel come una misura della grandezza dell'individuo. La comprensione marxista di questo problema non va interpretata per analogia con quella hegeliana. La comprensione marxista del problema risiede nel riconoscimento dell'unità dell'individuo e del sociale. L'individuo non può essere considerato un fenomeno secondario, un valore di secondo piano, perché questo porta a una distorsione del concetto marxista di personalità.
I cambiamenti nella coscienza sociale sono determinati, come è noto, dai cambiamenti nella vita sociale. Ma una ripetizione di questo posizione chiave pochi. È necessario specificarlo, mostrare come avvengono cambiamenti qualitativi nel processo della vita spirituale della società, qual è il "meccanismo" per l'emergere di nuove idee, nuove norme morali, ecc. E qui vediamo che l'unica fonte di nuove formazioni nella coscienza sociale è proprio la coscienza individuale. L'unico nel senso che nella coscienza pubblica non c'è una sola idea che non sarebbe stata l'idea della coscienza individuale all'inizio. "La coscienza sociale è creata, sviluppata e arricchita dagli individui". Questa disposizione è di fondamentale importanza per l'analisi di uno specifico “meccanismo” per cambiare il contenuto della coscienza sociale.
Se questa o quella idea riflette correttamente i cambiamenti emergenti nella vita sociale, le tendenze nel suo sviluppo, economico, politico, ecc. interessi di un gruppo sociale, di una classe, di una società, se incarna valori socialmente significativi, allora in questo caso il suo profilo comunicativo inizialmente ristretto si espande rapidamente, acquisisce nuove forme di oggettivazione interpersonale, viene riprodotto intensamente, trasmesso costantemente nei sistemi di comunicazione sociale e gradualmente "conquista le menti e le anime delle persone". Entra così nelle strutture valore-contenuto-attività di molte coscienze individuali, diventa un principio di pensiero interno, “soggettivo”, una guida all'azione, un regolatore normativo per molte persone che formano l'una o l'altra comunità sociale.
Naturalmente, sia nel processo di formazione di un'idea come fenomeno di coscienza pubblica, sia nel suo successivo funzionamento a questo livello, i meccanismi sociali sanzionatori, le varie organizzazioni sociali, istituzioni, istituzioni che effettuano comunicazioni di massa e controllano i contenuti delle informazioni sociali giocano un ruolo primario. A seconda del tipo di idee, più precisamente del sistema delle idee (politiche, morali, artistiche, scientifiche, ecc.), il loro contenuto è oggettivato in modi diversi nei sistemi di comunicazione interpersonale, diffusi, sanzionati, “approvati”, istituzionalizzati attraverso le attività degli enti pubblici speciali.
Anche l'attività di questi organismi non è qualcosa di astratto e impersonale, ma consiste in un'attività regolata in un certo modo di personalità professionali, i cui compiti includono (a seconda della funzione sociale che svolgono) la riproduzione di idee in varie forme oggettivate, il controllo della loro circolazione nei circuiti comunicativi. , adeguamento e sviluppo del loro contenuto, sviluppo di mezzi per aumentarne l'efficacia, ecc. In altre parole, anche nell'ambito dell'attività puramente istituzionalizzata, nell'attività degli organi statali speciali, i fenomeni della coscienza sociale "passano" attraverso i filtri delle coscienze individuali, lasciandovi il segno. La fonte immediata dei cambiamenti nella coscienza sociale risiede nella coscienza individuale.
Cambiamenti sostanziali o nuove formazioni nella coscienza pubblica hanno sempre la paternità. I loro iniziatori sono persone specifiche o un numero di persone. La storia non conserva sempre i loro nomi, quindi intendiamo la paternità in senso generale - come una creazione personale di un'idea, una teoria, un valore culturale. In un certo numero di casi, possiamo identificare con precisione l'autore di un nuovo valore spirituale che è entrato nel fondo della coscienza pubblica. Molto spesso questo vale per il campo dell'arte e della creatività scientifica. La personalità della paternità è particolarmente indicativa per le opere di creatività artistica. Il valore artistico socialmente significativo ha un'integrità speciale, è unico, qualsiasi violazione di esso nei processi di riproduzione lo peggiora o addirittura lo rovina. La collaborazione è rara in questo settore. L'autore di una grande opera d'arte, conosciuto o meno, è, di regola, "solo", unico.
La situazione è diversa nella scienza. I prodotti della creatività scientifica non sono così discreti e isolati in una serie di fenomeni culturali come le opere d'arte. Non sono unici (perché possono essere prodotti indipendentemente da più persone), non sono olisticamente originali come le opere d'arte, perché hanno connessioni logiche e teoriche esterne molto forti e numerose (con altre idee scientifiche, teorie, principi metascientifici) . ).
Quando in una società maturano i presupposti oggettivi per una scoperta, alcune persone vi si avvicinano (ricordiamo, ad esempio, la storia della creazione della teoria della relatività, i risultati di Lorentz, Poincaré, Minkowski). Molto spesso, la paternità è (non del tutto giusta) assegnata a qualcuno che ha espresso nuove idee in modo un po' più completo o più distinto di altri. Tuttavia, l'assenza dell'unicità della paternità non cancella la posizione sulla sua natura necessariamente personale. Lo stesso vale per quei casi in cui un nuovo valore spirituale è frutto dell'attività congiunta di più persone.
Infine, i creatori di tante idee scientifiche, tecniche, artistiche e altro, che spesso sono di fondamentale importanza per la coscienza sociale e, di conseguenza, per la pratica sociale, rimangono sconosciuti e, forse, non saranno mai conosciuti. Ma ciò non significa che le idee corrispondenti siano nate non nella coscienza individuale, ma in qualche altro modo soprannaturale (se escludiamo il trasferimento di conoscenze dall'esterno alla nostra civiltà!).
La situazione della paternità nel campo della creatività morale e dei cambiamenti che essa provoca nella coscienza pubblica è particolarmente difficile. Ma anche qui i ricercatori scoprono sostanzialmente lo stesso “meccanismo” specifico per la formazione di principi, norme e regole morali. La storia mostra che l'emergere di nuovi valori morali e la loro affermazione nella mente pubblica inizia con il rifiuto di individui norme morali prevalenti in quanto non rispondenti, a loro avviso, alle mutate condizioni vita sociale, interessi di classe, ecc. Questo processo, secondo A. I. Titarenko, si realizza "attraverso la violazione di norme e costumi già stabiliti, attraverso azioni che, soprattutto all'inizio, sembravano immorali nella storia".
La storia può indicare molti di questi esempi. “Il ruolo dell'individuo nel modificare il contenuto prescrittivo (comandante) della moralità si svolge principalmente attraverso l'approvazione di una nuova pratica comportamentale da parte di una persona, la commissione di azioni di nuovo tipo, l'adozione di un modo di agire precedentemente sconosciuto. " Ciò richiede, di regola, da parte dell'individuo non solo una profonda convinzione di avere ragione, ma anche coraggio, coraggio, grande forza d'animo e spesso disponibilità a donare la propria vita in nome di nuovi ideali.
"Fare un nuovo tipo di atto" provoca una protesta pubblica. Nuovi atteggiamenti morali vengono prima assimilati dagli strati dell'avanguardia e solo con il tempo diventano proprietà della coscienza pubblica nel suo insieme. Inoltre, nel campo della moralità, come osserva G. D. Bandzeladze, gli atti creativi sono "i più massicci".
Analizzando i processi della creatività morale, O. N. Krutova osserva che, sebbene il processo di formazione di nuove norme morali sia il risultato della creatività individuale, le tracce della partecipazione degli individui ad essa vengono gradualmente cancellate, il contenuto della moralità assume un "impersonale modulo". Questo processo esprime i tratti tipici della formazione dei fenomeni di coscienza sociale come formazioni transpersonali.
Abbiamo sottolineato sopra solo un aspetto della produzione spirituale, che, tuttavia, esprime la sua necessaria componente creativa: il movimento di nuovi contenuti dalla coscienza individuale alla coscienza sociale, dalla forma personale della sua esistenza a quella transpersonale. Ma allo stesso tempo è importante non perdere di vista la compenetrazione dialettica del generale e dell'individuo. Dopotutto, le nuove formazioni creative che hanno luogo nel seno della coscienza individuale non possono essere “libere” da strutture logiche e di valore immanenti alla coscienza individuale, da certi principi, idee, atteggiamenti, ecc., che formano il livello della coscienza sociale. Quest'ultimo, in ogni caso specifico, può svolgere non solo una funzione euristica, ma anche una funzione di parafrasi (fettering). Le nuove formazioni fondamentali nella coscienza individuale (entrambe aventi un alto significato sociale e del tutto prive di esso, ad esempio, ogni tipo di ingenuo-proiettore o innovazioni mistiche, ecc.) violeranno certamente, ricostruiranno queste strutture.
Ma qui è importante tenere a mente la complessità delle strutture logico-categoriche e semantiche di valore della coscienza sociale. Sono estranei all'ordine lineare, includono relazioni sia di dipendenza gerarchica che di coordinamento e competizione, e in un certo numero di punti sono chiaramente di natura antinomica. Ciò si manifesta nella correlazione delle strutture universali, di classe, nazionali, di gruppo della coscienza sociale, che sono "combinate" nella coscienza individuale. Inoltre, le differenze strutturali non sono presentate in esso così rigidamente come nei modi socialmente oggettivati e codificati di esprimere il contenuto effettivo della coscienza sociale.
Qui troviamo una misura storicamente determinata della libertà della coscienza individuale e della sua ineludibile problematicità, e allo stesso tempo della sua intenzione creatrice, per la quale ogni oggettivazione, ogni risultato “predisposto” è solo prodotto intermedio perché conosce solo la realizzazione e non conosce ciò che è stato realizzato, assolutamente compiuto.
Questa intenzione creativa è la caratteristica più importante dell'ideale. Significa una lotta inarrestabile oltre i limiti della realtà oggettiva, nel regno del possibile, desiderabile, migliore, benedetto - lottare per l'ideale.
La ricostruzione di un processo complesso, a più stadi, di formazione di nuovi fenomeni di coscienza sociale (ideologici, scientifici e teorici, ecc.) richiede un'accurata ricerca storica, i cui risultati restano spesso problematici. E. V. Tarle ha scritto: “È improbabile che qualcosa possa essere più difficile per lo storico di un noto movimento ideologico che cercare e determinare l'inizio di questo movimento. Come è nato il pensiero nella coscienza individuale, come ha capito se stesso, come è passato ad altre persone, ai primi neofiti, come è cambiato via via…”. Risposte affidabili a queste domande presuppongono, nelle sue parole, "il percorso di seguire le fonti primarie". E qui è di notevole interesse individuare quei fattori (socio-economici, ideologici, psicologici, ecc.) che hanno contribuito o ostacolato questo processo, quelle collisioni, scontri di opinioni opposte, interessi con cui tanto spesso è segnato. A questo proposito, di solito si apre un altro aspetto del problema: scoprire i veri obiettivi, le motivazioni, le intenzioni. figura storica, indipendentemente da ciò che lui stesso ha scritto e detto di se stesso.
La dialettica dell'individuo e del generale, del personale e del transpersonale costituisce il nodo problematico più importante nella struttura dinamica dell'attività cognitiva. Queste domande sono state ampiamente sviluppate nella nostra letteratura sulla ricerca conoscenza scientifica(opere di B. S. Gryaznov, A. F. Zotov, V. N. Kostyuk, S. B. Krymsky, V. A. Lektorsky, A. I. Rakitov, G. I. Ruzavin, V. S. Stepin, V. S. Shvyrev, V. A. Shtoff, M. G. Yaroshevsky e altri). L'analisi critica dei concetti post-positivisti dello sviluppo della conoscenza scientifica è stata essenziale a questo proposito. Esperienza particolarmente istruttiva Analisi critica Il concetto di "tre mondi" di K. Popper, di cui si è già parlato.
Senza soffermarsi sulle contraddizioni teoriche nelle opinioni di K. Popper, rivelate non solo dai sovietici, ma anche vicini filosofi occidentali Sottolineiamo solo una circostanza fondamentale. K. Popper assolutizza i momenti del “divenire” generale, transpersonale, nella cognizione umana. Egli, secondo la giusta osservazione di N. S. Yulina, in realtà nega "l'essenza creativa autoattiva della coscienza umana". "Si scopre che non sono le persone storiche specifiche dotate di caratteristiche individuali a creare nuove idee che costituiscono il contenuto totale della cultura, ma solo la cultura crea la coscienza individuale".
L'incoerenza dell'operazione di Popper di "scissione" di norme e forme logiche "dalla reale attività delle persone in mondo reale” è mostrato in modo convincente da M. G. Yaroshevsky, la cui ricerca per il nostro scopo è di particolare importanza. Questo si riferisce allo sviluppo da parte sua di un'immagine concettuale della scienza, in cui le coordinate logico-soggetto, socio-comunicative e psicologiche personali dell'analisi del suo sviluppo sono organicamente combinate. È in questo contesto concettuale che M. G. Yaroshevsky esplora la dialettica del personale e del transpersonale, il ruolo delle strutture categoriali del pensiero nell'attività creativa di uno scienziato. Queste strutture categoriali (componenti elemento essenziale coscienza sociale) denota nel corso dell'analisi con il termine “sopraconscio”, poiché lo scienziato spesso non li riflette e perché gli sono dati dalla cultura disponibile. Ma la loro predestinazione non è la loro inviolabilità. Singolo scienziato in corso attività creativaè in grado di modificare queste strutture in un modo o nell'altro, non sempre consapevole della trasformazione categoriale che è stata operata. "Più profondi sono i cambiamenti che questo scienziato ha apportato nel sistema categoriale, maggiore è il suo contributo personale".
“Sarebbe un errore profondo pensare al sovraconscio come qualcosa al di fuori della coscienza. Al contrario, è compreso nel suo tessuto interiore e da esso è inseparabile. Il superconscio non è il transpersonale. In essa la personalità si realizza con la massima pienezza, e solo grazie ad essa assicura - con la scomparsa della coscienza individuale - la sua immortalità creatrice. Modificando le strutture categoriali, una persona contribuisce al fondo della coscienza sociale, che "vivrà" e si svilupperà dopo la sua morte (questo, a proposito, è uno dei significati di "transpersonale"). Ma la coscienza sociale continua a "vivere" ea svilupparsi dopo la morte di ogni individuo particolare, non solo nelle forme oggettivate della cultura, ma certamente nelle coscienze individuali degli individui viventi.
Abbiamo cercato di mostrare il legame inscindibile tra coscienza sociale e coscienza individuale, soffermandoci su una valutazione critica di quegli atteggiamenti concettuali che portano alla loro eccessiva opposizione, all'assolutizzazione del “pubblico” e del “transpersonale”, all'annientamento del vivente, soggetto creativo o a tale troncamento del “personale”, quando si trasforma in funzione di “forme trasformate”, in pietoso burattino del “mondo materiale”, in una sorta di “strumentazione” che nulla ha a che vedere con il originalità, attività creativa e valore intrinseco dell'individuo.
La coscienza è una delle proprietà della materia, consistente nella capacità di riflettere il mondo circostante; è una delle caratteristiche più importanti di una persona e della società. La coscienza è un privilegio umano. Alcuni filosofi riconoscono la conoscibilità della coscienza, altri, al contrario, negano categoricamente tale possibilità, ma il problema della coscienza ha sempre interessato i filosofi. Nel Medioevo era diffusa l'idea dell'inizio spirituale divino della mente e del pensiero delle persone. Dalla metà del 17° secolo, la capacità di sentire e pensare è stata chiamata coscienza, spesso identificata con la cognizione.
La coscienza non è solo individuale, personale, ma include anche una funzione sociale. Struttura coscienza pubblica complesso e sfaccettato, ed è in interazione dialettica con la coscienza dell'individuo. Nella struttura della coscienza sociale si distinguono livelli come la coscienza teorica e quella quotidiana. La prima forma la psicologia sociale, la seconda l'ideologia. La coscienza ordinaria si forma spontaneamente nella vita quotidiana delle persone. La coscienza teorica riflette l'essenza, i modelli della natura circostante e pace sociale. La coscienza pubblica appare in varie forme: visioni e teorie socio-politiche, opinioni giuridiche, scienza, filosofia, moralità, arte, religione. Differenziazione della coscienza pubblica in forma modernaè il risultato di un lungo sviluppo. La società primitiva corrispondeva a una coscienza primitiva, indifferenziata. Il lavoro mentale non era separato dal lavoro fisico e il lavoro mentale era direttamente intessuto nei rapporti di lavoro, in vita di ogni giorno. Le prime nello sviluppo storico dell'uomo furono forme di coscienza sociale come la moralità, l'arte e la religione. Quindi, con lo sviluppo della società umana, sorge l'intero spettro delle forme di coscienza sociale, che viene individuata come una sfera speciale di attività sociale. Forme separate di coscienza sociale: 1) coscienza politicaè un'espressione sistematica e teorica delle opinioni pubbliche sull'organizzazione politica della società, sulle forme dello Stato, sul rapporto tra i vari gruppi sociali, classi, partiti, rapporti con altri stati e nazioni; 2) coscienza giuridica in forma teorica esprime la coscienza giuridica della società, la natura e lo scopo dei rapporti giuridici, delle norme e delle istituzioni, delle questioni legislative, dei tribunali, dei pubblici ministeri. Si pone come obiettivo l'approvazione di un ordinamento giuridico corrispondente agli interessi di una determinata società; 3) moralità- un sistema di opinioni e valutazioni che regolino i comportamenti degli individui, mezzo per educare e rafforzare determinati principi e relazioni morali; 4)art- una forma speciale di attività umana associata allo sviluppo della realtà attraverso le immagini artistiche; 5) religione e filosofia- le forme di coscienza sociale più lontane dalle condizioni materiali. Religione più antico della filosofia ed è una tappa necessaria nello sviluppo dell'umanità. Esprime il mondo circostante attraverso un sistema di visione del mondo basato sulla fede e sui postulati religiosi.
La coscienza pubblica e quella individuale sono in stretta unità. La coscienza sociale è di natura interindividuale e non dipende dall'individuo. Per persone specifiche, è oggettivo. Ogni individuo nel corso della sua vita, attraverso i rapporti con le altre persone, attraverso la formazione e l'educazione, è influenzato dalla coscienza sociale, sebbene non tratti questa influenza in modo passivo, ma selettivamente, attivamente. Norme sociali la coscienza influenza spiritualmente l'individuo, forma la sua visione del mondo, atteggiamenti morali, idee estetiche. La coscienza pubblica può essere definita come una mente pubblica che si sviluppa e funziona secondo le proprie leggi.
Le opinioni dell'individuo, che soddisfano più pienamente gli interessi dell'epoca e del tempo, dopo il completamento dell'esistenza individuale, diventano proprietà della società. Ad esempio, il lavoro di scrittori, pensatori, scienziati eccezionali, ecc. In questo caso, la coscienza individuale, manifestata nel lavoro di una persona in particolare, acquisisce lo stato di coscienza sociale, lo reintegra e lo sviluppa, conferendogli le caratteristiche di un certo era.
coscienza individuale- questa è la coscienza di un individuo, che riflette il suo essere individuale e attraverso di esso, in un modo o nell'altro, essere sociale. La coscienza pubblica è una combinazione di coscienza individuale. Ogni coscienza individuale si forma sotto l'influenza dell'essere individuale, dello stile di vita e della coscienza sociale. Allo stesso tempo, lo stile di vita individuale di una persona gioca il ruolo più importante, attraverso il quale viene rifratto il contenuto della vita sociale. Un altro fattore nella formazione della coscienza individuale è il processo di assimilazione da parte dell'individuo della coscienza sociale. Questo processo è chiamato interiorizzazione in psicologia e sociologia. Pertanto, è necessario distinguere tra due lati diseguali nel meccanismo di formazione della coscienza individuale: l'autonoma consapevolezza di essere del soggetto e la sua assimilazione del sistema di vedute esistente.
La coscienza individuale è determinata dall'essere individuale, sorge sotto l'influenza della coscienza di tutta l'umanità. Ci sono due livelli principali di coscienza individuale:
1. Iniziale (primario) - "passivo", "specchio". Si forma sotto l'influenza dell'ambiente esterno, della coscienza esterna su una persona. Forme principali: concetti e conoscenze in generale. I principali fattori nella formazione della coscienza individuale: attività educative dell'ambiente, attività educative società, attività cognitiva la persona stessa.
2. Secondario: "attivo", "creativo". L'uomo trasforma e organizza il mondo. Il concetto di intelligenza è associato a questo livello. Il prodotto finale di questo livello e la coscienza in generale sono oggetti ideali che appaiono nelle teste umane. Forme di base: obiettivi, ideali, fede. I fattori principali: volontà, pensiero - l'elemento centrale e spina dorsale. Tra il primo e il secondo livello c'è un livello intermedio "semiattivo". Le forme principali: il fenomeno della coscienza - memoria, che è selettiva, è sempre richiesta; opinioni; dubbi.
La coscienza individuale è un'immagine soggettiva del mondo, che si forma in una persona individuale sotto l'influenza delle sue condizioni di vita e delle sue caratteristiche mentali. Ha un'esistenza intrapersonale, che spesso rappresenta un flusso di coscienza sconosciuto. La coscienza pubblica caratterizza le rappresentazioni collettive di comunità e gruppi sociali emergenti sotto l'influenza di fattori transpersonali: le condizioni materiali della società e la sua cultura spirituale.
La differenza tra coscienza individuale e coscienza sociale non significa che solo la coscienza sociale sia sociale. La coscienza individuale è parte integrante della coscienza della società. La cultura storicamente elaborata dalla società nutre spiritualmente la personalità, trasformandosi in una parte organica della coscienza individuale. Ogni individuo è un rappresentante del suo popolo, gruppo etnico, luogo di residenza e la sua coscienza è indissolubilmente legata alla società. Allo stesso tempo, la coscienza sociale si sviluppa solo in un contatto costante con l'individuo, attraverso il suo coinvolgimento nella coscienza realmente funzionante dell'individuo.
La coscienza pubblica ha una struttura complessa. Ci sono due livelli: la coscienza ordinaria e quella teorica.
La coscienza ordinaria è eterogenea nel suo contenuto. Include l'esperienza lavorativa accumulata dalle generazioni precedenti, norme morali, costumi, regolamenti più o meno rigidi nella sfera della vita quotidiana, osservazioni della natura, alcune idee di visione del mondo, arte popolare (folklore), ecc.
La coscienza ordinaria è rivolta principalmente al lavoro, alla vita e alle relative condizioni quotidiane di vita e alle relazioni delle persone. Si distingue per sincretismo, dettagli dettagliati, colorazione emotiva, spontaneità e orientamento pratico. La coscienza ordinaria, che si forma sotto l'influenza diretta degli aspetti quotidiani della vita, è conservatrice, chiusa, dogmatica. La coscienza ordinaria ha capacità cognitive limitate: non è in grado di penetrare nell'essenza dei fenomeni, di sistematizzare i fatti.
La coscienza teorica si basa sull'ordinario, ma ne supera i limiti.
Questi livelli rivelano la struttura della coscienza sociale come momenti nel movimento della cognizione, diversi per il grado della sua adeguatezza all'oggetto. Allo stesso tempo, la coscienza sociale, essendo il risultato dell'attività spirituale delle comunità e dei gruppi sociali, porta l'impronta delle loro capacità soggettive. Psicologia sociale e ideologia sono gli elementi in cui si rivela l'influenza delle caratteristiche dei portatori di coscienza sociale.
37. Il problema della conoscibilità del mondo. Conoscenza e fede. Sviluppo dei concetti di conoscenza nella storia della filosofia.
Conosciamo il mondo? Una persona è in grado di formare un vero quadro della realtà nelle sue idee e concetti?
La maggior parte dei filosofi risponde affermativamente a questa domanda, sostenendo che una persona ha mezzi sufficienti per conoscere il mondo che lo circonda. Berkeley e Hegel, i materialisti francesi del 18° secolo, hanno risolto positivamente questo problema da diverse posizioni e in modi diversi. e Feuerbach, materialisti russi e filosofi marxisti. Questa posizione è chiamata ottimismo epistemologico.
Tuttavia, ci sono filosofi che negano la possibilità di una conoscenza affidabile. Questa posizione è chiamata agnosticismo (greco - inaccessibile alla conoscenza, inconoscibile).
È importante notare che la comprensione dell'agnosticismo come dottrina che nega la possibilità di conoscere il mondo è imprecisa. Difficilmente si possono nominare filosofi che neghino completamente una tale possibilità. L'agnosticismo dovrebbe essere definito come una dottrina che nega la possibilità di una conoscenza affidabile dell'essenza dei sistemi materiali, delle leggi della natura e della società.
Elementi di agnosticismo erano contenuti nel relativismo (dal greco - relativo - un principio metodologico, consistente nel riconoscimento della relatività e della convenzionalità di tutta la nostra conoscenza) degli antichi sofisti greci. Accettata la tesi di Eraclito sulla fluidità, la variabilità di tutte le cose, Protagora riteneva che anche la conoscenza delle cose fosse mutevole e fluida, e quindi di qualsiasi cosa si può dire "in due modi e in modo opposto". Pertanto, non c'è nulla di vero, così come non c'è nulla di falso. Ci sono tante opinioni sulla stessa cosa quante le persone la percepiscono: come sembra a qualcuno, è davvero così; qualsiasi giudizio su una e quella cosa è equivalente a qualsiasi altra.
Il relativismo dei sofisti è servito come fonte diretta di scetticismo antico (dal greco - considerare, indagare - un concetto filosofico che mette in discussione la possibilità di conoscere la realtà). Il rappresentante dello scetticismo, Pyrrho, credeva che le cose non possono essere comprese né dai sentimenti né dalla ragione, e quindi non possiamo preferire una conoscenza su di esse. Non solo i sentimenti sono ingannevoli, anche la mente è ingannevole. Se la conoscenza logica è basata sulla prova, allora si presuppone la verità su cui poggia come fondamento, ma questa verità deve essere essa stessa giustificata da un'altra verità, e così via. Pertanto, nessun giudizio può essere riconosciuto come vero - credevano gli scettici.
Così, né i sofisti né gli scettici hanno negato completamente la conoscenza, hanno negato la possibilità di una conoscenza vera e affidabile, la sua validità generale. Evidenziando il lato soggettivo della conoscenza, la natura relativa della conoscenza, a causa della variabilità delle cose, hanno ignorato la loro relativa stabilità, il contenuto oggettivo delle sensazioni e delle percezioni. Allo stesso tempo, relativismo e scetticismo hanno svolto un ruolo positivo in filosofia e scienza, mettendo in discussione tutto ciò che era dato per scontato senza giustificazione razionale e sollevando importanti problemi filosofici.
Scetticismo - elemento necessario filosofia. Il dubbio, la critica, la negazione mirano al superamento del dogmatismo, all'assolutizzazione delle verità.
Tuttavia, lo scetticismo estremo come concetto filosofico si fonde con l'agnosticismo.
Nella forma più coerente, l'agnosticismo si è manifestato nello scetticismo di Hume. Se gli antichi scettici non mettevano in dubbio l'esistenza del mondo oggettivo, mettendo in discussione il vero e. conoscenza, Hume ha messo in dubbio l'esistenza della realtà stessa. Tutta la nostra conoscenza, credeva, è una percezione sensoriale, oltre la quale fondamentalmente non possiamo andare. Pertanto, è impossibile giudicare quale sia il rapporto tra esperienza e realtà, così come l'esistenza della realtà stessa.
A differenza di Hume, Kant riconosceva l'esistenza di un mondo oggettivo (le cose in sé), ma le considerava inconoscibili. Anche Hume e Kant non negarono completamente la possibilità della conoscenza, limitandola alle percezioni sensoriali.
Nella seconda metà del XIX e nel XX sec. la posizione dell'agnosticismo è caratteristica di alcune correnti filosofiche, nonché di alcune teorie delle scienze naturali: "idealismo fisiologico", "teoria dei geroglifici", ecc.
Per rispondere alla domanda: "Come è possibile una conoscenza affidabile?", dobbiamo innanzitutto considerare l'attività cognitiva, che consiste nel soggetto e oggetto della conoscenza e il processo cognitivo stesso.
Come tutti gli opposti, conoscenza e fede non possono esistere separatamente. Qualunque cosa facciamo, sono presenti insieme in ogni nostra azione e persino in ogni pensiero. Per credere in qualcosa, devi in qualche modo conoscere l'argomento in cui credi. A sua volta, la conoscenza inizia sempre con disposizioni date per scontate senza alcuna prova, con postulati e assiomi.
Nel pensiero filosofico medievale, la questione del rapporto tra fede e conoscenza era una delle più importanti. La priorità della fede sulla conoscenza è stata difesa da Agostino e altri rappresentanti della patristica, e la conoscenza sulla fede è stata difesa dagli scolastici (ad esempio Tommaso d'Aquino). Nell'era dell'Illuminismo e della Nuova Era, la ragione, non la fede, fu proclamata la vera fonte della conoscenza. Nella filosofia classica tedesca, ad esempio, in Kant si può trovare una separazione della fede religiosa da ogni altra, che si trova anche nella scienza. Filosofia moderna(positivismo, neopositivismo) si basa principalmente sull'ideale scientifico della conoscenza, sebbene in alcuni movimenti (esistenzialismo, fenomenologia, ecc.) vi siano pensatori che difendono la priorità della fede, come modo di intendere, sulla conoscenza. Il problema dell'interazione tra fede e conoscenza, religione e scienza è ancora aperto e attuale in connessione con il fenomeno della "crisi del paradigma" del pensiero scientifico.