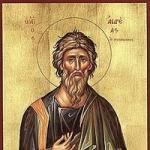Icone della Russia: Crocifissione. Dalla storia dell'iconografia della crocifissione
Legno, pavolok, gesso, tempera, 25*30 cm


Prezzo 0
Misura 17*21 cm 25*30 cm altro Doratura completamente priva di aloni
L'icona "La crocifissione di Gesù Cristo" ci rimanda alla storia evangelica dell'esecuzione di Cristo mediante crocifissione. Nel primo capitolo del Vangelo di Matteo, un angelo appare a Giuseppe e dice: "E gli porrai nome Gesù, perché sarà lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati". Salvare le persone dal peccato è lo scopo del Sacrificio compiuto dal Signore.
Al centro dell'icona c'è una croce marrone piatta con il Cristo crocifisso. Gli occhi di Gesù sono aperti, a simboleggiare la sua divina immortalità. Gli angeli si librano sopra la croce e ai suoi lati ci sono Maria e Giovanni in lutto in mantelli scuri.
La collina alla base della croce con un teschio umano al suo interno segna il luogo dell'azione: il Monte Golgota. Questa è una bassa collina fuori città dove venivano eseguite le esecuzioni pubbliche. Secondo la leggenda, Adamo fu sepolto su questa collina. Golgota significa teschio in aramaico. Cristo crocifisso sul Calvario simboleggia la vittoria sui peccati di Adamo e la morte derivante dal peccato originale.
Le lettere greche all’interno dell’aureola di Gesù Cristo, WON, significano “chi sono” o “che esiste”. Geova è uno dei nomi di Dio con cui chiamò se stesso quando invitò Mosè a condurre il popolo d'Israele fuori dall'Egitto.
Per acquistare un'icona della Crocifissione di Cristo o fare una domanda, inviaci un messaggio. I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco.
Uno degli eventi principali della Passione di Cristo è la crocifissione di Gesù Cristo, che pose fine alla vita terrena del Salvatore. La stessa esecuzione mediante crocifissione era il metodo più antico per trattare i criminali più pericolosi che non erano cittadini romani. Lo stesso Gesù Cristo fu ufficialmente giustiziato per un attentato alla struttura statale dell'Impero Romano: invitò a rifiutarsi di pagare le tasse a Roma, si dichiarò Re dei Giudei e Figlio di Dio. La crocifissione stessa fu un'esecuzione dolorosa: alcuni condannati potevano restare appesi alla croce per un'intera settimana fino alla morte per soffocamento, disidratazione o perdita di sangue. In sostanza, ovviamente, i crocifissi morirono di asfissia (soffocamento): le loro braccia tese fissate con chiodi non permettevano il riposo dei muscoli addominali e del diaframma, provocando edema polmonare. Per accelerare il processo, alla maggior parte dei condannati alla crocifissione furono rotti gli stinchi, causando così un affaticamento estremamente rapido di questi muscoli.
L'icona della Crocifissione di Cristo mostra: la croce su cui fu giustiziato il Salvatore aveva una forma insolita. Di solito per l'esecuzione venivano utilizzate pile ordinarie, pilastri a forma di T o croci oblique (su una croce di questo tipo fu crocifisso l'apostolo Andrea il Primo Chiamato, per cui questa forma della croce ricevette il nome di "Sant'Andrea"). La croce del Salvatore aveva la forma di un uccello che vola verso l’alto, indicando la Sua imminente Ascensione.
Alla Crocifissione di Cristo erano presenti: Nostra Signora la Vergine Maria. Apostolo Giovanni il Teologo, donne portatrici di mirra: Maria Maddalena, Maria di Cleopa; due ladroni crocifissi alla sinistra e alla destra di Cristo, soldati romani, spettatori della folla e sommi sacerdoti che si burlavano di Gesù. Nell'immagine della Crocifissione di Cristo, Giovanni il Teologo e la Vergine Maria sono spesso raffigurati in piedi davanti a Lui: Gesù crocifisso si rivolge a loro dalla croce: ordinò al giovane apostolo di prendersi cura della Madre di Dio come sua madre, e la Madre di Dio ad accogliere come figlio il discepolo di Cristo. Fino alla Dormizione della Madre di Dio, Giovanni onorò Maria come sua madre e si prese cura di lei. A volte la croce del martire di Gesù è raffigurata tra altri due crocifissi, sui quali sono crocifissi due criminali: un ladro prudente e un ladro pazzo. Il ladro pazzo insultò Cristo e gli chiese beffardamente: “Perché tu, Messia, non salvi te stesso e noi?” Il prudente ladro ragionò con il suo compagno, dicendogli: “Siamo condannati per la nostra azione, ma Lui soffre innocentemente!” E, rivolgendosi a Cristo, disse: “Ricordati di me, Signore, quando ti ritroverai nel Tuo Regno!” Gesù rispose al ladrone saggio: “In verità, in verità ti dico, sarai con me nel Paradiso!” Nelle immagini della Crocifissione di Cristo, dove ci sono due ladri, indovina chi di loro è pazzo. e chi è prudente è abbastanza semplice. La testa chinata impotente di Gesù indica la direzione in cui si trova il ladro prudente. Inoltre, nella tradizione iconografica ortodossa, la traversa inferiore rialzata della croce del Salvatore punta al ladro prudente, suggerendo che il Regno dei Cieli attendeva quest'uomo pentito, e l'inferno attendeva il bestemmiatore di Cristo.
Sulla maggior parte delle icone della Crocifissione del Salvatore, la croce del martire di Cristo si trova sulla cima della montagna e sotto la montagna è visibile un teschio umano. Gesù Cristo fu crocifisso sul monte Golgota - secondo la leggenda, fu sotto questa montagna che il figlio maggiore di Noè, Sem, seppellì il teschio e due ossa di Adamo, il primo uomo sulla Terra. Il sangue del Salvatore dalle ferite del Suo corpo, cadendo a terra, filtrando attraverso il suolo e le pietre del Golgota, laverà le ossa e il cranio di Adamo, lavando così via il peccato originale che gravava sull'umanità. Sopra la testa di Gesù c'è la scritta “I.N.C.I” - “Gesù di Nazaret, Re dei Giudei”. Si ritiene che l'iscrizione su questa tavola sia stata fatta dallo stesso Ponzio Pilato, che vinse l'opposizione dei sommi sacerdoti e degli scribi ebrei, i quali credevano che con questa iscrizione il prefetto romano della Giudea avrebbe mostrato un onore senza precedenti all'uomo giustiziato. A volte, invece di "I.N.Ts.I", sulla tavoletta è raffigurata un'altra iscrizione - "Re della gloria" o "Re della pace" - questo è tipico delle opere dei pittori di icone slavi.
A volte si ritiene che Gesù Cristo sia morto a causa di una lancia che gli ha trafitto il petto. Ma la testimonianza dell'evangelista Giovanni il Teologo dice il contrario: il Salvatore morì sulla croce, prima di morire bevve aceto, che gli furono portati su una spugna dai beffardi soldati romani. Ai due ladroni giustiziati insieme a Cristo furono rotte le gambe per ucciderli rapidamente. E il centurione dei soldati romani Longino trafisse con la lancia il corpo del morto Gesù per assicurarsi della sua morte, lasciando intatte le ossa del Salvatore, il che confermò l'antica profezia menzionata nel Salterio: "Non una delle Sue ossa sarà rotta!". Il corpo di Gesù Cristo fu deposto dalla croce da Giuseppe d'Arimatea, nobile membro del Santo Sinedrio che professava segretamente il cristianesimo. Il centurione pentito Longino si convertì presto al cristianesimo e in seguito fu giustiziato per aver predicato sermoni che glorificavano Cristo. San Longino fu canonizzato martire.
Gli oggetti che in un modo o nell'altro hanno partecipato al processo della crocifissione di Cristo sono diventati sacre reliquie cristiane, chiamate Strumenti della Passione di Cristo. Questi includono:
- La croce su cui Cristo fu crocifisso I chiodi con cui fu inchiodato alla croce Le tenaglie che servirono per estrarre quei chiodi La tavoletta “I.N.C.I” La corona di spine La lancia di Longino La ciotola di aceto e la spugna con cui i soldati diedero l'acqua a Gesù crocifisso Scala, con l'aiuto della quale Giuseppe d'Arimatea rimosse il suo corpo dalla croce, le vesti di Cristo e i dadi dei soldati che si divisero le sue vesti.
Ogni volta, facendo il segno della croce, disegniamo nell'aria un'immagine della croce, con riverenza e inesprimibile gratitudine ricordando l'impresa volontaria di Gesù Cristo, che con la sua morte terrena ha espiato il peccato originale dell'umanità e ha dato speranza alle persone per la salvezza.
Le persone pregano l'icona della Crocifissione di Cristo per il perdono dei peccati, si rivolgono ad essa con pentimento.
La capacità di leggere e scrivere era un privilegio molto più grande di adesso. Pertanto, le immagini venivano utilizzate per diffondere e spiegare alcune idee religiose. Pertanto, l'icona della crocifissione veniva spesso chiamata il Vangelo raffigurato o il Vangelo per gli analfabeti. In effetti, in questa immagine i credenti potevano vedere alcuni dettagli e simboli fondamentali della fede. La composizione è stata sempre ricca e ha dato alle persone l'opportunità di pensare al cristianesimo e ai cristiani di essere più ispirati e ispirati dalla fede.
La trama e il significato dell'icona della crocifissione di Gesù Cristo
Lo sfondo dell'icona della Crocifissione di Gesù Cristo è spesso scuro. Alcuni potrebbero associare questo dettaglio con una rappresentazione simbolica dell'oscurità dell'evento, tuttavia, in realtà qui vengono catturati eventi autentici. In effetti, secondo le prove, quando Cristo fu crocifisso, la luce del giorno si oscurò davvero: tale era il segno ed è questo fatto che si riflette nell'immagine.
Inoltre, lo sfondo può essere diametralmente opposto, solenne: dorato. Sebbene la crocifissione sia un fatto triste (anche le persone presenti nell'immagine oltre a Cristo sono spesso raffigurate con gesti di dolore e volti in lutto), è questa impresa di redenzione che dà speranza a tutta l'umanità. Quindi anche questo evento è in definitiva gioioso, soprattutto per i credenti.
L'icona canonica della crocifissione di Cristo, di regola, include molte figure aggiuntive oltre a quella principale. Particolarmente caratteristico è l'uso di caratteri e dettagli aggiuntivi per le opere realizzate prima del periodo dell'iconoclastia. Mostrato:
- La Madre di Dio è molto spesso alla destra del Salvatore;
- Giovanni il Teologo - uno dei 12 apostoli e 4 evangelisti, dall'altra parte della croce;
- due ladri crocifissi fianco a fianco su ciascun lato, Rach, che credette proprio alla crocifissione, divenne la prima persona salvata da Cristo e ascese al cielo;
- tre soldati romani si trovano di fronte dal basso, come sotto una croce.
Le figure di ladri e guerrieri sono spesso raffigurate di dimensioni più piccole di altre. Ciò enfatizza la gerarchia dei personaggi presenti, determinando quale di essi ha maggiore importanza.
Inoltre, la differenza di dimensioni determina in una certa misura le peculiari dinamiche della narrazione. Infatti, fin dai tempi antichi, l'icona, compresa la crocifissione del Signore, non è stata solo l'immagine di qualche evento, ma anche un simbolo di fede, una breve affermazione dei principali dettagli dell'insegnamento. Quindi l’icona potrebbe diventare una sorta di alternativa al Vangelo, ecco perché parliamo di narrazione attraverso l’immagine.

Sulla parte superiore dell'icona “La Crocifissione di Gesù Cristo” ci sono due rocce ai lati. Possono essere in qualche modo simili alle rocce visibili su molte icone del Battesimo del Signore, dove simbolicamente indicano il movimento spirituale, l'ascesa, ma qui le rocce svolgono una funzione diversa. Stiamo parlando di un segno durante il periodo della morte di Cristo: un terremoto, che si manifestò proprio quando il Salvatore fu crocifisso.
Prestiamo attenzione alla parte superiore, dove si trovano gli angeli con le braccia tese. Esprimono dolore, ma anche la presenza delle forze celesti sottolinea il significato di questo evento e trasferisce la crocifissione di Cristo da semplice questione terrena a fenomeno di ordine superiore.
Continuando il tema del significato dell'evento della crocifissione, ricordiamo l'icona, dove rimangono solo la croce e i dettagli principali. Nelle immagini più semplici non ci sono personaggi secondari, di regola rimangono solo Giovanni Evangelista e la Vergine Maria. Il colore di fondo è l'oro, che sottolinea la solennità dell'evento.
Dopotutto, non stiamo parlando di una persona crocifissa, ma della volontà del Signore, che alla fine si è compiuta nell'atto della crocifissione. Pertanto, la verità stabilita dall’Onnipotente è incarnata sulla terra.
Da qui la solennità dell'evento e la solennità dell'icona della crocifissione di Gesù Cristo, che porta anche alla gioia successiva: la risurrezione di Cristo, dopo di che per ogni credente si apre l'opportunità di ottenere il Regno dei Cieli.

In che modo aiuta l'icona della Crocifissione di Cristo?
Le persone che sentono i propri peccati si rivolgono molto spesso a questa icona con le preghiere. Se ti sei reso conto della tua colpa in qualcosa e vuoi pentirti, allora la preghiera davanti a questa immagine non solo può aiutarti, ma anche guidarti sulla retta via e rafforzarti nella fede.
Preghiera al Signore Gesù crocifisso
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, Creatore del cielo e della terra, Salvatore del mondo, eccomi, indegno e più peccatore di tutti, piegando umilmente il ginocchio del mio cuore davanti alla gloria della Tua Maestà, canto lodi a la croce e la tua sofferenza, e il ringraziamento a te, re di tutti e Dio, ti offro, poiché ti sei degnato di sopportare tutte le fatiche e ogni tipo di problemi, disgrazie e tormenti, come un uomo, affinché tu sia tutto il nostro compassionevole Aiutatore e Salvatore in tutti i nostri dolori, bisogni e amarezze. Sappiamo, Maestro onnipotente, che tutto questo non ti è stato necessario, ma per la salvezza umana, affinché tutti potessimo riscattarci dall'opera crudele del nemico, hai sopportato la croce e la sofferenza. Che ti ripagherò, o amante degli uomini, per tutto ciò che hai sofferto per me a causa di un peccatore; Non lo sappiamo, perché l’anima e il corpo e tutto ciò che è buono vengono da Te, e tutto ciò che è mio è Tuo, e io sono Tuo. Proprio nel tuo innumerevole e misericordioso Signore, spero nella misericordia, canto la tua ineffabile longanimità, magnifico la tua imperscrutabile stanchezza, glorifico la tua incommensurabile misericordia, adoro la tua purissima Passione e, baciando amorosamente le tue ferite, grido: abbi pietà di me peccatore e rendimi non sterile nel ricevere la tua Santa Croce, affinché condividendo qui con fede le tue sofferenze, possa essere degno di vedere la gloria del tuo Regno nei cieli! Amen.
Preghiera alla Santa Croce
Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità, concedendo vittorie ai cristiani ortodossi contro l'opposizione e preservando la tua residenza attraverso la tua croce.
Tropario al Signore Gesù Cristo crocifisso
Fino a poco tempo fa si credeva che l'immagine della Crocifissione non apparisse nell'arte cristiana finché esisteva l'esecuzione della croce. E solo presumibilmente dal V secolo, quando l'umanità civilizzata finalmente lo lasciò nel passato e i suoi ricordi divennero leggenda, allora compaiono le prime immagini della sofferenza di Cristo, e dapprima molto condizionate, come se fossero accenni, e non nel forma di scene reali. Tuttavia, non molto tempo fa, nella città di Iruña Veleya, nel nord della Spagna, è stato scoperto un frammento di argilla raffigurante la Crocifissione, presumibilmente risalente al III secolo d.C. . E presto seguì una scoperta ancora più sorprendente - in Terra Santa, che la stampa si affrettò a riferire: sul Monte degli Ulivi, una spedizione archeologica scoprì una presunta tomba paleocristiana, in cui fu ritrovata una croce. Queste scoperte, tuttavia, non hanno ancora ricevuto stime attendibili da parte degli esperti, ma anche prima di loro alcuni ricercatori ritenevano che le prime immagini della Crocifissione risalgano al I-III secolo.Tono 1 Salva il tuo popolo, o Signore, e benedici la tua eredità, concedendo vittorie contro la resistenza e preservando la tua vita attraverso la tua croce.
I monumenti più famosi giunti fino a noi risalgono solo al V secolo. Ne citiamo qui due: la Crocifissione sul rilievo di una porta della Chiesa di Santa Sabina a Roma e su una tavoletta del British Museum. L'immagine sull'avoria britannica è espressiva, rappresentando un rilievo della stessa epoca, con un programma iconografico già sviluppato della Crocifissione. Sulla porta romana ci sono semplicemente tre figure umane con le braccia tese a croce, una delle quali, quella centrale, è più grande delle altre due. Pertanto l’affermazione di Yu.G. è del tutto infondata. Bobrova: “L’immagine della crocifissione storica con la figura di Cristo cominciò a diffondersi solo dopo le decisioni del Concilio Ecumenico del 692, che abolì le sostituzioni simboliche dell’immagine di Cristo”. I monumenti stessi confutano tali opinioni.
Così, il monaco Anastasio, abate del Monte Sinai, (c. 600–695), scrisse un'opera polemica contro i monofisiti, “Guida”, illustrandola con un'immagine della Crocifissione. Allo stesso tempo, Anastasio fu il primo a utilizzare il crocifisso greco, cioè una croce a otto punte.
È possibile essere d'accordo con V.N. Toporov è che la croce è un segno di morte, funerale (perché è presumibilmente installata sulla tomba come geroglifico di morte, come segno di cancellazione, abolizione, cancellazione, ecc.)? In ogni caso, il “Manuale per un sacerdote” dice il contrario: “La croce sulla tomba di un cristiano ortodosso è un silenzioso predicatore di beata immortalità e risurrezione; piantato nella terra e ascendente al cielo, significa la fede dei cristiani che il corpo del defunto è qui sulla terra e l'anima è in cielo, che sotto la croce è nascosto un seme che crescerà per la vita eterna nel Regno di Dio”. Apparentemente, le persone secolari percepiscono la croce come un segno di morte a causa del fatto che un teschio cominciò a essere raffigurato all'interno della Grotta del Calvario dal IX secolo - secondo N.V. Pokrovsky, un simbolo di morte e non la testa di Adamo, come pensava G.D. Filimonov. "Una croce con la testa di Adamo ai piedi perderebbe ogni significato della croce come simbolo di vittoria e salvezza e riceverebbe un significato completamente opposto", scrive N.V. Pokrovskij. - Quale significato infatti potrebbe avere la testa dell'Adamo salvato, calpestata dalla croce, simbolo di salvezza? È chiaro che il successivo simbolo della morte, avendo sostituito il simbolo più antico sotto l’influenza di un ammorbidimento dei concetti, ricevette, sotto la stessa influenza, un’interpretazione della testa di Adamo del tutto estranea alla sua natura”. Tuttavia, l’opinione di Filimonov è confermata negli scritti dei primi autori cristiani. La tradizione della sepoltura di Adamo sul Golgota è nota fin dal III secolo d.C. Origene, ad esempio, vedeva la Divina Provvidenza nella coincidenza dei luoghi di sepoltura del progenitore e della crocifissione del Signore. La ragione principale di questa conclusione per il famoso teologo alessandrino furono le parole dell'apostolo Paolo: “Come la morte avviene per mezzo dell'uomo, così attraverso l'uomo è la risurrezione dei morti. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti vivranno in Cristo” (1 Cor 15, 21–22). Tertulliano la pensava allo stesso modo. San Basilio Magno, spiegando il termine “luogo della fronte”, ci ha parlato di una leggenda non scritta secondo la quale il teschio di Adamo sarebbe stato sepolto sul Golgota. Anche molti apocrifi raccontano la stessa cosa, con l'unica differenza che secondo alcuni Adamo fu sepolto sul Calvario dagli angeli, secondo altri da Set, che vi trasferì il corpo dei suoi genitori dopo il diluvio, secondo per altri la testa finì sul Calvario insieme al diluvio delle acque A questo proposito, dovremmo ricordare le eloquenti leggende sull'albero della croce, che crebbe dal grano - dal seme che Seth mise nella bocca del defunto Adamo. La gente poi sradicò l'albero e lo portò a Gerusalemme per costruire un tempio. Poi si scoprì: le radici erano penetrate nel cranio di una persona sconosciuta. La testa venne separata dalle radici e gettata via. Ma durante una caccia fu ritrovata dal re Salomone, che decise di riportare il ritrovamento a Gerusalemme. Così fecero, ricoprendo devotamente il teschio di pietre (ora sono riprodotte quasi naturalisticamente dagli artigiani della chiesa ai piedi di numerosi “calvari”). E il legno fu poi utilizzato per realizzare la Croce su cui fu crocifisso Gesù Cristo. Il sangue sgorgato dalle ferite del Signore irrorò il capo di Adamo e lavò il peccato ancestrale. L'altare per Proskomedia simboleggia il luogo dell'esecuzione nel tempio dove Cristo soffrì sulla croce e dove è sepolto il teschio del colpevole della Caduta. Pertanto, G.D. era davvero così sbagliato? Filimonov?
Passiamo ad altri dettagli della Crocifissione. Nei tempi antichi, sia gli artisti dell'Europa occidentale che quelli bizantini lo dipingevano con lo stesso numero di chiodi: quattro, cioè ogni mano e piede del Salvatore era inchiodato con un chiodo separato. Ma a partire dal XII secolo in Occidente i piedi cominciarono ad essere raffigurati sempre più spesso impilati uno sopra l'altro e forati con un solo chiodo. Questo dettaglio si trasformò rapidamente in una delle differenze significative tra la crocifissione ortodossa e quella cattolica. Così, il granduca Vasily Vasilyevich nel 1441 informò il patriarca di Costantinopoli Mitrofan, accusando il metropolita Isidoro di Mosca, firmatario dell'unione con Roma, che lui, tornato a Mosca, durante la processione alla Cattedrale dell'Assunzione, ordinò di portare davanti di lui il Crocifisso latino, sul quale furono trafitti con un chiodo i piedi del Signore. Il pittore di icone greco Theotokopouli, che si trasferì in Spagna nel 1576 e lì senza dubbio si convertì al cattolicesimo, diventando il famoso artista El Greco, era “imbarazzato” ogni volta che lavorava alla Crocifissione. In quasi tutti i dipinti di questo soggetto la seconda gamba di Cristo è talmente immersa nell'ombra che è difficile capire se uno o due chiodi abbiano trafitto i piedi del Crocifisso (ill. 1).
La domanda naturale è: per quale motivo la tradizione orientale e quella occidentale divergevano nella rappresentazione di questo dettaglio iconografico? Gli ortodossi spiegano le caratteristiche dell'immagine con la fedeltà alla tradizione storica: la croce portata dalla regina Elena da Gerusalemme a Costantinopoli aveva segni di quattro chiodi, il che significa che i piedi di Cristo erano inchiodati ciascuno separatamente. Per i cattolici, la base sono i tre chiodi della Crocifissione, conservati in Vaticano, e successivamente i dati della Sindone di Torino, nelle cui impronte il piede sinistro è posizionato così a destra che è del tutto possibile supporre che erano trafitti da un chiodo.Queste contraddizioni iconografiche interreligiose sono spiegate dalla ricerca scientifica del XX secolo. L'autorevole chirurgo francese Pierre Barbet, che studiò attentamente il sudario e la differenza tra le impronte del piede destro e sinistro, concluse che il piede destro era abbastanza chiaramente distinguibile, ma era impresso solo il tallone del sinistro perché quando venivano tirati i chiodi fuori e il corpo fu avvolto nel sudario, il sangue, scorrendo giù, inondò il tallone del piede. Barbe giunse ad una conclusione inequivocabile: le gambe del Crocifisso erano inchiodate con due chiodi. La comunanza di tale esecuzione è stata confermata dai ritrovamenti archeologici a Giv'at ha-Mivtar, un sobborgo di Gerusalemme, dove nel 1968, durante la costruzione di una strada, un bulldozer distrusse un antico cimitero con i resti di 35 corpi sepolti lì nel 50-70 d.C. Tra l'altro è stato ritrovato un ossario contenente le ossa di un uomo crocifisso. Il suo nome era Johanan. Gli scienziati hanno stabilito in modo affidabile che anche le gambe del malato erano forate con due chiodi diversi.
Possiamo quindi concludere: l'iconografia ortodossa ha una solida base storica e l'adesione alla tradizione della chiesa ha nuovamente messo in imbarazzo l'arrogante razionalismo nella comprensione dei fatti. Tuttavia, per ragioni di obiettività, va notato: i cattolici non sono così categorici riguardo alle immagini della Crocifissione. Ad esempio, una croce del Tempio di San Damiano ad Assisi (XII secolo) - una delle principali reliquie dell'Ordine francescano, dipinta da un ignoto artista umbro - con quattro chiodi (ill. 2). Una crocifissione simile può essere vista nella chiesa di San Nicola di Myra a Kiev. Ci sono altri monumenti. Ciò significa che per i cattolici a quei tempi non era così importante. Ecco perché, a quanto pare, El Greco, portando nell'ombra la seconda gamba del Salvatore, non aveva molta paura di essere accusato di scisma greco davanti all'allora onnipotente Inquisizione, e Zurbaran generalmente dipingeva le gambe del Salvatore, sebbene incrociato, ma trafitto da due chiodi.
Parliamo un po' delle mani. Tutte le icone mostrano chiaramente come le mani del Salvatore sono inchiodate alla Croce. Oggi è risaputo che è impossibile per una persona rimanere sulla croce se è inchiodato come il Salvatore sulle icone della Crocifissione. Le piccole ossa delle palme, soprattutto nel punto della loro connessione, non sono in grado di sostenere il peso del corpo umano: cadrà dalla croce, come confermato da Barbet attraverso numerosi esperimenti da lui effettuati in teatro anatomico. Dalle tracce di sangue sulla Sindone di Torino, il chirurgo francese ha dimostrato che in realtà i crocifissori piantavano chiodi tra l'ulna e il radio dell'avambraccio, vicino al polso. Tuttavia, sulle icone ortodosse, i chiodi vengono conficcati esclusivamente nei palmi di Gesù. Questo è canonico. Davvero i bizantini non conoscevano la “tecnologia” di tale esecuzione? No, sappiamo già che anche dopo il regno dell'imperatore Costantino, le persone continuarono a essere crocifisse sulle croci. Pertanto, il punto qui non è l'assenza o la presenza di esperienza reale, e nemmeno di realismo storico, ma la saturazione dell'immagine con significato e significato simbolici. Prestiamo attenzione alla posizione delle mani dei ladri. Cosa vediamo? Nelle immagini antiche, le loro mani sono spesso tirate dietro la schiena e legate al pilastro verticale della croce o semplicemente su entrambi i lati della traversa (Fig. 3). Pertanto, i pittori di icone sottolineano consapevolmente le caratteristiche dell’immagine delle mani del Salvatore. Nella teologia patristica esiste un termine kenosi, che significa stanchezza, umiliazione, sminuire Dio. La teologia dogmatica considera il Golgota il punto più alto della kenosi. È logico presumere che il punto più basso della caduta umana sia la crocifissione del Figlio di Dio da parte delle persone. L’umanità ha piantato chiodi forgiati proprio nelle mani che hanno nutrito e abbeverato gli affamati, guarito i disperati, dato alle persone grazia e"tenere" l'universo stesso. Le mani trafitte del Salvatore servono come indicazione, da un lato, dell'incommensurabile altezza dell'umiltà e della kenosi e, dall'altro, della folle insolenza e ingratitudine dell'orgoglio umano. Se i pittori di icone avessero seguito il percorso della “verità della vita”, spostando i chiodi dai palmi delle mani al punto in cui erano stati effettivamente conficcati, questo significato sarebbe stato offuscato. Ma si è rivelato così importante per la Chiesa che ha deciso di trasformarlo nel canone dell'icona della Crocifissione.
Un notevole dettaglio distintivo tra la Crocifissione cattolica e quella ortodossa è la corona di spine sulla testa del Salvatore. La stragrande maggioranza delle icone russe e bizantine di tutti i secoli non ha la corona. In via eccezionale, si possono segnalare due immagini: l'VIII secolo del Monastero di Santa Caterina del Sinai e il XIV secolo del rito festivo della Cattedrale di Santa Sofia a Veliky Novgorod. Ma queste deviazioni dal canone, a causa del loro numero esiguo, possono essere ignorate.
N.V. Pokrovsky credeva che la priorità nel dipingere la corona appartenesse agli artisti cattolici; iniziarono a raffigurarlo “nei secoli XII-XIII per esaltare l’aspetto sofferente del Crocifisso”. Questo eccezionale iconografo ovviamente non sapeva dell'esistenza della menzionata icona del Sinai. Critico e restauratore d'arte contemporanea V.V. Filatov, al contrario, suggerisce che “da Gerusalemme questa caratteristica fu portata nell’Occidente cattolico dai crociati e lì si stabilì saldamente nell’iconografia”. Ma gli stessi ortodossi, fino al XVII secolo, rifiutarono la corona sulla Crocifissione (lasciamo le eccezioni tra parentesi). Per quanto ne sappiamo, nel XVII secolo fu trovato per la prima volta solo nel Vangelo di Siya.
Anche l’inclinazione della testa del Salvatore era di fondamentale importanza. Sulle icone ortodosse la vediamo piegata verso la spalla destra (Fig. 4), tuttavia, gli artisti occidentali, seguendo il "realismo", spesso raffiguravano la testa senza inclinazione, guardando direttamente lo spettatore, e se la raffiguravano chinata, spesso il petto, ma anche dritto. La ragione di questa specificità ortodossa non può ancora essere spiegata in modo soddisfacente. Dovresti prestare attenzione a due opzioni per rappresentare gli occhi del Salvatore. In un caso gli occhi sono chiusi, nell'altro (più spesso nei monumenti antichi) sono aperti. Sembra che qui i pittori di icone bizantini ponessero un’enfasi diversa: il Salvatore, con gli occhi aperti, ricorda la Sua immortalità divina, e con gli occhi chiusi, offre la Sua vita per “le Sue pecore”.C'è anche un collegamento tra la Crocifissione e la liturgia. Abbastanza presto (dal V al VI secolo) nell'iconografia di questa immagine compaiono figure di guerrieri ai lati della Croce. Uno di loro dà al Salvatore una spugna con aceto e l'altro lo trafigge con una lancia (ill. 5). Nella stragrande maggioranza delle antiche icone ortodosse, questa ferita si presenta sul lato destro. Allo stesso modo, durante la proskomedia, la prima particella viene prelevata dall'agnello eucaristico dal lato destro proprio in connessione con la perforazione del costato destro del Signore. Inoltre, l'arma con cui il sacerdote rimuove le particelle è chiamata “lancia” e nella forma ricalca effettivamente la punta di quest'arma. "L'interpretazione del significato simbolico della ferita inflitta a Cristo da Longino, e del sangue e dell'acqua che ne fuoriescono, risale ad Agostino", riferisce A. Maykapar. "Il sangue santo e l'acqua sono simboli dei santi sacramenti: l'Eucaristia e il battesimo, e proprio come Eva fu creata da una costola presa da Adamo, così i due principali sacramenti cristiani furono versati dalla costola forata di Cristo, questo Nuovo Adamo." A volte sulle icone antiche puoi vedere un angelo che raccoglie il sangue e l'acqua che fuoriescono dalla ferita del Salvatore in una coppa (ill. 5, 9). Ciò sottolinea ulteriormente il tema eucaristico. Catena evento reale – liturgia – icona del tutto ovvio, e ogni anello in esso testimonia la sua inseparabilità.
Gli artisti medievali non collocavano solo i guerrieri sulla croce. Dal III, e non dal VI secolo, come comunemente si crede, vi furono raffigurati la Madre di Dio e Giovanni, il futuro teologo; successivamente furono dipinte Maria Maddalena, Maria di Giacobbe, Maria di Cleopa e Salomè (tre di loro stava alla Croce, anche se gli artisti a volte dipingevano di più). Le loro immagini profonde possono essere viste sul mosaico nella nicchia del naos nel monastero di Nea Moni (Chios; 1050 circa), sull'affresco serbo della chiesa della Vergine Maria a Studenica (1209), sull'icona bizantina dal reliquiario del cardinale Vissarion (metà XV secolo). Dionigi presentò espressamente i tre portatori di mirra anche nella Crocifissione per la Cattedrale della Trinità del Monastero Pavlo-Obnorsky (1500) (ill. 6). E da nessuna parte, prima dei tempi del declino, esiste quasi una messa in scena teatrale, con i propri cari che sostengono la Vergine Maria esausta, come spesso si trova nella pittura cattolica. Ovunque il Purissimo non muore di dolore, ma "muore con suo Figlio", come disse l'archimandrita Agafangel (Dogadin), sopportando coraggiosamente il dolore più grande quando "il ferro passò attraverso la sua anima". La scena sensuale del "morire" sminuisce l'impresa spirituale della Madre di Dio, se non la priva del tutto di questa impresa. Nonostante la loro natura intelligente, anche gli angeli, che solitamente si librano sopra la Croce e si coprono il volto con un himation, hanno compassione di Cristo. Il monaco Giovanni di Damasco conferma per loro la potenziale opportunità di piangere: "Essendo al di sopra di noi, incorporei e liberi da ogni passione corporea, essi, tuttavia, non sono imparziali, perché solo il Divino è imparziale". Dionisio ha un altro registro di angeli, ma non in lutto, ma impegnato con l'istituzione della Chiesa sotto forma di una figura femminile in rosso e l'espulsione della Sinagoga sotto forma di una donna in una maforia cremisi che torna indietro (ill. 7 ). Sia la Chiesa che la Sinagoga hanno le stesse aureole. La vocazione di entrambi è radunare le persone nel nome di Dio. Secondo Dionigi, presso la Croce la Chiesa riceve i suoi sacri diritti e la Sinagoga li perde. Tuttavia, non è Dionisio ad avere la priorità nello sviluppo di tale iconografia. La sua genesi è legata all'opera letteraria dei primi scrittori cristiani. In uno di essi, Clemente d'Alessandria, si possono trovare due paragoni: la Chiesa - con una pia donna con molti figli, e la Sinagoga - con una madre che perse numerosi figli a causa della sua incredulità. Successivamente, tale allegorizzazione troverà supporto nelle miniature e poi nella pittura monumentale. Ma nella Rus' diventerà rilevante solo alla fine del XV secolo, in occasione dell'eresia dei giudaizzanti. Prestiamo attenzione anche a come i pittori di icone hanno raffigurato la reazione della natura sull'icona della “Crocifissione”. Senza dubbio hanno trovato la base di ciò nei testi della Scrittura. Come sapete, gli evangelisti parlano dell'oscurità scoppiata dalla sesta alla nona ora (Matteo 27:45; Marco 15:33; Luca 23:44–45). Un dettaglio del genere, a differenza del terremoto avvenuto, è “più conveniente” per i mezzi espressivi della pittura. Pertanto, le immagini del sole e della luna sono state incluse nell'arte sacra dal VI secolo (vedi, ad esempio, il Vangelo di Rabbala, 586), e non sotto forma di intricati personaggi allegorici antichi che galoppano su carri o carri, simili a quelli rinvenuti nei monumenti occidentali, ma sotto forma di volti rotondi (ill. 8). La luna, rimanendo nel cerchio, veniva talvolta raffigurata di profilo. Il sole e la luna sui crocifissi non hanno alcun collegamento diretto con l'antichità e la sua mitologia. Sia nei Vangeli che nella pittura di icone abbiamo a che fare con il carattere escatologico della rappresentazione della natura, ed è per questo che la luna è spesso raffigurata in rosso, e non il sole. Ciò è coerente con le parole dell'Apocalisse: "Ed ecco, ci fu un grande terremoto, e il sole si oscurò come un sacco e la luna divenne come sangue" (Apocalisse 6:12). Troviamo una previsione simile negli Atti dei Santi Apostoli: “Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno grande e glorioso del Signore” (Atti 2:20). Il racconto dell'evangelista Matteo sulla resurrezione dei morti dalle tombe riecheggia senza dubbio il tema del Giorno del Giudizio. Trova un'ampia continuazione nel Vangelo apocrifo di Nicodemo, che influenzò direttamente l'iconografia, soprattutto nel genere delle miniature di libri. Rappresentativa a questo riguardo è l'affascinante storia delle resuscitate Karin e Leukia, che qui vengono interpretate come i figli di Simeone il Ricevitore di Dio. Ma nella pittura di icone tali immagini sono piuttosto rare. Molto più spesso, a partire dal V-VI secolo, gli isografi dipingevano ladroni crocifissi su entrambi i lati di Cristo (ill. 9). I loro nomi sono conservati nelle fonti antiche, ma tutti chiamano i ladri in modo diverso. Nel Vangelo arabo dell'infanzia del Salvatore questi sono Tito e Dumas; nel Vangelo di Nicodemo - Dismas e Gestas; in Erminia Dionysius Furnoagrafiot - Thesda il Gerico e Dima il Galileo; in un manoscritto del XVI secolo della biblioteca di Novgorod Sofia - Arag e Gesta; nella Parola sulla sofferenza e la morte di Cristo secondo i manoscritti dei secoli XVI-XVII - Dismas e Gevsta; negli originali dedicati alla passione del Signore - Dijmon ed Esta. Nella Rus', il prudente ladro sulle porte dell'altare settentrionale era designato come Rakh, ma, secondo Pokrovsky, questo nome non è associato ad alcuna fonte letteraria. La sua origine è sconosciuta. Per enfatizzare il significato gerarchico dell'immagine centrale, la maggior parte dei pittori di icone ha cercato di identificare iconograficamente e mostrare le differenze tra il Salvatore e i ladroni, anche in dettaglio. Pertanto, l'indumento principale che copriva la nudità dello sfortunato non era una benda, ma un perizoma; Come già accennato, i ladri spesso non venivano inchiodati alle croci, ma piuttosto legati; sulla miniatura del Vangelo della biblioteca universitaria di Atene (XII secolo) vediamo il Signore con una croce a sette punte e i ladroni con una a quattro punte. Molto probabilmente, c'erano una serie di altre differenze che non sono state prese in considerazione qui. Un'ulteriore differenziazione avvenne direttamente tra i ladri: all'inizio del Medioevo, il malevolo Gestas era raffigurato con la barba, più tardi - il prudente Dismas, perché agli albori del cristianesimo si riflettevano ancora antichi concetti di bellezza, e con lo sviluppo di Nella visione del mondo cristiana, la barba divenne uno dei segni importanti dell'immagine di Cristo nell'uomo (ricordiamo che a questo è collegata almeno la resistenza dei vecchi credenti russi a radersi la barba).In conclusione è necessario sottolineare soprattutto l'importanza dei dettagli iconografici, anche se non li abbiamo considerati tutti. Come insegnano i santi padri, nella Chiesa non c'è e non può esserci nulla di superfluo. Quindi è nell'icona. Ella è conseguenza dell'Incarnazione, è fonte di comprensione della Divina Sapienza, perché in Lei tutto è annunziato dal cielo e compreso dalla coscienza conciliare. Potremmo vederlo nell'esempio di una delle immagini pittoresche centrali della chiesa ortodossa.
25 / 06 / 2007
L'esecuzione mediante crocifissione fu mutuata dai Romani dai Persiani; fu applicata esclusivamente agli schiavi ed esistette almeno fino alla seconda metà del IV secolo. È generalmente accettato che sia stato abolito dall'imperatore Costantino il Grande dopo il 319, che firmò una legge che vietava l'uccisione degli schiavi (come riportato dai suoi contemporanei Aurelio Vittore, Cassiodoro, Sozomeno). Ma altri contemporanei - Senofonte di Efeso, Firmico Materno, Pacutus e Caritone - testimoniano l'esecuzione della croce nel IV secolo. come se fosse qualcosa di ordinario. N.V. Pokrovsky scrive: “Questa discrepanza può essere conciliata con il probabile presupposto che l'ordine dell'imperatore, come frutto della sua filantropia personale, non ha ricevuto la sanzione della legge per ragioni a noi sconosciute, e quindi casi individuali di crocifissione di criminali avvenne anche dopo Costantino il Grande. In realtà non esiste una legge del genere nelle Pandette. Anche le pandette non legittimano l'esecuzione sulla croce, benché sia prescritto che i ladri siano giustiziati sul luogo del delitto» ( Pokrovskij N.V. Il Vangelo nei monumenti iconografici. M., 2001, pp. 402–403).
Zaraiskij Vladislav. Due scoperte epocali // http://www.pravmir.ru/article_1161.html.
Bobrov Yu.G.. Fondamenti dell'iconografia dell'antica pittura russa. San Pietroburgo, 1995. P. 143. È necessario un chiarimento anche per un altro pensiero di questo autore: “La Crocifissione è uno dei temi centrali di tutta l'arte cristiana ed è una delle dodici festività che compongono una fila separata dell'iconostasi ” (Ibid. P. 141). La crocifissione, però, non è mai stata e non è “una delle dodici feste”; sull'iconostasi, nel rito festivo, si trova talvolta, ma come una sorta di contrappunto a uno speciale ciclo appassionato. Allo stesso tempo, va sottolineato che il ciclo appassionato è un fenomeno successivo, costituiva la sesta fila più alta, che ha distrutto il significato gerarchico e la struttura dell'iconostasi, per questo motivo non ha messo radici. A volte veniva introdotto direttamente in un rito festivo già esistente, come avvenne a Sofia di Novgorod durante l'ampliamento dell'iconostasi nel XVI secolo.
Ringrazio l'Arciprete Alexander Ranne, Professore Associato dell'Accademia Teologica di San Pietroburgo, per aver segnalato questo monumento.
Ad esempio, il pittore di icone cretese Emmanuel Lampardos nella seconda metà del XVII secolo. raffigurate le mani di Cristo con le dita giunte sulla Crocifissione - simile, come sono raffigurati durante una benedizione, ma per il ladrone prudente sono legati dietro la schiena alla trave verticale della croce, mentre il bestemmiatore ci viene mostrato di schiena, perché è crocifisso rivolto verso la croce, le sue mani sono legato dall'altro lato della traversa.
Kenosi- parola per parola defecazione, vuoto, derivato da vuoto, vuoto, sterile, fragile, senza senso.
Pokrovskij N.V.. Il Vangelo nei monumenti iconografici. P.447.
Filatov V. Fila festosa di Sofia Novgorod. L., 1974, pag. 43.
Nel Nuovo Testamento, come sappiamo, i guerrieri non sono menzionati per nome, ma secondo varie fonti antiche, per quanto abbiamo potuto stabilire, ce ne sono tre: Longino, Stephaton e Calpurnio. Nelle stampe popolari russe, però, figura anche il guerriero Labas, friazin di nascita. Ma nessuno osava negare che le stesse guardie avrebbero potuto chiamarsi così. La Chiesa onora come martire il centurione Longino, la sua memoria è il 16/29 ottobre.
Maikapar Alexander. Soggetti del Nuovo Testamento in pittura: La Crocifissione di Cristo // Arte: Supplemento al giornale “Primo settembre”. 2000. N. 42 (210). Novembre.
Matteo chiama Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Giosia e madre dei figli di Zebedeo (Matteo 27:56). Marco parla di Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore, Giosia e Salome che stanno in lontananza (Marco 15,40). Luca scrive in generale: «Tutti quelli che lo conoscevano e le donne che lo avevano seguito dalla Galilea, stavano da lontano e guardavano questo» (Lc 23,49). Giovanni elenca: “Presso la sua croce stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena” (Giovanni 19:25).
Nominiamo i monumenti più famosi, ma molti meravigliosi affreschi, mosaici e icone rimangono fuori dalla nostra vista per ragioni oggettive.
È vero, nell'icona nominata di Dionisio, Salome, abbracciando Maria, la sostiene.
Nel Salterio slavo di Khludov sono chiamati Karin e Litseosh. Ma il ricercatore tedesco Lipsius li considerava una persona: lo gnostico Leucius Carinus.
Ovunque chiamavamo per primo il ladro prudente. Negli originali iconografici del XVI secolo. porta il nome Barbaro, ma notiamo che fu spesso confuso con un altro ladro: il martire tracio Barbaro, che soffrì sotto Giuliano l'Apostata. E di conseguenza, il ladro prudente a volte si ritrovava raffigurato nei panni di un martire tracio.
Nella pittura di icone ci sono un gran numero di immagini che hanno un forte impatto sulle emozioni e sulla percezione dei credenti. Uno di questi è l'icona della "Crocifissione di Gesù Cristo", la cui foto non è difficile da vedere in qualsiasi galleria ortodossa, e l'immagine stessa si trova in quasi tutte le chiese.
Non è un caso che i soggetti delle immagini iconografiche siano sorti agli albori della formazione del cristianesimo. Le icone compivano la missione dell'illuminazione; nel senso letterale, erano illustrazioni che spiegavano argomenti religiosi. Hanno raccontato ai neo-convertiti eventi importanti e le principali tappe fondamentali nella formazione del cristianesimo. Ciò ha dettato l'aspetto della maggior parte dei soggetti nella pittura di icone, ovviamente, ad eccezione della semplice immagine dei santi, sebbene questa fosse spesso accompagnata da miniature che ne spiegavano le gesta.
Che aspetto ha l'immagine?
L'aspetto dell'icona della "Crocifissione" di Cristo Salvatore non è inequivocabile, l'immagine è scritta in modi diversi. Gli autori utilizzano varie tecniche artistiche, che certamente hanno il loro significato.
La prima cosa che distingue le immagini è lo sfondo. Alcuni autori usano toni scuri e cupi, altri dipingono il crocifisso in oro. Lo sfondo scuro sottolinea contemporaneamente la tragedia di quanto accaduto e trasmette gli eventi reali, perché durante la crocifissione di Gesù il sole si oscurò.
Lo sfondo dorato è usato più spesso dai pittori di icone. Questa ombra è un simbolo del trionfo, l'atto stesso di salvare l'umanità attraverso il sacrificio di Gesù. Simboleggia anche la grandezza dell'impresa del Salvatore in nome delle persone, la sua vittoria sulla morte. La vittoria di Gesù è simbolicamente espressa in un altro dettaglio: il teschio nel terreno, scritto alla base della crocifissione.
Oltre a Cristo, sull'icona sono raffigurati altri personaggi, che completano la sua trama. Anche il loro numero non rimane costante. In ogni immagine è canonicamente presente solo la Madre di Dio; le altre figure e il loro numero variano. Anche le dimensioni indicate sono diverse. La differenza di dimensioni trasmette il loro status, significato e importanza.
Chi altro è raffigurato nell'icona?
L'icona “La Crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo” contiene invariabilmente nella sua trama la figura della Vergine Maria. Di norma, la Madre di Dio è raffigurata dai pittori di icone alla destra di Gesù.

Oltre alla Madre di Dio, la trama dell'immagine è spesso completata da figure:
- Giovanni Evangelista;
- i ladri portati da Gesù in cielo;
- Soldati romani.
Spesso nella parte superiore dell'immagine le potenze celesti sono raffigurate sotto forma di angeli. In opere iconografiche complesse e ricche di dettagli, dietro la crocifissione sono raffigurate rocce, a simboleggiare il terremoto avvenuto durante l'esecuzione. Negli affreschi murali, la trama è spesso completata dai simbolici sole e terra dipinti nella parte superiore lungo i bordi.
La complessità dell'esecuzione e la pienezza dei dettagli sono caratteristiche delle vecchie immagini che svolgevano una missione educativa. Alla fine del Medioevo, l'icona della “Crocifissione” di Gesù Cristo non era più sovraccarica di dettagli, l'enfasi era posta sulla figura centrale, cioè sull'evento più importante di cui narra la trama dell'immagine.
Come è cambiata nel tempo l’immagine del Signore?
La trama della crocifissione è una di quelle chiave del cristianesimo. Di conseguenza, le immagini iconografiche su questo argomento furono tra le prime ad apparire. Naturalmente, l'icona di Gesù Cristo "Crocifissione" è cambiata nell'aspetto nel corso dei secoli, non solo nel numero di dettagli e personaggi raffigurati su di essa. L'immagine stessa del Salvatore è cambiata. I pittori di icone delle prime scuole e del Medioevo raffigurarono il Signore in modi diversi.

Fino alla fine del IX secolo e all'inizio del X secolo, l'icona di Gesù Cristo “Crocifissione”, sebbene fosse eseguita principalmente in colori scuri, il Signore stesso sembrava vivo e trionfante nell'immagine. I palmi erano aperti e le braccia tese, come se Gesù stesse cercando di abbracciare chiunque si avvicinasse all'icona. Dopo il X secolo, l’icona della “Crocifissione” di Gesù Cristo cambia; il Signore è sempre più raffigurato come morto, con le palme piegate o cadenti. Questa interpretazione simboleggia la grandezza dell’impresa del Signore, l’atto della sua morte redentrice e la sua importanza.
Qual è il significato dell'icona?
I credenti pregano il Signore per tutto e con ogni dolore e disgrazia si avvicinano alle immagini di Gesù. Ma non tutte le immagini hanno lo stesso significato di un'icona raffigurante l'atto della crocifissione.

Questa immagine non solo impressiona invariabilmente i credenti, ma influenza anche le loro emozioni. L'icona è una sorta di breve Vangelo, perché racconta eventi lontani che hanno costituito la base della fede cristiana. Questa è una sorta di "programma educativo" per coloro che gravitano verso il Signore, ma non hanno conoscenza del cristianesimo. Cioè, l'immagine della crocifissione è estremamente importante oggi, perché decenni di mancanza di spiritualità in Russia, anni trascorsi, senza esagerazione, nell'idolatria, chiamata partigianeria, hanno praticamente privato le persone della conoscenza elementare e fondamentale dei fondamenti del cristianesimo. I parrocchiani non sempre capiscono nemmeno chi è raffigurato esattamente su un'icona e gli affreschi sono spesso percepiti solo come una versione unica del disegno delle pareti della chiesa.
Di conseguenza, il significato dell'immagine nelle chiese moderne è simile a quello che era secoli fa. L'icona adempie una missione educativa e, naturalmente, rafforza la fede dei parrocchiani, influenzando la loro percezione emotiva e impressionandoli. Per questo motivo l'immagine è una delle prime che i credenti vedono quando entrano nelle chiese appena aperte, restaurate o in fase di ricostruzione.
In che modo un'immagine aiuta?
Ci sono molte immagini del Signore e ognuna di esse ha la sua trama. Il suo contenuto è legato alla comprensione di chi e cosa aiuterà la preghiera davanti a un'icona specifica. In che modo aiuta l'icona della Crocifissione di Gesù Cristo? Acquisendo e mantenendo la fede, nel pentimento e nell'entrare nella retta via.
Da tempo immemorabile, le persone che si sentono in colpa per se stesse, tormentate dal rimorso e dal rimorso, si sono rivolte a questa immagine. Uno stato emotivo deprimente può essere causato da qualsiasi motivo. Non è affatto necessario che un sentimento di pentimento implichi il commettere una cattiva azione. Il pentimento spesso perseguita le persone che non hanno mai fatto nulla di male a nessuno in vita loro. Uno stato emotivo depresso deriva dalla mancanza di comprensione del significato della propria vita e dalla consapevolezza del vuoto spirituale.
La fede nel Signore ti salva da tali emozioni. E la preghiera davanti all'icona raffigurante l'atto della crocifissione ha aiutato nel pentimento fin dai tempi antichi e riempie l'anima con la luce della fede e della gentilezza.
Come pregare davanti all'immagine?
Naturalmente, i servizi canonici si svolgono davanti all'icona raffigurante la crocifissione, viene letto il troparion e vengono eseguite altre azioni ecclesiali. È del tutto possibile per un normale parrocchiano pregare con le sue stesse parole, perché la condizione principale per rivolgersi all'Onnipotente è la sincerità, la franchezza del cuore e la purezza dei pensieri.

Puoi usare questo esempio di preghiera:
“Gesù Cristo, Signore Onnipotente e Misericordioso! Ti prego umilmente, Salvatore delle anime umane. E affido la mia vita a Te. Dimorare nel tuo seno e vedere la vita eterna. Evita la Geenna e le tentazioni che ad essa conducono. Supera i pensieri scortesi. Evita pensieri e azioni empi. Accettami, Signore, insegnami, illuminami, guidami sulla retta via e abbi pietà! Amen".