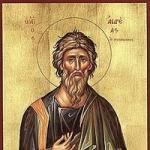Cos'è un'iconostasi: definizione, storia e descrizione. Iconostasi ortodossa: storia e struttura
Oggi, sulla base di antiche tradizioni e interpretandole secondo le loro conoscenze e idee culturali, tenendo conto delle caratteristiche dell'architettura del tempio, compaiono vari tipi di iconostasi. Ma diamo un'occhiata ai componenti dell'iconostasi del tempio moderno generalmente accettato.
Riga inferiore:
Le Porte Reali, a destra di esse c'è l'icona di Cristo, a sinistra c'è la Madre di Dio. A destra dell'icona di Cristo è solitamente collocata l'icona del tempio. Questa è una festa o l'immagine di un santo in onore del quale il tempio è consacrato. Inoltre, dopo le icone locali ci sono le Porte Nord (a sinistra delle Porte Reali) e le Porte Sud (a destra), chiamate anche Porte del Diacono. Raffigurano spesso gli arcangeli Michele e Gabriele; ci sono anche immagini degli arcidiaconi Stefano e Lorenzo, o dei profeti dell'Antico Testamento, dei sommi sacerdoti, del primo ladro prudente entrato in cielo e dei santi venerati nel tempio.
Seconda riga - Grado Deesis:
In realtà, questa serie ha dato origine al concetto stesso di iconostasi. Nella traduzione della parola “deisis” (greco) vediamo la preghiera. E al centro della preghiera c'è l'icona “Salvatore al potere” o “Salvatore sul trono”. Ai lati di Cristo - tre quarti di giro verso di Lui - la Madre di Dio e S. pregano per noi. Giovanni Battista. Poi vengono gli arcangeli, gli apostoli, i santi, i martiri e gli altri santi venerati in un tempio particolare.
A partire dal XVII secolo si assiste all'inversione del rito della Deesis e del rito festivo. Molto probabilmente ciò è stato causato dalla scomoda visualizzazione delle stesse icone delle festività nella terza fila. Ma questo cambiamento sconvolge la gerarchia canonica e si perde il significato evangelico dell'intera iconostasi.
Terza fila - Festiva:
Al centro di questa fila è solitamente posta l'icona dell'Ultima Cena. E ai lati ci sono le vacanze. Si tratta solitamente delle dodici feste: Natività della Vergine Maria, Ingresso al Tempio, Annunciazione, Natività di Cristo, Presentazione, Battesimo, Trasfigurazione, Ingresso del Signore in Gerusalemme, Ascensione di Cristo, Dormizione della Vergine Maria, Esaltazione della Attraverso.
Quarta fila - Profetica:
Qui sono collocate le icone del re Davide, di Salomone, del profeta Elia e di altri profeti che prefigurarono la venuta di Cristo. Nei gamberi tengono dei rotoli con il testo di queste profezie. Al centro di questa fila è solitamente raffigurata l'icona della Madre di Dio “Il Segno”. Oppure la Vergine Maria seduta in trono. Dipende dalla forma delle icone dei profeti stessi: a mezzo busto o a figura intera.
Quinta fila - Antenati:
Qui sono collocate le icone degli antenati: da Adamo a Mosè. Al centro è posta l'icona della “Trinità dell'Antico Testamento”. È un simbolo del sacrificio di Dio Verbo per espiare i peccati umani.
Croce o crocifisso- incoronare l'iconostasi. A volte ai lati del crocifisso sono raffigurati la Madre di Dio in piedi e l'apostolo Giovanni il Teologo.
Non c'è una sola cosa o azione in una chiesa ortodossa che non abbia un significato spirituale. Compresa l'iconostasi e la cortina delle Porte Reali, sono “partecipanti” a pieno titolo al servizio divino.
Qual è il significato di questi oggetti nel microcosmo di una chiesa ortodossa?
L'architettura e la decorazione interna di una chiesa ortodossa sono, per così dire, il paradiso in terra. Questo è un modello del mondo spirituale - il Regno dei Cieli - che il Signore ci ha rivelato attraverso il santo profeta Mosè sul monte Sinai. Allora Dio comandò che il tabernacolo dell'Antico Testamento fosse creato secondo il modello chiaro che aveva dato a Mosè fin nei minimi dettagli. La chiesa ortodossa del Nuovo Testamento ha la stessa struttura dell'Antico Testamento, con la differenza che nostro Signore Gesù Cristo si è fatto uomo e ha compiuto l'opera di salvezza della razza umana. Fu a causa di questo grandioso evento che avvennero dei cambiamenti nel tempio del Nuovo Testamento rispetto all'Antico Testamento.
Ma la struttura in tre parti del tempio è rimasta invariata. Sotto il santo profeta Mosè questi erano: il cortile, il santuario e il Santo dei Santi. Nel tempio del Nuovo Testamento questo è il vestibolo, la parte centrale del tempio e l'altare.
Il portico e la parte centrale del tempio simboleggiano la Chiesa terrena. Tutti i credenti cristiani ortodossi possono essere qui. La parte centrale del tempio corrisponde al santuario dell'Antico Testamento. In precedenza, nessuno tranne i sacerdoti poteva esserci. Ma oggi, poiché il Signore ci ha purificati tutti con il Suo sangue purissimo e ci ha uniti a Sé con il Sacramento del Battesimo, tutti i cristiani ortodossi possono dimorare nella parte centrale del tempio - questo santuario del Nuovo Testamento.
Il Santo dei Santi del Tempio Mosaico corrisponde all'altare nella chiesa del Nuovo Testamento. È un simbolo del Regno dei Cieli. Non per niente è costruito su una collina rispetto alla parte centrale del tempio e al vestibolo. La stessa parola “altus” significa “alto” in latino. Il centro dell'altare è il trono. Questo è il trono su cui Dio stesso siede invisibilmente nel tempio. Il luogo principale della chiesa ortodossa. Anche un sacerdote senza bisogni speciali (servizi divini, servizi) e gli indumenti liturgici necessari (ad esempio una tonaca) non dovrebbe toccarlo: questa è la terra santa, il luogo del Signore.
Di solito tra l'altare e la parte centrale del tempio viene eretto un muro speciale decorato con icone. Si chiama “iconostasi”. La parola è greca, composta, formata dalle parole “icona” e “stare”. Questa partizione è stata eretta, come alcuni pensano erroneamente, non in modo che non fosse visibile ciò che stava facendo il sacerdote sull'altare. Ovviamente no. L'iconostasi ha un significato liturgico e spirituale molto specifico.
La pratica di costruire iconostasi è molto antica. Secondo la tradizione ecclesiastica, il primo che ordinò di coprire l'altare con una tenda fu San Basilio Magno nella seconda metà del IV secolo. Ma le partizioni tra l'altare e la parte centrale del tempio erano note anche prima. Ad esempio, nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.
Il tipo moderno di iconostasi si formò praticamente nell'arte sacra all'inizio del XV secolo.
Allora, cosa significa l'iconostasi in senso spirituale e liturgico?
Simboleggia il mondo dei santi e degli angeli: il Regno dei Cieli, ancora inaccessibile a noi. Questo è il luogo e lo stato d’animo a cui dobbiamo tendere. Il Regno dei Cieli per noi – che viviamo sulla terra – è ancora separato e inaccessibile. Ma ogni cristiano ortodosso è obbligato ad andare da lui e ad adoperarsi con l'aiuto dei mezzi salvifici che la Chiesa e il suo Capo - Cristo - ci offrono.
La separazione visiva dell'altare dalla parte centrale della chiesa dovrebbe motivarci a tendere lì, verso la montagna, e questo desiderio è il nucleo della vita di ogni cristiano ortodosso. Crediamo che un giorno il Signore misericordioso aprirà le porte del cielo e ci condurrà in esso, come un Padre che ama suo figlio...
D'altra parte, le icone dell'iconostasi ci raccontano la storia della salvezza del genere umano da parte di nostro Signore Gesù Cristo. Ad esempio, l'iconostasi può essere a uno o più livelli. Nel primo ordine al centro ci sono le Porte Reali. Questo è anche il luogo di Dio. Anche il sacerdote non ha il diritto di attraversarli: solo nei paramenti e in orari di servizio rigorosamente definiti. A destra e a sinistra ci sono le cosiddette porte del diacono. Il clero e il clero possono entrare nell'altare attraverso di loro. Sono detti diaconi perché attraverso di loro i diaconi escono dall'altare e vi rientrano durante la recita di particolari preghiere (litanie) davanti alle Porte Reali. A destra delle Porte Reali è posta l'icona del Salvatore, e a sinistra della Santissima Theotokos; sulle porte stesse del diacono, di regola, ci sono le icone dei santi Arcangeli Michele e Gabriele - questi diaconi celesti di Dio, o i santi diaconi del primo martire e arcidiacono Stefano e del martire Lorenzo. Meno spesso: altre icone. Dietro il cancello del diacono a destra c'è un'icona del tempio.

Se nell’iconostasi è presente un secondo livello, questo viene chiamato “livello Deesis”. "Deisis" tradotto dal greco significa "preghiera, petizione". Spesso abbiamo una forma errata di traduzione in russo moderno di questa parola: "Deesis". Al centro della fila è raffigurato Cristo Pantocratore (Pantocratore) sul trono, alla sua destra (se visto dal tempio, quindi a sinistra) c'è la Santissima Theotokos in posa orante, e a sinistra ( se dal tempio, allora a destra) è il santo Profeta, Precursore e Battista del Signore Giovanni anche lui con le mani stese in preghiera. Poi ci sono le icone di vari santi, anche in pose di preghiera, di fronte al Salvatore. Possono essere raffigurati vari santi della Chiesa ortodossa, molto spesso questi sono i 12 apostoli.
Direttamente sopra le Porte Reali si trova l'icona dell'Ultima Cena, che divenne la prima liturgia celebrata da Dio stesso. Questo è un simbolo del servizio principale della Chiesa e del tempio, compreso il servizio della Santa Eucaristia: il Corpo e il Sangue di Cristo.
Se nell'iconostasi è presente un terzo livello, su di esso vengono posizionate le icone delle dodici feste. Simboleggiano la salvezza di Cristo dell’umanità caduta. Meno comuni (solo nelle grandi cattedrali) sono il quarto e il quinto livello. Nella quarta fila sono raffigurati i santi profeti, nella quinta gli antenati (i santi antenati Adamo ed Eva, i patriarchi Abramo, Isacco, ecc.). Al centro della fila superiore dell'iconostasi c'è un'icona della Santissima Trinità, ed è coronata dalla Santa Croce come strumento principale della nostra salvezza.
Il velo in chiesa si chiama con la parola greca “katapetasma” (tradotto come “tenda”). Separa le Porte Reali ai lati dell'altare dal Santo Trono.
Tutto nel tempio: sia le Porte Reali che il sipario hanno un significato rigorosamente definito.
Ad esempio, le Porte Reali sono, per così dire, le porte di Cristo. Ecco perché su di esse vengono spesso poste icone rotonde dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria e dei quattro santi evangelisti: predicano il vangelo del Dio-uomo Cristo. L'apertura delle Porte Reali durante il servizio e il passaggio del clero attraverso di esse è un simbolo del fatto che il Signore è presente nel tempio e benedice coloro che pregano.
L'inizio della veglia notturna. Dopo l'ora nona, le Porte Reali si aprono e il sacerdote incensa in silenzio, poi proclama la glorificazione della Santissima Trinità e altre preghiere statutarie davanti al trono, quindi esce dall'altare attraverso le Porte Reali e incensa l'intero tempio, le icone, e gente che prega. Tutto ciò simboleggia l'inizio della Storia Sacra, la creazione del mondo, dell'umanità. La collocazione dell'altare da parte del sacerdote e dei fedeli simboleggia che Dio era in paradiso con le persone e che queste comunicavano direttamente e visibilmente con Lui. Dopo la censura, le Porte Reali vengono chiuse. Ebbe luogo la Caduta e le persone furono espulse dal paradiso. Le porte si aprono di nuovo ai Vespri, viene fatto un piccolo ingresso con un turibolo: questa è la promessa di Dio di non abbandonare le persone che hanno peccato, ma di inviare loro il Suo Unigenito Figlio per la salvezza.
È lo stesso nella Liturgia. Davanti al piccolo ingresso si aprono le Porte Reali, simbolo dell'ingresso di Cristo nella predicazione, quindi dopo di questo e poco dopo vengono letti l'Apostolo e il Vangelo. Il Grande Ingresso con il Calice e la Patena è l’uscita del Salvatore verso la sofferenza sulla Croce.
Chiusura del catapetasma prima dell’esclamazione “Usciamo di qui. Santo dei Santi” è un simbolo della morte di Cristo, della deposizione del Suo corpo nella tomba e della chiusura della tomba con una pietra.
Ad esempio, molti servizi quaresimali si svolgono non solo con le porte reali chiuse, ma anche con il sipario chiuso. Questo è un simbolo del fatto che l'umanità è stata espulsa dal paradiso, che ora dobbiamo piangere e lamentarci dei nostri peccati davanti all'ingresso chiuso nel Regno dei Cieli.
L'apertura sia del sipario che delle Porte Reali durante il servizio pasquale è un simbolo del ripristino della comunione perduta con Dio, della vittoria di Cristo sul diavolo, della morte e del peccato e dell'apertura della via verso il Regno dei Cieli per ognuno di noi.
Tutto ciò ci dice che nel culto ortodosso, così come nella struttura del tempio, non c'è nulla di superfluo, ma tutto è armonioso, armonioso ed è progettato per condurre il cristiano ortodosso nelle stanze celesti.
Sacerdote Andrey Chizhenko
L'aspetto della cortina dell'altare è associato alla costruzione del tabernacolo dell'Antico Testamento e del tempio di Gerusalemme. Preparato da ortox.ru e dall'architetto Kesler M.Yu.
L'aspetto della cortina dell'altare è associato alla costruzione del tabernacolo dell'Antico Testamento e del tempio di Gerusalemme. L'interno del tabernacolo era diviso in due parti da quattro colonne di legno di acacia, ricoperte d'oro, fissate su basi d'argento; su questi pilastri era appesa una tenda. Dietro il velo, nel Santo dei Santi, dove solo il sommo sacerdote entrava una volta all'anno, si trovava l'arca contenente le tavole dell'Alleanza. Anche il Tempio di Gerusalemme era diviso in due stanze da un tramezzo di legno di cedro: quella esterna - il Luogo Santo e quella interna - il Santo dei Santi. Una porta con ante in legno d'ulivo, decorata con immagini di cherubini, palme, fiori, ricoperti d'oro, rappresentava l'ingresso al Sancta Sanctorum. Davanti ad esso, come nel tabernacolo, c'era una cortina di stoffa multicolore, sapientemente realizzata.
Ai tempi dei primi cristiani
Le chiese catacombali conservano caratteristiche dell'antica struttura dell'altare e, a questo riguardo, possono fungere da tipo principale di altare cristiano. Nella tomba di S. L'altare di Agnese occupava un intero ambiente - i cubicula - ed era separato dagli altri due da grate, la cui linea è segnata da semicolonne in tufo, sfondate all'ingresso dei cubicula e che fungevano da sostegno alle inferriate. e la linea di confine tra il luogo dei laici e l'altare.
Nelle basiliche paleocristiane l'altare era separato dalla parte centrale da una transenna in marmo a forma di quattro colonne su cui poggiava l'architrave; la barriera era chiamata in greco “templon” o “kosmitis”. Non copriva tanto quanto metteva in risalto l'altare, sottolineandone il significato come luogo di celebrazione del Sacramento. L'architrave era solitamente decorato con intagli raffiguranti viti, pavoni e altre immagini simboliche, e sopra il cancello era posta una croce scolpita o scolpita. Nel corso del tempo, tra le colonne iniziarono a essere collocate icone di Cristo, della Madre di Dio e dei santi. L'imperatore Giustiniano (527-565) complicò la forma della barriera collocando a Santa Sofia di Costantinopoli 12 colonne secondo il numero degli apostoli, e sotto Basilio il Macedone (867-886) apparve sull'architrave un'immagine di Cristo. Entro il 12 ° secolo. era già diffuso un templon a forma di portico con grandi icone del Salvatore, della Madre di Dio e del santo di questo tempio. A volte la deisis (Cristo, la Madonna e Giovanni Battista) veniva posta sopra le Porte Reali. In alcune chiese già nell'XI secolo. appare una serie di dodici festività. Nel tardo periodo bizantino la barriera poteva raggiungere due o tre file (deisis, apostoli e profeti, festività), ma i greci preferivano ancora i templon a un livello. La cortina dell'altare correva sotto l'arco che separava la navata dall'abside dell'altare e solitamente si estendeva ulteriormente a nord e a sud, racchiudendo l'altare e il diacono. Col passare del tempo, la comparsa di un'iconostasi a tre porte ha permesso nelle chiese con un'abside di collocare l'altare direttamente nell'altare, a lato dell'altare.
Nella Rus'
La barriera passò alla Rus' da Bisanzio sotto forma di un'iconostasi a due livelli. In epoca pre-mongola, la parte dell'altare era separata dalla parte centrale del tempio da una bassa barriera di legno o di marmo, decorata, oltre alle immagini di Cristo, della Madre di Dio e di vari santi venerati, con una o due file di icone. L'altare con i suoi dipinti murali rimase aperto alla visione di coloro che pregavano nel tempio.
La prima alta iconostasi è considerata l'iconostasi della Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino di Mosca, composta da tre livelli (in antico russo - ranghi): locale, deisis e festivi. Secondo la cronaca, fu creato nel 1405 da un artel guidato da Teofane il greco, l'anziano Prokhor di Gorodets e il monaco Andrei Rublev. L'aspetto dell'alta iconostasi è associato al nome di quest'ultima: nel 1408 prese parte alla realizzazione dell'iconostasi della Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir, e nel 1425-27. — Cattedrale della Trinità-Sergio Lavra.
Entro la fine del XV secolo. appare il quarto livello: profetico e alla fine del XVI secolo. il quinto sono gli antenati. Entro il 17 ° secolo Il tipo di iconostasi a cinque livelli è stabilito ovunque ed è considerato classico. Tuttavia, sono note iconostasi a sei e sette livelli. L'iconostasi cominciò a includere file appassionate: un'immagine della passione di Cristo. Sopra la fila superiore appare una fila di serafini e cherubini. Grande Cattedrale di Mosca 1666-1667 decise di completare l'iconostasi con la Crocifissione.
L'ulteriore evoluzione delle forme dell'iconostasi è associata allo sviluppo del decoro. Alla fine dei secoli XVII-XVIII. Lo stile barocco con le sue magnifiche e intricate decorazioni arriva in Russia. Le iconostasi erano ricoperte da ricchi intagli, abbondanti dorature, avevano una configurazione bizzarra, includevano altorilievi e persino sculture. Le icone diventano pittoresche, il rigore e la sequenza dei ranghi non vengono rispettati. Alla fine del XVIII secolo. Il barocco è sostituito dal classicismo. L'iconostasi è decorata con colonne, portici e trabeazioni; l'arredamento comprende spesso rilievi e sculture rotonde; il ruolo delle immagini è ridotto al minimo. Dalla metà del XIX secolo. furono erette iconostasi eclettiche in stile “bizantino-russo”. A cavallo tra il XIX e il XX secolo. c'è un ritorno alle barriere dell'altare a un livello: pietra bizantina o legno antico russo. Sono state create anche iconostasi originali, ad esempio, in porcellana o quercia nera.
L'essenza dell'iconostasi: separare - avvicinare
Nell'alta iconostasi delle chiese russe, il simbolismo delle barriere dell'altare delle chiese paleocristiane e bizantine è pienamente realizzato. Simeone di Salonicco scrive: “Pertanto, in cima ai pilastri, kosmitis significa l'unione dell'amore e dell'unità in Cristo... Ecco perché in cima al kosmite, al centro tra le sante icone, è raffigurato il Salvatore e su ai suoi lati ci sono la Madre di Dio e il Battista, gli Angeli e gli Apostoli e altri santi. Questo ci insegna che Cristo è in cielo con i suoi santi e con noi adesso, e che deve ancora venire”. L'iconostasi che separa l'altare dalla parte centrale del tempio esprime l'idea della connessione più stretta e inestricabile che esiste tra il mondo sensoriale e quello spirituale attraverso l'aiuto orante degli esseri celesti raffigurati sulle icone. Con l'avvento dell'iconostasi, l'assemblea dei credenti si trovò letteralmente faccia a faccia con l'assemblea degli esseri celesti, misteriosamente presenti nelle immagini dell'iconostasi. Come nella preghiera eucaristica della liturgia vengono ricordati nella fede gli antenati, i padri, i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori defunti dell'Antico Testamento e poi tutti i credenti viventi nella Chiesa, così l'iconostasi viene continuata dai cristiani riuniti in chiesa.
"La limitazione dell'altare è necessaria affinché non risulti essere nulla per noi", scrive il sacerdote Pavel Florensky (1882-1943). Il cielo dalla terra, ciò che è in alto da ciò che è in basso, l'altare dal tempio può essere separato solo da testimoni visibili del mondo invisibile, simboli viventi dell'unione di entrambi, altrimenti - santi. L'iconostasi è il confine tra il mondo visibile e il mondo invisibile, e questa barriera dell'altare si realizza, resa accessibile alla coscienza da una fila di santi radunati, una nuvola di testimoni che circonda il Trono di Dio... L'iconostasi è l'apparizione di santi e angeli… l’apparizione dei testimoni celesti e, soprattutto, della Madre di Dio e di Cristo stesso nella carne, testimoni che annunciano ciò che è oltre la carne”. L'iconostasi non chiude l'altare ai credenti nel tempio, ma rivela loro l'essenza spirituale di ciò che è contenuto ed eseguito nell'altare. Questa essenza consiste in quella divinizzazione alla quale sono chiamati e tendono i membri della Chiesa terrena e che i membri della Chiesa celeste, rivelata nell'iconostasi, hanno già raggiunto. Le immagini dell'iconostasi mostrano il risultato dell'avvicinamento a Dio e dell'unità con Lui, verso il quale sono diretti tutti gli atti sacri della Chiesa di Cristo, compresi quelli che si svolgono all'interno dell'altare.
Rivelare l'Economia Divina
L'iconostasi nel suo insieme rivela gradualmente le vie della Divina Rivelazione e l'attuazione della salvezza - dalla sua pre-preparazione negli antenati di Cristo nella carne e dalla sua prefigurazione da parte dei profeti. Ciascuna delle file rappresenta un certo periodo della storia sacra, correlato all'eterno - la sua immagine centrale - l'apice della pre-pianificazione e della profezia. Attraverso immagini visibili, l'iconostasi conduce alla fila festosa - il compimento di ciò che è stato preparato e oltre alla fila dove tutto è rivolto a Cristo. Su un piano, facilmente osservabile da diversi punti e coperto da un unico sguardo, l'iconostasi rivela la storia dell'uomo, l'immagine del Dio Uno e Trino e il cammino di Dio nella storia. Secondo p. Pavel Florensky: “I cammini della Divina Rivelazione e la realizzazione della salvezza vanno dall'alto al basso... In risposta alla Divina Rivelazione, dal basso verso l'alto, ci sono cammini di ascesa umana: attraverso l'accettazione del vangelo evangelico (evangelisti su le Porte Reali), la combinazione della volontà umana con la volontà di Dio (l'immagine dell'Annunciazione qui ed è l'immagine della combinazione di queste due volontà), attraverso la preghiera e, infine, attraverso la comunione al Sacramento dell'Eucaristia , l’uomo realizza la sua ascesa a ciò che rappresenta il rito deisis, all’unità della Chiesa”. «L'iconostasi materiale non sostituisce l'iconostasi dei testimoni viventi e non è posta al loro posto, ma solo come indicazione di essi, per focalizzare su di essi l'attenzione di chi prega... In senso figurato, un tempio senza materiale L'iconostasi è separata dall'altare da un muro cieco, ma l'iconostasi sfonda le finestre al suo interno, e poi attraverso il loro vetro noi... possiamo vedere cosa sta succedendo dietro di loro - testimoni viventi di Dio. Distruggere le icone significa murare le finestre”.
L’iconostasi, quindi, non copre completamente l’altare: al contrario, da un punto di vista spirituale, rivela ai credenti le più grandi verità dell’Economia di Dio sulla salvezza. La comunicazione viva e misteriosa dei santi di Dio, in cui l'immagine di Dio è già stata restaurata, con le persone in piedi nel tempio, in cui questa immagine deve ancora essere restaurata, crea la totalità delle Chiese celesti e terrene.
La sequenza è la chiave del simbolismo
Nell'iconostasi i temi delle icone sono rigorosamente coerenti, sia nel loro insieme che nelle loro singole parti. Nella sua forma classica, l'iconostasi è composta da cinque file di icone sormontate da una croce. L'iconostasi a cinque livelli deve essere vista dall'alto verso il basso. In primo luogo, mostra l’attesa dell’umanità nei confronti del Salvatore promesso da Dio, poi l’apparizione di Cristo nel mondo e l’espiazione da Lui compiuta.
L'iconostasi è coronata dalla Croce di Cristo. Tutta la storia è quindi percepita come un'ascesa al Golgota, dove è avvenuta la salvezza dell'umanità. Il crocifisso all'estremità dell'iconostasi sottolinea che Cristo è il Redentore e il Sacrificio, grazie al quale si ottiene la salvezza.
Le due file superiori - antenati e profeti - mostrano la prefigurazione della Chiesa del Nuovo Testamento negli antenati di Cristo secondo la carne e la sua prefigurazione nei profeti. Ciascuno di questi gradi rappresenta un certo periodo della storia sacra e ciascuno corrisponde alla sua immagine centrale: l'apice dei preparativi e delle profezie.
La fila o ordine superiore degli antenati ci mostra la Chiesa originale dell'Antico Testamento da Adamo a Mosè - il periodo pre-legge, nella persona degli antenati dell'Antico Testamento con i testi corrispondenti sui rotoli spiegati. Qui sono raffigurati gli antenati più vicini al tempo della vita celeste: Adamo (a volte Eva), Abele, Noè, Sem, Melchisedek, Abramo, ecc. Al centro di questo livello c'è l'immagine della Santissima Trinità - l'apparizione di Abramo alla quercia di Mamre, come primo testamento di Dio con l'uomo e prima rivelazione del Dio Uno e Trino, ovvero l'immagine della “Patria”, raffigurante tutte e tre le ipostasi (Padre, Figlio e Spirito Santo) attraverso i simboli disponibili in Cristianesimo.
Di seguito è riportata una serie profetica, che rappresenta la Chiesa dell'Antico Testamento da Mosè a Cristo, il periodo sotto la legge. Qui sono raffigurati capi, sommi sacerdoti, giudici, re, profeti - anche con rotoli spiegati, sui quali sono scritti nelle loro mani i testi delle loro profezie sulla venuta del Salvatore al mondo. L'icona dell'Incarnazione al centro della serie profetica indica un collegamento diretto tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Allo stesso tempo, l'icona "Segno" con l'immagine di Cristo in un medaglione sullo sfondo del grembo della Madre di Dio, a volte la Madre di Dio in trono con il Bambino Gesù in grembo, è diventata un'opzione comune. . Su entrambi i lati ci sono solitamente Davide, Salomone, Daniele, Isaia, Aronne, Gedeone, Ezechiele, Giona, Mosè.
Il livello successivo dell'iconostasi è festivo; rappresenta il periodo del Nuovo Testamento, esprimendo l'adempimento di ciò che era stato predetto nei ranghi superiori. Qui sono raffigurati quegli eventi del Nuovo Testamento che, costituendo il circolo liturgico annuale, sono celebrati in modo particolarmente solenne dalla Chiesa come una sorta di tappe principali dell'azione provvidenziale di Dio nel mondo, la graduale realizzazione della salvezza. Solitamente le “festività” erano disposte nel seguente ordine da sinistra a destra: “Natività della Madre di Dio”, “Introduzione al Tempio”, “Annunciazione”, “Natività di Cristo”, “Candelora”, “Battesimo”, “Trasfigurazione”, “Ingresso in Gerusalemme”, “Ascensione”, “Trinità”, “Assunzione della Madre di Dio”, “Esaltazione della Croce”. Oltre a queste dodici festività, e talvolta al loro posto, questa serie includeva icone su altri soggetti sacri: "Pentecoste", "Protezione", "Discesa agli inferi", ecc.
La fila successiva dell'iconostasi si chiama deisis (“deisis” significa “preghiera”). Il suo tema principale è la preghiera della Chiesa per la pace. Questo mostra il momento della Seconda Venuta di Cristo e del Giudizio Universale. Qui Cristo appare come il giudice del mondo, davanti al quale appaiono per i peccati umani la Madre di Dio, simbolo della Chiesa del Nuovo Testamento, e Giovanni Battista, simbolo della Chiesa dell'Antico Testamento. All'atto della preghiera prendono parte angeli, apostoli, santi e martiri. Cristo è raffigurato seduto su un trono, il cosiddetto "Salvatore al potere". Attraverso il trono “trasparente” si possono vedere le sfere di splendore della gloria celeste. Sullo sfondo sono raffigurati i "poteri celesti": Cherubini e Serafini. Questo rango è la parte centrale e più importante dell'iconostasi.
Il livello inferiore dell'iconostasi è locale. Al suo centro ci sono le Porte Reali. A sinistra del cancello c'è l'icona della Madre di Dio con il Bambino, a destra c'è l'immagine del Salvatore. A destra dell'icona di Cristo c'è una "immagine del tempio", che mostra in onore di quale festa o santo fu consacrata la chiesa. A sinistra dell'icona della Madre di Dio c'è l'icona con la quale puoi determinare quale santo è più venerato in questo tempio.
Porte del Paradiso
Sulle porte nord e sud dell'altare sono raffigurati Arcangeli o santi diaconi, concelebranti durante la celebrazione del Sacramento. Sulla porta meridionale, l'Arcangelo è talvolta sostituito da un ladro prudente, il che sottolinea la comprensione di queste porte come ingresso al Regno dei Cieli, il cui simbolo è l'altare.
Sulle porte centrali - le Porte Reali - è solitamente raffigurata l'Annunciazione e in basso - i quattro evangelisti. A volte le icone dei santi Basilio Magno e Giovanni Crisostomo sono collocate qui con il Vangelo in mano o con un rotolo aperto con testo liturgico. Simbolicamente le Porte Reali rappresentano l'ingresso al Regno di Dio. L'Annunciazione qui è l'inizio che apre all'uomo l'ingresso in questo Regno; è la personificazione del Messaggio che è stato proclamato dagli evangelisti, e qui il loro vangelo si riferisce direttamente alla persona che viene alla Chiesa per unirsi a questo Regno. Qui, sulla solea, al confine tra l'altare e la parte centrale del tempio, avviene la comunione dei credenti. Pertanto, sopra il cancello è posta un'immagine dell'Eucaristia. Durante i servizi divini, le Porte Reali si aprono nell'iconostasi, dando ai credenti l'opportunità di contemplare il santuario dell'altare: il trono e tutto ciò che accade nell'altare.
Creare un'iconostasi: pratica
Nella pratica moderna, le iconostasi sono spesso realizzate in legno o pietra naturale (marmo, arenaria). In alcuni casi viene utilizzata la maiolica o il metallo forgiato.
Nelle iconostasi di tyabla in legno, file continue di icone sono installate tra le travi di legno orizzontali - tyablas. La superficie frontale delle travi può essere dipinta con motivi floreali o decorata con intagli in legno. Un tipo più complesso è un'iconostasi scolpita con un sistema di divisioni orizzontali e verticali, riccamente decorata con intagli in legno, basma, ecc.
Tipicamente, gli intagliatori utilizzano specie legnose comuni: pino, tiglio, quercia, ma a volte vengono utilizzati pero, noce ed ebano. Oggi gli intagliatori utilizzano più spesso incisioni cieche o ad altorilievo, che sono particolarmente decorative. Le sculture in legno possono essere colorate o gessate e rivestite con vernici dorate, argentate e colorate. Le parti inferiori della fila locale sono talvolta ricoperte da tessuti ricamati. Quando si progetta un'iconostasi in legno intagliato, non bisogna lasciarsi trasportare troppo dalle superfici intagliate, ricordando che l'iconostasi è destinata principalmente all'installazione di icone davanti alle quali le persone pregano. La decorazione delle superfici intermedie non dovrebbe far altro che indicare lo splendore delle dimore celesti dove risiedono i santi. In altre parole, l’iconostasi non dovrebbe essere trasformata in una “stasi dell’intaglio”, dove le icone si perdono dietro l’abbondanza di intagli dorati.
Le iconostasi in pietra naturale possono essere a livello singolo o multilivello. Le superfici frontali rivolte verso la parte centrale del tempio sono abbondantemente ricoperte di intagli. In questo caso è possibile utilizzare diversi tipi di pietra naturale, fornendo una ricca combinazione di colori.
Il lavoro di progettazione dell'iconostasi di un tempio di nuova concezione dovrebbe essere svolto contemporaneamente alla progettazione architettonica del tempio stesso. Si inizia con la determinazione dello stile dell'iconostasi, che è correlato all'architettura del tempio progettato. Durante la ricostruzione vengono raccolti disegni d'archivio e fotografie dell'iconostasi dell'antico tempio. Durante il processo di progettazione vengono determinate la posizione dell'iconostasi, le sue dimensioni e la configurazione in lunghezza e altezza, compreso il numero di file. Nelle chiese di piccole dimensioni che hanno una profondità ridotta, è consigliabile installare un'iconostasi bassa per aumentare visivamente la profondità del tempio grazie alla vista della conca dell'abside sopra l'iconostasi.
La struttura dell'iconostasi lignea è in legno di pino, che può essere rinforzata con elementi metallici con una grande apertura che separa l'altare dal tempio stesso. Per prima cosa viene installato il blocco delle Porte Reali, che comprende le porte stesse, i pilastri, il baldacchino e la corona. Successivamente, il corpo dell'iconostasi viene prodotto e installato. La fase finale del lavoro consiste nell'installazione delle icone. Il lato posteriore dell'iconostasi può essere rivestito con compensato o tessuto.
Mikhail Yuryevich Kesler, architetto.
“Pittore di icone” n. 21, 2009
Architetto M.Yu. Kesler
Una formulazione semplice e precisa che definisce l'iconostasi come elemento di una chiesa ortodossa dovrebbe corrispondere a idee abbastanza profonde sul tempio in generale, sull'icona, sul contenuto spirituale e sulla storia dell'iconostasi, sui sacramenti e sul culto della Chiesa ortodossa. Di conseguenza, il tema dell’“iconostasi” può essere divulgato solo in un sistema di approfondimento storico e culturale, quando tutte le questioni sopra individuate vengono affrontate con coerenza e serietà.
Nelle condizioni di un'istruzione scolastica di alta qualità nel campo della storia e della cultura, l'argomento "Iconostasi" può essere dedicato alle lezioni nella sezione (argomento, ciclo) "Tempio ortodosso: struttura interna". Partendo dal presupposto che è proprio in tali condizioni che lavora il nostro lettore, forniamo materiale universale e necessario che può essere utilizzato sia da un insegnante di cultura artistica mondiale che da un insegnante di arte, storia della cultura religiosa o fondamenti della cultura ortodossa.
Se tutte queste materie sono presenti nel curriculum, il docente di storia della cultura religiosa (o dei fondamenti della cultura ortodossa) ne svelerà i contenuti più profondamente nell'aspetto religioso-cognitivo. L'insegnante MHC considererà con gli studenti il lato artistico ed estetico utilizzando esempi specifici, con rinforzo e sostegno per la parte spirituale, significativa e storica, che verrà data dall'insegnante di Storia della cultura religiosa (o dei fondamenti della cultura ortodossa) . L'insegnante d'arte ripeterà le conoscenze già acquisite dagli scolari usando l'esempio di diverse chiese, le collegherà ai luoghi di culto locali e presterà maggiore attenzione all'analisi dell'influenza artistica ed estetica, alle caratteristiche degli stili e allo sviluppo dell'arte della chiesa ortodossa nel mondo moderno. Se tale completezza e qualità dell'educazione culturale non è prevista in nessuna scuola in particolare, allora l'insegnante che dovrà trattare questo argomento dovrà cercare di trasmettere il materiale qui offerto, facendo affidamento solo su se stesso.
E La konostasis è uno degli elementi più importanti e obbligatori di una chiesa ortodossa. L'iconostasi è un tramezzo che separa l'altare dalla parte centrale del tempio, chiamata navata, ed è certamente fiancheggiata da icone. Proprio quest’ultima caratteristica ha dato il nome “iconostasi”, che significa “stare in piedi delle immagini, o icone” (dal greco. eiconostasi: icona - immagine, immagine + stasi - luogo in cui si trova).
Feofan il greco, Andrei Rublev, Prokhor di Gorodets e altri
Iconostasi della Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino di Mosca. XV-XVII secoli
Diagramma delle righe: UN. Fila locale; B. Fila Pyadnichny; IN. Grado di Deesis. Intorno al 1405; G. Fila festiva. Intorno al 1405; D. Serie profetica; E. Litigio degli antenati
Disposizione delle icone: 1. Host; 2. La Madonna in trono; 3. Annunciazione; 4. Natale; 5. Incontro; 6. Pre-sesso; 7. Battesimo; 8. Trasfigurazione; 9. Resurrezione di Lazzaro; 10. Ingresso a Gerusalemme; 11. Ultima Cena; 12. Crocifissione; 13. Sepoltura; 14. discesa agli inferi; 15. Ascensione; 16. Discesa dello Spirito Santo; 17. Dormizione; 18. Basilio Magno; 19. Apostolo Pietro; 20. Arcangelo Michele; 21. Nostra Signora; 22. Cristo Pantocratore;. 23. Giovanni Battista;. 24. Arcangelo Gabriele; 25. Apostolo Paolo; 26. Giovanni Crisostomo; 27. Nikola, con i segni dei miracoli; 28. Nostra Signora di Tikhvin, con segni di miracoli; 29. Arcangelo Uriel. Porta dell'altare nord; 30. Salvatore con la futura Madre di Dio e Giovanni Battista, con i santi nei campi; 31. Cornice dell'icona “Nostra Signora del Don” con l'immagine di donne giuste; 32. passò al trono; 33. Annunciazione della Madre di Dio, con segni acatistici. Icona del tempio; 34. Giovanni Battista, Pietro apostolo e Alessio Uomo di Dio; 35. Arcangelo Raffaele. Porta dell'altare sud; 36. Il Salvatore con i santi Sergio di Radonezh e Varlaam di Khutyn che cadono, con i segni delle parabole; 37. Icona “Quattro parti”. 38–39. Fila di icone degli antenati; 40–41. Fila profetica di icone; 42–43. Una fila di mini tablet; 44. Nikola Mozhaisky; 45. Cintura spa; 46. La resurrezione di Lazzaro.
L’iconostasi non è stata l’invenzione di una persona responsabile o di una figura creativa, né è stata il risultato dello sforzo volontario di un sovrano o di un pastore della chiesa. L'iconostasi divenne portatrice dell'esperienza religiosa di molte generazioni di popoli diversi, della loro ricerca della sistemazione ottimale dell'edificio religioso per realizzare l'obiettivo principale della religione: ripristinare la connessione con il Creatore, interrotta dalla caduta delle prime persone, ripristinare la comunione con Dio. E quindi, nessuna definizione di iconostasi, inclusa quella che proponiamo, può includere l'intero significato e le funzioni dell'iconostasi. Sono inseparabili dalla storia della Chiesa ortodossa, che ha origine dagli eventi dell'Antico Testamento, dalla pratica ecclesiastica (servizi divini, sacramenti ecclesiastici), dall'arte sacra (il significato e lo scopo dell'icona, la sua iconografia e altre caratteristiche).
L'iconostasi si basava su tre idee nate in momenti diversi nella storia religiosa umana, la cui interazione ci ha dato ciò che vediamo oggi nelle chiese ortodosse e chiamiamo iconostasi.
La prima, la più antica delle idee fondamentali dell'iconostasi è associata all'idea di un luogo sacro, isolato dal solito mondo frenetico e accessibile solo agli iniziati. Tali locali esistevano negli edifici sacri anche in epoca precristiana in tutte le culture, tra popoli diversi.
Il tempio del Nuovo Testamento conserva le tradizioni del tabernacolo dell'incontro e della rivelazione dell'Antico Testamento, trasformandolo alla luce della redenzione compiuta dell'umanità da parte del Salvatore del mondo e dell'apertura del Regno dei Cieli. L'immagine del tabernacolo, ricevuta al Sinai dal profeta Mosè, incarnava l'idea di isolare un luogo sacro dove Dio possa dimorare e l'uomo possa comunicare con lui. Il Tabernacolo (un tempio portatile smontato) aveva tre parti principali: 1) il Sancta Sanctorum; 2) Santuario; 3) il cortile del tabernacolo. La parte più sacra del tabernacolo - il Santo dei Santi - simboleggiava il Regno Celeste di Dio, quindi nessuno entrava nel Santo dei Santi del tempio dell'Antico Testamento, tranne il sommo sacerdote, a cui era permesso entrarvi solo una volta all'anno . Qui era conservata l'Arca dell'Alleanza. Il Santo dei Santi era chiuso con una cortina “sordo”, che separava il Regno di Dio dal resto del mondo, anche dal Santuario, in cui ogni mattina e sera veniva bruciata resina profumata - l'incenso - sull'altare dell'incenso a Dio . L'immagine e la struttura del tabernacolo furono trasferite nel tempio stazionario dell'Antico Testamento, costruito a Gerusalemme dal figlio del re Davide Salomone.
IN In una chiesa ortodossa, il Santo dei Santi corrisponde ad un altare. Prima della venuta di Cristo e della Sua espiazione per i peccati umani, nessuno poteva entrare nel Regno dei Cieli, nemmeno i giusti, quindi il Santo dei Santi era chiuso. Con il cristianesimo, una nuova idea entra nel mondo, l'idea del Nuovo Testamento: la redenzione e l'apertura del Regno dei Cieli a tutte le persone attraverso il sacrificio espiatorio di Cristo. Quindi la struttura di culto tradizionale dell'Antico Testamento include questa idea: l'apertura del Regno dei Cieli, che inizia qui sulla terra, dentro di noi.
Uno dei pensieri religiosi e filosofici più importanti è ora accessibile a tutti in un'immagine: il Regno di Dio esiste, ma era chiuso nell'Antico Testamento, rappresentando il più grande mistero di Dio - il mistero della parola divina e dell'amore sacrificale che crea e preserva il mondo. Solo i profeti ne hanno parlato.
Secondo le Sacre Scritture, durante l'espiazione, dopo le parole del Salvatore che rese il suo spirito: "Tutto è compiuto", il sole si oscurò, si verificò un terremoto e la cortina del tempio di Gerusalemme si squarciò in due. Il Regno dei cieli si è aperto ed è entrato nel mondo attraverso l'amore sacrificale del Salvatore. E una persona, attraverso la fede in Cristo, apre il Santo dei Santi - il suo cuore - prima di tutto per se stesso e per il mondo. Nel cristiano, come in un tempio, c'è il Regno dei Cieli, Dio abita, comunica con l'uomo e attraverso l'uomo con il mondo. Confrontando lo scopo di parti delle chiese dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, vediamo come simbolicamente furono incarnate le parole del Vangelo: "Il Regno dei Cieli si è avvicinato".
Iconostasi tyablo a quattro file (tyablo - scaffale) della Chiesa dell'Intercessione
Secoli XVII-XVIII Kizhi
La nuova idea di apertura dell'antica esistenza sacra doveva riflettersi nella struttura del tempio, nel rapporto tra l'altare e la navata (l'ex Santo dei Santi e Santuario). Inizia l'interazione di due idee: apertura e segretezza.
Il compito della cristianità non è facile. Il mistero della Creatività Divina e della salvezza è stato rivelato e allo stesso tempo rimane un mistero. Si apre ai credenti in Cristo nella loro esperienza religiosa, gradualmente, attraverso i sacramenti della chiesa, la consapevolezza dei peccati, il pentimento, la prova del loro amore per Dio e per le persone, e questa scoperta è illimitata e irregolare per le persone, la conoscenza di Dio è senza fine e dipende dalla persona stessa e dalla provvidenza di Dio. E il sacramento dell’Eucaristia – il mistero del sacrificio di Dio, costantemente offerto per il mondo – può essere celebrato davanti a tutti gli uomini, tra i quali possono esserci non credenti e coloro che stanno appena iniziando il loro cammino in Cristo? Ma la cosa principale è dov'è la misura che può essere applicata alle persone che vengono al tempio? Chi può essere presente, offrendo la preghiera con riverente timore reverenziale, e chi può interferire, distrarre il sacerdote dalla più importante di tutte le faccende umane: le preghiere, la celebrazione del sacramento della chiesa?
Naturalmente solo il Dio vivente ha una tale misura. E stabilire una tale misura secondo il consenso umano significa tornare indietro, dalla grazia, alla legge, e persino stabilita dalle persone, impedendo la liberazione del proprio cuore per la guida di Dio.
IN Nelle più antiche chiese bizantine l'altare non era separato. Un estratto da un testo scritto nel IV secolo permette di sentire come i cristiani di quei tempi vivevano e percepivano l'Eucaristia: “Paura e tremore colgono il sacerdote in quest'ora terribile per lui e per i laici. Nella sua straordinaria capacità e nel suo ufficio, terrorizzando anche i serafini, il figlio della polvere della terra si erge come redentore, attanagliato da grande paura. Il terribile zar, misticamente sacrificato e sepolto, e gli spettatori spaventati, tremanti di timore del Signore”. L'altare significava il Trono Divino, provocando un sacro brivido, e l'Eucaristia si svolgeva come un "sacramento tremendo".
E col tempo cominciò ad essere utilizzato un velo (katapetasma), che veniva disegnato durante l'esecuzione del sacramento. Abbastanza presto, a giudicare dalla descrizione dello scrittore ecclesiastico del IV secolo. Vescovo Eusebio di Cesarea, apparve la cosiddetta barriera: un tramezzo basso con porte al centro. Immagini di tali barriere si trovano spesso nei dipinti di chiese antiche, specialmente nelle composizioni dell'Eucaristia. Successivamente, su questa bassa barriera, a destra e a sinistra delle Porte Reali, iniziarono ad essere collocate le icone, solitamente due.
È così che viene inclusa la terza idea dell'iconostasi: le icone come finestre sul mondo spirituale. Trovandosi nella navata del tempio, i credenti non sono semplicemente recintati dall'altare, ma si trovano di fronte alla storia della salvezza dell'umanità e al mondo spirituale, nel quale ogni persona può guardare ed entrare grazie alle numerose finestre, al ruolo di cui è interpretato da icone e immagini dell'iconostasi. Si è così trovato un equilibrio tra la necessità di conservare lo spirito di riverenza durante la celebrazione del sacramento dell'Eucaristia e la possibilità della presenza e partecipazione ad esso di ogni credente, e, allo stesso tempo, solo Dio conosce la misura della dignità della loro partecipazione.
Fu in questa forma che l'iconostasi dovette passare da Bisanzio alla Rus' ed esistere così fino al XV secolo, quando la pittura di icone raggiunse una fioritura particolare e le chiese cominciarono a riempirsi di molte icone, ripetendo quasi tutte le pitture murali dell'epoca. tempio. Le icone sulla barriera dell'altare sono disposte su più file, vicine l'una all'altra, e la barriera stessa avanza, coprendo i pilastri orientali, l'altare e il diacono, o la sacrestia, deposito di vasi sacri, paramenti liturgici, libri, vino, prosfora e altri oggetti necessari al culto e all'adempimento dei requisiti.
IN XV-XVI secoli Si sta sviluppando un tipo russo di iconostasi: un'alta iconostasi. L'iconostasi russa è la struttura più complessa e, a differenza di quella greca, è caratterizzata da una rigorosa struttura orizzontale e verticale. L'iconostasi, secondo la tradizione greco-bizantina accettata, ha tre porte. Le porte centrali sono chiamate Porte Reali, perché solo attraverso di esse il sacerdote fa uscire il calice (coppa) con i Santi Doni (sotto le spoglie del pane e del vino - il Corpo e il Sangue di Cristo), cioè il Signore stesso, il Re della Gloria, passa attraverso queste porte. Sulle Porte Reali sono raffigurati l'Annunciazione e i quattro evangelisti.
Altre porte, a nord e a sud, recano immagini di arcangeli o santi diaconi (a volte santi) e sono chiamate porte dei diaconi perché i diaconi di solito le attraversano. I sacerdoti attraversano queste porte più volte durante le funzioni, ma il vescovo mai, poiché, simboleggiando Cristo Salvatore, attraversa le Porte Reali.
Come segno che dopo il sacrificio espiatorio di Cristo, il Regno dei Cieli si è aperto per le persone nel tempio del Nuovo Testamento, l'altare si apre in tutti i momenti più importanti del servizio. Ma solo coloro che svolgono il servizio divino o prestano servizio durante esso possono entrare nell'altare, solo in paramenti sacri e solo durante il servizio.

Iconostasi della Chiesa di Dmitrij “sul Sangue”
XIX secolo Uglich
E i cavalli sull'iconostasi sono disposti in un certo ordine, in gradinate (o ranghi, o file).
La classica alta iconostasi russa si presenta così. A destra delle Porte Reali c'è l'icona del Salvatore, e a sinistra c'è la Madre di Dio con il Bambino. L'icona del tempio è posta accanto all'icona di Cristo (raffigura un santo o un evento sacro a cui è dedicato il tempio). Questo è il livello locale.
Sopra la fila locale c'è la deesis (deisis) (dal greco. d'ésis- preghiera) una fila che simboleggia la preghiera di tutta la Chiesa celeste a Cristo. L'icona centrale di questa serie - "Il Salvatore al potere" - raffigura il Salvatore come il giudice del mondo intero (in abiti reali o vescovili sul trono celeste). A sinistra e a destra ci sono le immagini della Madre di Dio e di Giovanni Battista in piedi davanti al Signore in preghiera. Queste immagini simboleggiano la preghiera perfetta, poiché la massima santità possibile per la razza umana è rivelata nella Santissima Theotokos e in Giovanni Battista. Su entrambi i lati delle immagini centrali del Salvatore, della Madre di Dio e di Giovanni Battista ci sono icone di apostoli in preghiera e altri santi, motivo per cui questo livello è talvolta chiamato livello apostolico.
Il terzo ordine è chiamato “festivo”, perché qui, nel rigoroso rispetto della trama e dei canoni compositivi, sono raffigurate le principali festività ortodosse.
Il successivo, quarto ordine, è profetico. Contiene le icone dei giusti dell'Antico Testamento: i profeti, attraverso i quali fu ricevuta la rivelazione dell'incarnazione del Salvatore e della Madre di Dio. Al centro di questa fila si trova l'icona della Madre di Dio “Il Segno”, che simboleggia l'incarnazione di Cristo.
Il quinto livello dell'iconostasi - gli antenati - contiene le immagini degli antenati - i patriarchi dell'Antico Testamento e l'icona della Santissima Trinità al centro.
Direttamente sopra le porte reali c'è l'icona dell'Ultima Cena. Al centro sopra il rango più alto c'è la Croce (Golgota) - un simbolo della redenzione dell'umanità e della vittoria dell'amore divino sulla morte.

Iconostasi della Cattedrale di Sant'Isacco
XIX secolo San Pietroburgo
Nell'antica Rus', questo tipo di iconostasi era il più comune, sebbene il numero di livelli potesse essere ridotto a una fila, con l'immagine obbligatoria dell'Ultima Cena sopra le porte reali. Sotto le icone della fila inferiore, quasi sopra il pavimento, anticamente venivano poste anche immagini di filosofi e sibille pagani, poiché, pur non conoscendo il vero Dio, si sforzavano di conoscerlo.
L'iconostasi, come l'intero altare, si trova su un luogo elevato, che sporge nella parte centrale del tempio ed è chiamato solea.
Le regole e le tradizioni stabilite nella costruzione delle chiese ortodosse sono rigorosamente osservate, tuttavia, entro certi limiti, sono consentite differenze (non fondamentali), dovute alle caratteristiche di un particolare tempio, quindi ogni chiesa ortodossa è unica a modo suo, sia esternamente e internamente.
Una chiesa ortodossa può avere altari aggiuntivi che formano le cappelle del tempio; di conseguenza, ogni altare ha la propria iconostasi.
Iconostasi nel tempio
“Il Salvatore al potere”, icona dell’iconostasi della Cattedrale dell’Assunzione a Vladimir, bottega di Rublev, 1408, Galleria Tretyakov
L'iconostasi, che tradotto dal greco significa "il luogo dove stanno le icone", è una realizzazione caratteristica della cultura ortodossa ed è un elemento integrante della costruzione del tempio. È costituito da diverse file di icone disposte in modo ordinato e, tipico della cultura religiosa nel suo insieme, ha molte funzioni e significati. Separando l'altare dal naos, dove si riuniscono i parrocchiani, simboleggia il confine che separa il mondo divino “alto” e quello “basso”, esprime l'idea del sacramento e sottolinea l'importanza dell'altare rispetto al resto del tempio spazio. L'iconostasi rappresenta anche l'epicentro della decorazione interna del tempio, dove si concentrano tutte le icone principali. Inoltre, questa è una sorta di illustrazione del culto, che racconta ai parrocchiani gli obiettivi, la storia e la struttura della chiesa cristiana.
La tradizione di erigere una barriera altare risale alla nascita del cristianesimo, ma la composizione e la struttura dell'iconostasi ortodossa “alta” si svilupparono durante lo sviluppo della costruzione dei templi russi a cavallo tra il XIV e il XV secolo. A differenza dei prototipi bizantini, creati nello stile di un colonnato, l'iconostasi russa è piena di file di icone e rappresenta una barriera continua su tutta la larghezza del tempio.
Ogni iconostasi è unica e si differenzia dalle altre sia per numero e dimensione delle icone, sia per stile e tecnica di esecuzione. Allo stesso tempo, la posizione relativa degli elementi principali è strettamente naturale e regolata dal canone. Nella classica iconostasi “alta”, la cui struttura si formò nei secoli XV-XVI, le icone erano disposte su quattro file principali. Questa è la soluzione all'iconostasi, che fu eretta nella Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir intorno al 1408 con la partecipazione della bottega dei famosi pittori di icone Daniil Cherny e Andrei Rublev. L'iconostasi riempiva tre aperture delle absidi dell'altare e consisteva, si ritiene, di cinquanta o più icone, inclusa un'enorme fila di Deesis per quei tempi. Sotto c'erano le icone del rango locale, che non sono sopravvissute fino ad oggi, e sopra c'erano icone con immagini di festività e profeti.
La composizione realizzata nella Cattedrale di Vladimir si trova in molte chiese ed è considerata canonica. Nei secoli successivi, l'aspetto dell'iconostasi cambiò, divenne più complesso e il numero delle file aumentò a sette. Tuttavia, è stata questa esecuzione in quattro parti a diventare la base della tradizione dell'iconostasi russa, che continua ancora oggi.

Iconostasi nella chiesa di Serafino di Sarov, Naberezhnye Chelny
L'iconografia, posta sul primo ordine, è costruita attorno alla pittura delle porte “reali”, sulle quali sono tradizionalmente raffigurati l'Annunciazione e le figure di evangelisti o santi. Ai lati della navata ci sono immagini accoppiate della Madre di Dio e del Salvatore, che occasionalmente vengono sostituite dalle icone delle feste del Signore e della Madre di Dio. A destra del volto di Cristo c'è l'icona del tempio, che rappresenta un evento o un santo in onore del quale il tempio fu consacrato. Le porte delle porte del diacono sono decorate con immagini di arcangeli, arcidiaconi, sommi sacerdoti o profeti dell'Antico Testamento. Ad eccezione delle icone della Madre di Dio e di Cristo, la cui presenza è obbligatoria, la composizione della fila locale varia sia nel soggetto che nelle dimensioni. Di norma, è formato da icone di santi venerati localmente. Meno comuni sono le composizioni allegoriche, le immagini delle festività o le scene della vita biblica. Il numero delle icone è limitato dalla larghezza dell'altare e varia da tre a venti o più.
Il livello successivo dell'iconostasi è occupato dalle icone di Cristo, della Madre di Dio, di Giovanni Battista, nonché degli apostoli e dei santi, che compongono la fila della Deesis. I primi tre rappresentano una composizione in tre parti, che si trova al centro e funge da dominante simbolica dell'iconostasi nel suo insieme. L'iconografia della Deesis è determinata da un canone rigoroso. Il Salvatore è raffigurato come l’Onnipotente o il Salvatore al potere. A sinistra c'è l'immagine della Madre di Dio, dipinta di fronte alla figura di Cristo, così come le icone dell'Arcangelo Michele e dell'Apostolo Paolo, che, pur non facendo parte della Deesis, sono tuttavia elementi costanti di questa ordine. Sulla destra si trovano rispettivamente le immagini di Giovanni Battista, dell'apostolo Pietro e dell'arcangelo Gabriele. L'iconografia e la posizione relativa delle rimanenti immagini, comprese le icone dei restanti dieci apostoli, che costituiscono una speciale “deesis apostolica”, consente varie variazioni.
Il rito festivo, situato sul terzo livello, rappresenta le icone delle feste del Signore e della Madre di Dio, così come altri eventi della storia del Vangelo, inclusi temi come la risurrezione di Lazzaro, l'Ultima Cena e l'esaltazione della Croce.
Sopra c'è la fila profetica, che include le icone dei profeti dell'Antico Testamento: Elia, Gedeone, Zaccaria, Salomone, Davide e molti altri. Secondo i canoni dell'iconografia ortodossa, i profeti sono raffigurati con rotoli di detti e simboli di profezia.

Iconostasi della Cattedrale di Cristo Salvatore, XIX secolo, Mosca
Nella combinazione delle file principali, l'iconostasi ortodossa esprime quasi tutte le fasi principali della storia e della gerarchia della Chiesa ortodossa. La Deesis rappresenta Cristo in gloria e riecheggia l'iconografia del Giudizio Universale. La serie profetica si riferisce alla storia dell'Antico Testamento. Il rito festivo testimonia i principali eventi della vita di Gesù Cristo. Il simbolismo della fila locale, che gioca un ruolo speciale nel processo di culto, può essere considerato nel contesto dell'idea della riunificazione del divino e del terreno, del movimento verso la salvezza attraverso la preghiera e la chiesa.
La quinta fila, quella degli antenati, che è stata inclusa nella composizione delle iconostasi ortodosse dall'inizio del XVI secolo, contiene immagini degli antenati e rappresenta la più antica e più alta gerarchia dell'essenza divina cristiana. Ecco le immagini dei profeti dell'Antico Testamento e delle prime persone, comprese le icone di Adamo, Eva, Abele e Abramo. Al centro, sopra le porte reali e l'immagine di Cristo, c'è tradizionalmente un'icona associata all'immagine di Dio Padre: la “Trinità” o “Patria”.
Il punto più alto di sviluppo dell'iconostasi russa si verificò nel periodo tra il XVI e il XVII secolo. A quest'epoca risalgono eccezionali opere d'arte templare, tra cui l'iconostasi delle cattedrali dell'Assunzione e dell'Arcangelo a Mosca. Con l'aumento del numero e della dimensione delle icone, la struttura dell'iconostasi è cambiata. La fila festosa, formata da un gruppo di icone con immagini più piccole e complesse, cominciò ad essere posizionata più vicino allo spettatore, immediatamente sopra quello locale. Inoltre, sono apparse diverse nuove serie. Si tratta di riti appassionati che raccontano la morte di Cristo e il tormento degli apostoli, oltre a uno speciale “rito della festa” costituito da piccole icone domestiche lasciate sull'altare dai parrocchiani.
Nei secoli successivi l'iconostasi subì notevoli modifiche. Il periodo sinodale è stato caratterizzato dal desiderio di un'organizzazione estetica dello spazio del tempio, che, in molti casi, è andato contro sia la tradizione che il canone, ma non ha impedito la creazione di opere eccezionali che hanno segnato la pagina successiva della storia dell'iconostasi ortodossa.