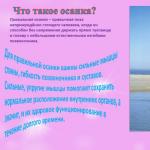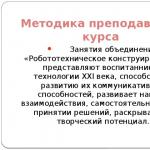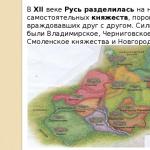Derivati funzionali dell'acido carbonico. Ammidi dell'acido carbonico e loro derivati Derivati dell'acido carbonico
L'acido carbonico, come molti altri acidi, forma numerosi derivati: sali, esteri, anidridi di cloro, ammidi, ecc.
Per la medicina, le ammidi dell'acido carbonico sono di grande interesse, poiché i loro derivati sono farmaci preziosi.
L'acido carbonico, come acido dibasico, forma due tipi di ammidi: a) un'ammide incompleta (un prodotto della sostituzione di un idrossile con un gruppo amminico) - acido carbammico; b) completo
ammide (un prodotto della sostituzione di due idrossili per gruppi amminici) - urea o urea.
L'acido carbammico allo stato libero è sconosciuto a causa della sua elevata tendenza a decomporsi in anidride carbonica e ammoniaca. Ma i suoi cloruri acidi, coli, esteri sono ben noti. Per la pratica medica sono importanti gli esteri dell'acido carbamico, detti uretani, che hanno un effetto ipnotico.

A seconda della natura dell'alcol con cui viene esterificato l'acido carbammico, si possono ottenere vari uretani.
Tra i derivati dell'urea, di maggiore interesse per la medicina sono i suoi derivati acilici, in cui l'idrogeno del gruppo amminico dell'urea è sostituito da un residuo acido - acile (Ac è il residuo di qualsiasi acido).

I derivati dell'urea di Atsilyshe furono ottenuti per la prima volta da N. N. Zinin e da lui chiamati ureides.
Quando l'urea reagisce con un acido carbossilico monobasico, si formano ureidi aperte (acicliche).

Nell'interazione dell'urea con un acido carbossilico dibasico, si possono ottenere ureidi sia aperti che chiusi (ciclici), a seconda delle condizioni di reazione.

Quando gli idrogeni nel gruppo metilenico (posizione 5) della molecola di acido barbiturico vengono sostituiti da vari radicali, si possono ottenere molti dei suoi derivati (barbiturici), che vengono utilizzati in medicina come farmaci ipnotici.
Per proprietà fisiche, i farmaci legati agli ureidi e agli uretani sono solidi cristallini bianchi, difficilmente solubili in acqua, ad eccezione dei sali.
Le proprietà chimiche di ureidi e uretani hanno una serie di caratteristiche comuni: se riscaldati con alcali, rilasciano sia ammoniaca che carbonato di sodio e, quando acidificato, il carbonato di sodio rilascia bolle di gas (CO2).
Altri prodotti di reazione durante l'interazione di uretani e ureidi con alcali consentono di distinguerli l'uno dall'altro.
Nel caso degli uretani si forma alcol (I), nel caso degli ureidi si forma il sale sodico del corrispondente acido (II).

Uno dei rappresentanti degli uretani è il farmaco meprotan, degli ureidi aperti, bromisoval trova applicazione in medicina.
Descrizione. Solubilità. Polvere cristallina bianca inodore, gusto salino-alcalino, solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool. Le soluzioni acquose hanno una reazione leggermente alcalina. Agitando e riscaldando fino a 70 ° C soluzioni acquose di NaHCO 3, si forma un doppio sale di Na 2 CO 3 · NaHC03.
Ricevuta
Il bicarbonato di sodio fu scoperto nel 1801 dallo scienziato V. Rose. Il preparato si ottiene saturando carbonato di sodio purificato con anidride carbonica:
Na2CO3 · 10 H 2 O + CO 2 → 2 NaHCO 3 + 9 H 2 O
bere anidride calcinata
Autenticità
Con un'analisi qualitativa si effettuano reazioni farmacopeiche per lo ione Na+ e HCO 3 - - e lui.
Reazioni generali agli ioni CO 3 2- e HCO 3 - -:
Sotto l'azione di un forte acido minerale, si osserva un rapido rilascio di CO 2:
NaHCO 3 + HCl → NaCl + H 2 O + CO 2
CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O
biossido di calce bianca
acqua di carbonio
Reazioni distintive:
1) I carbonati possono essere distinti dagli idrocarburi dal colore dell'indicatore: la fenolftaleina. Quando il carbonato di sodio viene sciolto in acqua, la reazione del mezzo è leggermente alcalina e quindi il colore dell'indicatore è rosa: Na 2 CO 3 + H 2 O → NaHCO 3 + NaOH
Quando si dissolve il bicarbonato di sodio, la reazione del mezzo è acida e l'indicatore è incolore o leggermente rosa: NaHCO 3 + H 2 O → H 2 CO 3 + NaOH
H 2 CO 3 → CO 2 + H 2 O
2) Con una soluzione satura di solfato di magnesio, i carbonati formano un precipitato bianco a temperatura ambiente e gli idrocarburi - solo quando bolliti:
4 Na 2 CO 3 + 4 MgSO 4 + 4 H 2 O → 3 MgCO 3 Mg(OH) 2 3 H 2 O↓ + 4 Na 2 SO 4 + CO 2
2 NaHCO 3 → Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O
Bontà
NaHC03: 1) ammessi: Cl -, K +, Ca 2+, Fe, As.
L'additivo specifico di CO 3 2– viene determinato per calcinazione alla temperatura di 300°C. La perdita di massa deve essere almeno del 36,6%. Più impurità di carbonati, minore è la perdita di massa all'accensione. La perdita teorica è del 36,9%. La differenza tra la perdita di peso teorica e quella indicata nel GF determina il limite ammissibile di impurità carbonatiche nel preparato - 0,3%.
2) non ammessi: NH 4 + sali e metalli pesanti.
quantificazione
Acidimetria, titolazione diretta, il campione viene sciolto in acqua appena bollita e raffreddata per rimuovere CO 2, titolato con 0,5 N HCl, indicatore metilarancio. E = M.
Applicazione. Conservazione.
negozio in un contenitore ben chiuso. La sostanza è stabile all'aria secca, ma perde lentamente CO 2 in aria umida e forma Na 2 CO 3 .
Applicare come antiacido all'interno, così come esternamente sotto forma di risciacqui, risciacqui, inalazioni di soluzioni allo 0,5 - 2%.
Caratteristiche della preparazione delle soluzioni iniettabili di NaHCO 3
Le soluzioni iniettabili di NaHCO 3 vengono sterilizzate a 100°C per 30 minuti. In questo caso si forma CO 2, quindi le bottiglie con una soluzione iniettabile di NaHCO 3 vengono riempite a 2/3 del volume a una temperatura non superiore a 20 o C.
Dopo la sterilizzazione, la soluzione viene raffreddata fino alla completa dissoluzione della CO 2 risultante.
Descrizione. Solubilità. Cristalli trasparenti incolori o polvere cristallina bianca, inodore, sapore leggermente amaro. Sorge e svanisce. Leggermente solubile in acqua, solubile in alcool, leggermente solubile in cloroformio, etere, trementina.
Ricevuta
Terpinidrato ottenuto dal pinene - un prodotto della distillazione frazionata della trementina. Il pinene viene idratato sotto l'azione dell'acido solforico al freddo per 10 giorni. Quindi la miscela viene neutralizzata con soda, il terpinidrato viene separato, purificato e ricristallizzato.

Autenticità
Reazioni generali
I farmaci identificano alcol idrossile:
1) reazione di formazione di esteri con acidi. Questa proprietà viene utilizzata per ottenere validol. L'esterificazione di mentolo e terpinidrato con anidride acetica dà derivati acilici sotto forma di un precipitato bianco; il suo punto di fusione può essere determinato.
2) reazione di ossidazione. Il mentolo è ossidato da ossidanti deboli a chetone-mentone. Sotto l'azione di forti agenti ossidanti, il mentolo si decompone in acido formico, acetico, butirrico e ossalico.
Reazioni specifiche
Terpinidrato quando interagisce con una soluzione alcolica di cloruro ferrico durante l'evaporazione, forma una colorazione rosso carminio, viola e verde in diversi punti del piatto di evaporazione. Quando il benzene viene aggiunto ai prodotti di ossidazione, si forma un colore blu.
Il terpinidrato viene aperto anche da una reazione di disidratazione in presenza di acido solforico concentrato per formare torbidità e odore aromatico:

Bontà
Terpinidrato. 1) Permettere:
ceneri solfate e metalli pesanti.

Anidride carbonica (anidride carbonica)-partecipante a molte reazioni di carbossilazione e decarbossilazione in vivo e in vitro.
La carbossilazione è possibile quando i composti con una carica negativa parziale sull'atomo di carbonio reagiscono con l'anidride carbonica. Nel corpo, l'interazione dell'anidride carbonica con l'acetil coenzima A porta alla formazione del malonil coenzima A.
Come lo stesso acido carbonico, anche alcuni dei suoi derivati sono sconosciuti in forma libera: ClCOOH monocloruro e monoammide - carbamico acido H 2 NCOOH. Tuttavia, i loro esteri sono composti abbastanza stabili.
Per la sintesi di derivati dell'acido carbonico, si può usare fosgene(dicloranidruro) COCl 2, facilmente formato dall'interazione del monossido di carbonio con il cloro alla luce. Il fosgene è un gas estremamente velenoso (bp. 8 o C), nella prima guerra mondiale fu usato come agente di guerra chimica.
L'estere etilico dell'acido cloroformico, quando reagito con l'ammoniaca, forma l'estere etilico dell'acido carbammico H 2 NCOOC 2 H 5 . Gli esteri dell'acido carbammico (carbammati) hanno un nome comune - uretani.
Gli uretani hanno trovato applicazione in medicina come medicinali, in particolare meprotano e etacizina.

Urea (urea)(NH 2) 2 C=O è il più importante prodotto finale del metabolismo umano contenente azoto (circa 20-30 g/die di urea vengono escreti nelle urine).
Gli acidi e gli alcali, se riscaldati, provocano l'idrolisi dell'urea; nel corpo, viene idrolizzato dall'azione degli enzimi.
Quando riscaldata lentamente a una temperatura di 150-160 ° C, l'urea si decompone con il rilascio di ammoniaca e la formazione biureto.
Quando il biureto interagisce in soluzioni alcaline con ioni rame(II), si osserva un caratteristico colore viola a causa della formazione di un complesso chelato (reazione del biureto). Il residuo di biureto nel complesso chelato ha una struttura immidica.

Sono derivati di acidi carbossilici contenenti un residuo di urea come sostituente ureidi. Sono usati in medicina, in particolare acido α-bromoisovalerico ureide - bromizzato
(bromurale) - usato come un leggero sonnifero. Il suo effetto è dovuto a una combinazione di bromo e residuo di acido isovalerico noto per il suo effetto inibitorio sul sistema nervoso centrale.

Guanidina (iminourea)- un derivato azotato dell'urea - è una base forte, poiché l'acido coniugato - ione guanidinio - è stabilizzato mesomericamente.

Il residuo di guanidina fa parte dell'α-aminoacido - arginina e della base nucleica - guanina.
3.2 Eterofunzionale composti nei processi vitali
caratteristiche generali
La maggior parte delle sostanze coinvolte nel metabolismo sono composti eterofunzionali.
I composti sono chiamati eterofunzionali, nelle cui molecole sono presenti diversi gruppi funzionali.
Le combinazioni di gruppi funzionali caratteristici di composti biologicamente importanti sono presentate nella Tabella 3.2.
Tabella 3.1. Le più comuni combinazioni di gruppi funzionali in composti alifatici biologicamente importanti

Tra i composti eterofunzionali negli oggetti naturali, i più comuni sono gli amminoalcoli, gli amminoacidi, i composti idrossicarbonilici, nonché gli idrossi e gli oxoacidi (Tabella 9.2).
Tabella 9.2. Alcuni idrossi e oxoacidi e loro derivati

* Per acidi di- e tricarbossilici - con la partecipazione di tutti i gruppi carbossilici. Per sali incompleti e derivati funzionali viene aggiunto un prefisso idro)-, ad esempio "idrossalato" per l'anione HOOC-COO - .
Di particolare importanza biologica α-amminoacidi sono trattati nel capitolo 12. Le poliidrossialdeidi e i poliidrossichetoni (carboidrati) sono trattati nel capitolo 13.
Nella serie aromatica si basano importanti composti naturali biologicamente attivi e droghe sintetiche (vedi 9.3). i-aminofenolo, i-aminobenzoico, salicilico e acido sulfanilico.
I nomi sistematici dei composti eterofunzionali sono costruiti secondo le regole generali della nomenclatura sostitutiva (vedi 1.2.1). Tuttavia, per un certo numero di acidi ampiamente utilizzati, sono preferiti nomi banali (vedi Tabella 9.2). I loro nomi latini servono come base per i nomi di anioni e derivati acidi, che spesso non coincidono con nomi banali russi.
Reattività
PROGRAMMA
corso di chimica organica
per gli studenti della Facoltà di Biologia e del Suolo
INTRODUZIONE
Il tema della chimica organica. La storia dell'emergere della chimica organica e le ragioni della sua separazione in una scienza separata. Caratteristiche distintive dei composti organici e reazioni organiche.
La struttura dei composti organici. Teoria della struttura chimica. Il ruolo di A.M. Butlerov nella sua creazione. Legami chimici: semplici e multipli. Formula strutturale. Isomeria. Omologia. Dipendenza delle proprietà chimiche dalla composizione e struttura della sostanza. funzione chimica. principali gruppi funzionali.
Classificazione dei composti organici. Principi di nomenclatura sistematica (IUPAC).
Legame chimico nelle molecole dei composti organici. Tipi di legame chimico. Legami ionici, covalenti, di coordinazione. Collegamento semipolare. Il ruolo dell'ottetto elettronico. Configurazioni elettroniche degli elementi. Orbitali atomici e stati di valenza del carbonio. Ibridazione di orbitali atomici: sp3, sp2, sp(tre stati di valenza di un atomo di carbonio). obbligazioni s e p. I parametri principali di un legame covalente sono: energia del legame, lunghezza del legame, polarità e polarizzabilità del legame. L'elettronegatività degli elementi. Il concetto di mesomerismo (risonanza). Effetti sostitutivi elettronici: induttivi ( io), mesomerico ( M).
Isomeria dei composti organici. Isomeri strutturali e stereoisomeri. Fondamenti di stereochimica. Struttura spaziale del metano e suoi omologhi. Il principio della libera rotazione ei limiti della sua applicabilità. Conformazioni schermate e ostacolate. Conformazioni di composti a catena aperta. Formule conformazionali di tipo Newman e "capra". Conformazione dell'anello cicloesano. Connessioni assiali ed equatoriali. Inversione della conformazione della sedia. Confronto della stabilità dei derivati del cicloesano con le posizioni assiali ed equatoriali dei sostituenti. Interazione 1,3-Diassiale.
geometrico ( cis - trad) isomeria e le condizioni per la sua comparsa nella serie delle olefine, cicloalcani. E-, Z- nomenclatura.
Isomeria ottica. Attività ottica e sostanze otticamente attive. Asimmetria molecolare come condizione per la comparsa dell'attività ottica. Atomo di carbonio asimmetrico. Enantiomeri e diastereomeri. R- e S- nomenclatura per designare la configurazione del centro di chiralità. Formule di proiezione di Fisher. Nomenclatura D e L. Stereoisomeria di composti con più centri di chiralità. Eritro- e treoisomeri. Mesoforme. modifica racemica.
Classificazione delle reazioni organiche in base alla natura delle trasformazioni e alla natura dei reagenti.
IDROCARBURI
alcani. Serie omologa del metano. Isomeria. Nomenclatura. Modi per ottenere. Proprietà fisiche, loro dipendenza dalla lunghezza e dalla struttura della catena. Proprietà chimiche. Reazioni di sostituzione radicale (SR): alogenazione (influenza della natura dell'alogeno), nitrazione (Konovalov), sulfoclorurazione, ossidazione. Inizio e inibizione delle reazioni radicaliche. Reattività di atomi di idrogeno associati ad atomi di carbonio primari, secondari e terziari. Radicali alchilici e loro relativa stabilità.
Alcheni. Isomeria. Nomenclatura. Modi per ottenere. Proprietà fisiche. Lunghezza ed energia di formazione del doppio legame. Proprietà chimiche. Reazioni di addizione elettrofila: alogeni, alogenuri di idrogeno, acqua, acidi ipohalici, acido solforico. Il meccanismo delle reazioni di addizione elettrofila. Orientamento stereo e regionale dell'adesione. Carbocationi, la loro stabilità a seconda della struttura. Il governo di Markovnikov e la sua giustificazione moderna. Addizione radicale: aggiunta di HBr in presenza di perossidi. Addizione nucleofila. Polimerizzazione: cationica, anionica e radicalica. idrogenazione catalitica. Ossidazione: epossidazione secondo Prilezhaev, ossidazione con permanganato di potassio, ozonizzazione. Proprietà chimiche del legame a-metilene adiacente al legame p (posizione allilica): clorurazione, ossidazione.
Alchini. Isomeria. Nomenclatura. Sintesi di acetilene e suoi omologhi. Caratterizzazione delle proprietà fisiche. Proprietà chimiche degli acetileni: reazioni di addizione, reazioni di sostituzione che coinvolgono un atomo di idrogeno mobile al carbonio con triplo legame. acetilidi. Polimerizzazione dell'acetilene a benzene, vinilacetilene, cicloottatetraene.
alcadieni. Tipi di alcadieni. Isomeria. Nomenclatura. Stereochimica degli alleni. Asimmetria molecolare. Coniugato - 1,3-dieni. Metodi per ottenere dieni. Proprietà fisiche. Lunghezze dei legami carbonio-carbonio nell'1,3-butadiene e sua energia di formazione. Manifestazione dell'effetto di coniugazione. 1,2- e 1,4-addizione a 1,3-dieni - addizione elettrofila di alogeni e alogenuri di idrogeno. Carbocationi di tipo allile. Ciclodizione a un sistema di dieni: sintesi di dieni Diels-Alder. Polimerizzazione di 1,3-dieni. Gomma sintetica a base di 1,3-butadiene (divinile). Copolimeri di divinile con stirene, acrilonitrile, gomma butilica. Gomma naturale: sua struttura, ozonolisi, trasformazione in gomma.
Cicloalcani. Classificazione. Isomeria. Nomenclatura. Metodi generali e speciali per la sintesi di cicli piccoli, medi e grandi. Proprietà fisiche e chimiche. Valutazione comparativa della reattività e stabilità termica di ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e cicloesano. La teoria dello stress di Bayer e la sua comprensione moderna. Stima dell'intensità dei cicli sulla base dei calori di combustione. Comprensione moderna della struttura del ciclopropano. Conformazioni dei cicloalcani. Cicloalcheni e cicloalcadieni.
idrocarburi aromatici. Caratteristiche delle proprietà chimiche del benzene e dei suoi omologhi. La struttura del benzene (angoli di valenza, distanze interatomiche). Energia di formazione e calore di idrogenazione del benzene. energia di stabilizzazione. Carattere aromatico del nucleo benzenico. Concezione moderna della natura dell'aromaticità. Composti aromatici non benzenoidi. La regola dell'aromaticità di Hückel. Aromaticità dei composti eterociclici: furano, tiofene, pirrolo, piridina. Aromaticità del catione ciclopropenile, anione ciclopentadienilico, catione cicloeptatrienile. Mancanza di proprietà aromatiche nel cicloottatetraene.
omologhi del benzene. Serie omologa del benzene. Isomeria nella serie degli alchilbenzeni. Nomenclatura. Metodi di sintesi di laboratorio. Metodi di produzione nell'industria. Reazioni di sostituzione elettrofila nel nucleo aromatico. Schemi generali e meccanismo di queste reazioni. reagenti elettrofili. Alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione. Influenza dei sostituenti donatori e di ritiro di elettroni (attivazione e disattivazione) sulla direzione e sulla velocità di sostituzione elettrofila nel nucleo del benzene. Influenza degli effetti induttivi e mesomerici dei sostituenti. Regole di orientamento per la sostituzione: orto- e paio- orientanti (sostituenti del primo tipo) e meta- orientanti (sostituenti del secondo tipo). Orientamento coordinato e non coordinato. Alogenazione e ossidazione delle catene laterali.
Idrocarburi polinucleari aromatici.
a) Idrocarburi con nuclei non condensati. difenile. difenilmetano e trifenilmetano. Radicale trifenilmetilico, catione e anione. Ragioni della loro stabilità.
b) Idrocarburi con nuclei condensati. Naftalene e antracene. Fonti di ricezione. Isomeria dei derivati monosostituiti. La struttura del naftalene e dell'antracene. Reazioni di addizione e sostituzione. Idrogenazione, ossidazione, alogenazione, nitrazione, solfonazione. Valutazione comparativa del carattere aromatico di benzene, naftalene e antracene. Fenantrene. Distribuzione dello scheletro del fenantrene in composti naturali.
DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Derivati dell'alogeno.
a) Alogenuri alchilici. Isomeria. Nomenclatura. Metodi di produzione: alogenazione diretta degli alcani, aggiunta di alogenuri di idrogeno ad alcheni e alchini, da alcoli per azione di derivati degli alogenuri di fosforo. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sostituzione nucleofila dell'alogeno. Meccanismi di S N 1 e S N 2, stereochimica delle reazioni. Nucleofilo. Gruppo in partenza. Formazione, stabilizzazione e riarrangiamento di ioni carbonio. Dipendenza del meccanismo di reazione dalla struttura del derivato dell'alogeno e dalla natura del solvente. Confronto delle reazioni S N 1 e S N 2. Reazioni di eliminazione degli alogenuri di idrogeno (E1 ed E2): stereochimica, direzione di eliminazione. La regola di Zaitsev. Competizione tra reazioni di sostituzione ed eliminazione a seconda della natura del reagente e delle condizioni di reazione. Reazioni degli alogenuri alchilici con i metalli. Reagenti di Grignard: preparazione e proprietà.
b) Derivati alogeni aromatici (alogenuri arilici). Nomenclatura. Preparazione: alogenazione diretta al cuore, da sali di diazonio. Proprietà chimiche. Reazioni di sostituzione elettrofila (influenza degli alogeni). Reazioni di sostituzione nucleofila negli alogenarili.
ALCOOL
Alcoli saturi monoidrici. Isomeria. Nomenclatura. Ottenimento: dagli alogenuri alchilici, idratazione degli alcheni, riduzione dei composti carbonilici. Ottenere alcoli primari, secondari e terziari utilizzando i reagenti di Grignard (pianificazione e limitazioni della sintesi). Proprietà fisiche. Associazione. Legame idrogeno. Proprietà chimiche degli alcoli. Proprietà acido-base degli alcoli. Reazioni che coinvolgono il legame О-Н: l'azione di metalli e composti organometallici, la formazione di esteri di acidi minerali, la reazione di esterificazione. Reazioni che coinvolgono il legame C-OH e loro meccanismo: sostituzione dell'ossidrile con l'alogeno. Disidratazione degli alcoli - intramolecolare e intermolecolare. Meccanismo di reazione, regola Zaitsev-Wagner. Deidrogenazione e ossidazione degli alcoli.
Alcoli diidrici (glicoli). Classificazione, isomeria. Nomenclatura. Metodi per ottenere glicoli. Caratteristiche delle proprietà fisiche e chimiche. disidratazione dei glicoli. Riarrangiamento Pinacol. Reazioni di ossidazione.
alcoli poliidrici. Glicerolo. Sintesi. Proprietà chimiche e applicazioni. Nitroglicerina. Alcoli poliidrici: eritritoli, pentiti, esiti.
FENOLI
Fenoli monoidrici. Isomeria, nomenclatura. Metodi di produzione industriale: fusione alcalina dei solfonati, idrolisi degli alogenuri arilici, ossidazione del cumene. Preparato a base di sali di diazonio. Proprietà chimiche. Acidità dei fenoli. Reazioni che coinvolgono il legame O-H: la formazione di fenolati, eteri ed esteri. Reazione Williamson. Influenza reciproca dei gruppi ossidrilici e del nucleo aromatico del fenolo. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione, solfonazione, nitrazione, combinazione con diazocomposti. Condensazione del fenolo con formaldeide. Ossidazione e riduzione dei fenoli.
fenoli poliidrici. Pirocatechina, resorcina, idrochinone.
ETERI
Classificazione. Isomeria. Nomenclatura. Metodi di ricezione. Proprietà fisiche e chimiche. Formazione di composti di ossonio. Sostituzione del gruppo alcossilico negli eteri (scissione degli eteri).
Eteri ciclici. Resina epossidica. Ricevuta. Proprietà chimiche degli epossidi. Reazioni di apertura dell'anello catalizzate da acidi e basi (meccanismo di reazione, stereochimica, direzione di apertura dell'anello), reazione con composti organometallici. tetraidrofurano. diossano.
Ammine. Ammine primarie, secondarie e terziarie. Ammine, alifatiche e aromatiche. Isomeria e nomenclatura. Metodi per la sintesi di ammine. Proprietà fisiche e chimiche delle ammine. Caratteri di base delle ammine. Influenza della natura e del numero di gruppi alchilici o arilici in un'ammina sulla sua basicità. Alchilazione delle ammine. Basi di ammonio quaternario e loro sali. Acilazione delle ammine. Proprietà e applicazioni dei derivati acilici. Reazioni di sostituzione elettrofila in alcune ammine aromatiche: alogenazione, nitrazione, solfonazione. Ammidi dell'acido sulfanilico (preparati sulfanilammidici). L'azione dell'acido nitroso sulle ammine primarie, secondarie e terziarie della serie alifatica e aromatica.
Composti diazoici aromatici. reazione di diazotazione. Condizioni per l'esecuzione e meccanismo di reazione. Catione diazonio: stabilità e carattere elettrofilo. Reazioni dei diazocomposti con evoluzione dell'azoto: sostituzione con alogeno, idrossile, gruppo ciano, idrogeno e altri atomi e gruppi. Reazioni dei diazocomposti senza evoluzione di azoto. Reazione di accoppiamento azo come reazione di sostituzione elettrofila. condizioni di flusso. Coloranti azoici - composti ossiazo- e aminoazoici. Proprietà indicatrici dei coloranti azoici sull'esempio dell'arancio metile. Relazione tra colore e consistenza. Recupero di diazocomposti.
Aminoalcoli. Etanolamina (colamina). Colina. Acetilcolina. Sfingosina.
COMPOSTI CARBONILICI
Limita aldeidi e chetoni(derivati di alcani, cicloalcani e idrocarburi aromatici). La struttura del gruppo carbonile. Isomeria. Nomenclatura. Produzione industriale di formaldeide da alcol metilico, acetaldeide da acetilene. Metodi generali per la preparazione di aldeidi e chetoni. Proprietà chimiche. Confronto della reattività di aldeidi e chetoni (alifatici e aromatici). Addizione nucleofila al gruppo carbonile: acqua, alcoli, acido cianidrico, bisolfito di sodio, composti organomagnesio. Schema generale delle reazioni con derivati dell'ammoniaca. Reazioni con ammine, idrossilammina, idrazine, semicarbazide. Catalisi acida e basica delle reazioni di addizione. Recupero di composti carbonilici ad alcoli, idrocarburi. Ossidazione di aldeidi e chetoni. Reazioni di sproporzione (Cannizzaro, Tishchenko). Reazioni che coinvolgono un atomo di idrogeno a-carbonio. Alogenazione. reazione aloforme. Sigillo aldolico. Il meccanismo della reazione e il ruolo del catalizzatore. Condensazione di Crotone.
Composti carbonilici insaturi. a-,b-Aldeidi e chetoni insaturi. Ricevuta. Coniugazione di un gruppo carbonile e di un doppio legame. Reazioni di addizione di reagenti elettrofili e nucleofili. polimerizzazione. Acroleina. Crotonaldeide.
acidi carbossilici
acidi monocarbossilici. Nomenclatura dell'isomerismo. Metodi di sintesi. Proprietà fisiche. La struttura del gruppo carbossilico. proprietà acide. costante di acidità Influenza dell'effetto dei sostituenti sulla forza degli acidi carbossilici. Reazioni che si verificano con una rottura del legame O-H. Sali di acidi carbossilici. Reazioni che avvengono con rottura del legame C-OH: la formazione di derivati funzionali degli acidi carbossilici. Reazione di esterificazione e suo meccanismo. Equilibrio costante. Preparazione di alogenuri acidi, anidridi e ammidi. Il meccanismo della reazione di sostituzione nucleofila negli acidi e loro derivati. Confronto della reattività di derivati acidi in reazioni con reagenti nucleofili. Alogenuri acidi. Proprietà chimiche. Interazione con acqua, ammoniaca, ammine, alcoli. Reazioni di acilazione. Amidi. Basicità ridotta delle ammidi. Idrolisi di ammidi in mezzi acidi e alcalini. Disidratazione. Legame ammidico nelle molecole proteiche. Eteri complessi. Proprietà chimiche. Idrolisi degli esteri e suo meccanismo. reazione di transesterificazione. Interazione con il reagente di Grignard. Recupero di esteri. Nitrili. Idrolisi e riduzione ad ammine. Reazioni di acidi che coinvolgono l'idrogeno in un atomo di carbonio: alogenazione, ossidazione. Decarbossilazione degli acidi carbossilici.
Acidi monocarbossilici insaturi. Isomeria. Nomenclatura. Influenza reciproca del doppio legame e del gruppo carbossilico. Aggiunta di reagenti elettrofili e nucleofili. Acidi grassi insaturi superiori: acido oleico, linoleico. Gli esteri degli acidi grassi superiori e il glicerolo sono grassi. Oli vegetali e loro tipologie. La struttura dei gliceridi naturali e le loro proprietà. Configurazione di triacilgliceroli naturali contenenti un atomo di carbonio asimmetrico. idrolisi dei grassi. Sapone. Idrogenazione dei grassi. Lipidi. Glicolipidi. Glicerofosfolipidi. Fosforgliceridi etanolamina (cefaline). Colinefosfogliceridi (lecitine).
acidi dicarbossilici. Isomeria. Nomenclatura. Metodi di sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Fasi di dissociazione e costanti di acidità. Formazione di due serie di derivate funzionali. Relazione con il riscaldamento degli acidi ossalico, malonico, succinico, glutarico e ftalico. anidridi cicliche. ftalimmide, ftalimmide di potassio. Etere Malonico. Reazioni di sostituzione che coinvolgono atomi di idrogeno del gruppo metilenico. Sintesi di acidi mono e bibasici mediante estere malonico. Acido adipico. Reazioni di policondensazione e loro impiego nell'industria (fibra artificiale).
DERIVATI DELL'ACIDO CARBONICO
Fosgene. Sintesi, proprietà e applicazione. Esteri degli acidi clorocarbonico e carbonico. Acido carbammico: carbammati, esteri (uretani). Urea. Metodi di sintesi. Struttura e reazioni. Biureto. Acilazione dell'urea (ureidi).
OSSACIDI
Classificazione. acidi monobasici diidrici. Isomeria. Nomenclatura. Acido glicolico. Acidi lattici e loro stereoisomeria. Metodi per la sintesi di a-, b- e g-idrossiacidi. Proprietà chimiche. Disidratazione degli idrossiacidi. lattici e lattoni. Idrossiacidi triatomici bibasici. acidi malici. Stereoisomeria. Il fenomeno della conversione valdese.
Idrossiacidi tetraidrici bibasici. Acidi tartarici, loro stereoisomeria. Uva e acidi mesotartarici. Stereochimica di composti con due atomi asimmetrici, identici e differenti. Racemates. diastereomeri. Mesoforme. Idrossiacidi aromatici. Acido salicilico. Ricevuta e domanda. Aspirina.
OSSOACIDI (ALDEIDO E CHETOACIDI)
Classificazione. Nomenclatura. Acido gliossilico e piruvico. Ottenere e proprietà. Decarbossilazione e decarbonilazione. b-chetoacidi: acido acetoacetico e suo estere. Sintesi dell'estere acetoacetico. Condensazione di Ester Claisen, il suo meccanismo. Proprietà chimiche dell'estere acetoacetico. Reazioni caratteristiche delle forme chetoniche ed enoliche dell'estere acetoacetico. Il fenomeno del tautomerismo. Tautomerismo cheto-enolico dell'estere acetoacetico. Ragioni per la relativa stabilità della forma enol. Scissione acida e chetonica dell'estere acetoacetico. Sintesi di chetoni, acidi mono e dicarbossilici.
Informazioni simili.
Applicazione. Conservazione.
quantificazione
Bontà
Autenticità
Ricevuta
Preparati di ferro
Applicazione. Conservazione.
negozio in un contenitore ben chiuso, in luogo fresco, poiché il tetraborato di sodio può perdere acqua di cristallizzazione e idrolizzarsi formando acido borico:
Na 2 B 4 O 7 + 7 H 2 O ® 4 H 3 BO 3 ↓ + 2NaOH
L'acido borico non richiede condizioni di conservazione speciali.
Applicare preparati come antisettici per uso esterno. L'acido borico viene utilizzato sotto forma di soluzioni al 2-3% per gargarismi, sotto forma di soluzioni di glicerina, unguenti, polveri. Le soluzioni all'1-2% vengono utilizzate nella pratica degli occhi. I composti del boro sono velenosi, quindi non vengono utilizzati internamente. Il borace viene utilizzato sotto forma di soluzioni all'1-2%.
Descrizione. Solubilità. Cristalli prismatici trasparenti di colore verde-bluastro chiaro o polvere cristallina verde chiaro. Solubile in acqua, soluzioni leggermente acide. Svanisce nell'aria.
Un eccesso di ferro ridotto viene sciolto in una soluzione al 30% di acido solforico a t o \u003d 80 o C: Fe + H 2 SO 4 ® FeSO 4 + H 2
La soluzione viene evaporata, il farmaco viene essiccato a t o = 30 o C.
Effettuare reazioni farmacopee allo ione ferro e agli ioni solfato.
1) Fe2+: Reazione di formazione di Turnbull blue:
FeSO 4 + K 3 + H 2 SO 4 ® FeK ¯ + 2 K 2 SO 4
Reazione con soluzioni alcaline e ammoniaca:
FeSO 4 + NaOH + NH 4 OH ® Fe (OH) 2 ¯ + O 2 aria. ® Fe(OH) 3 ¯
bianco marrone
Reazione di precipitazione del solfuro:
FeSO 4 + Na 2 S ® FeS ¯ + Na 2 SO 4
2) SO 4 2-: FeSO 4 + BaCl 2 ® BaSO 4 ¯ + FeCl 2
1) ammessi: metalli pesanti, As.
2) inaccettabile: si aprono i sali di rame con l'aggiunta di H 2 O 2 e NH 4 OH, quindi si filtra il precipitato formatosi; il filtrato dovrebbe essere incolore.
permanganatometria, titolazione diretta. Il metodo si basa sull'ossidazione di Fe(II) con permanganato di potassio in un mezzo acido a Fe(III). E = M.
10 FeSO 4 + 2 KMnO 4 + 8 H 2 SO 4 ® 5 Fe 2 (SO 4) 3 + K 2 SO 4 + 2 MnSO 4 + 8 H 2 O
negozio in recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, evitando perdite di acqua di cristallizzazione e ossidazione in aria umida con formazione del sale basico Fe 2 (OH) 4 SO 4 . A 64°C, il solfato di ferro si scioglie nella sua acqua cristallina.
Applicare solfato ferroso nella complessa terapia dell'anemia da carenza di ferro sotto forma di compresse e iniezioni. Assegna 0,05–0,3 g per ricezione.
L'acido carbonico forma due tipi di sali: carbonati medi e bicarbonati acidi.
| NaHCO3 | Idrocarbonato di sodio Natrii idrocarburi |
Descrizione. Solubilità. Polvere cristallina bianca inodore, gusto salino-alcalino, solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool. Le soluzioni acquose hanno una reazione leggermente alcalina. Agitando e riscaldando fino a 70 ° C soluzioni acquose di NaHCO 3, si forma un doppio sale di Na 2 CO 3 · NaHC03.