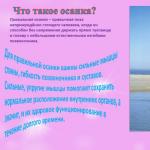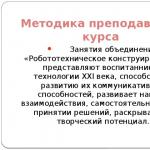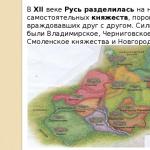Caratterizzare il concetto di norme sociali. Teoria del governo e dei diritti
Dal momento della nascita ai giorni nostri, i rappresentanti dell'umanità hanno escogitato molte regole diverse che aiutano a regolare le relazioni nella società, nella famiglia, nel lavoro, ecc. Alcune di esse sono cresciute in tradizioni e costumi secolari. Con l'avvento delle istituzioni educative e l'introduzione della materia della sociologia, queste regole e tradizioni iniziarono a essere chiamate norme sociali.
concetto
Le norme sociali sono un modello di comportamento accettato in una società che funge da regolatore delle relazioni tra le persone e le comunità di persone. Esempi di norme sociali possono essere rintracciati nel comportamento quotidiano delle persone nella società.
Tutti sanno, ad esempio, che apparire nudi in pubblico è inaccettabile e in alcuni paesi addirittura punibile con la reclusione. Questa regola non si applica solo a luoghi appositamente designati per incontri di nudisti (esclusivamente nei paesi con una società democratica progressista), nonché a stabilimenti come le saune. Ma anche questi luoghi sono divisi per genere.
Prima di considerare esempi specifici di norme sociali, è necessario determinarne le caratteristiche ei tipi. La classificazione aiuterà a comprendere meglio comportamenti specifici.
emergenza
Lo sviluppo delle norme sociali è direttamente correlato allo sviluppo della società. Per la prima comunità, i rituali erano abbastanza per regolare le questioni che emergono nel processo di convivenza. Il rituale è una delle prime norme sociali, che è una procedura consolidata nella comunità per eseguire determinate azioni.
I costumi sono considerati una forma di norme più sviluppata rispetto ai rituali. Le norme religiose sono le prossime. La loro formazione avviene nel processo di consapevolezza da parte di una persona della sua insignificanza di fronte ai fenomeni naturali. Ci sono culti di varie divinità, culto delle forze della natura.

Insieme ai costumi e alla religione, compaiono i principi della moralità. E con l'emergere del sistema statale si formano le prime norme giuridiche ed economiche.
Classificazione
Selezioniamo, parlando dei principali tipi di norme sociali, esempi di norme di azione internazionale. Sono strettamente intrecciati e partecipano alla regolazione delle relazioni più contemporaneamente.
Una delle norme primarie di natura su larga scala sono quelle politiche. Sono espressi in varie dichiarazioni e carte, regolano le relazioni nella sfera politica non solo in uno stato, ma anche su scala internazionale. Esempi di norme sociali di natura politica sono le forme di potere attuate negli stati. Ad esempio, per la Gran Bretagna la monarchia è una norma sociale.
I principi economici sono le regole per la distribuzione della ricchezza nella società. Cioè, queste norme danno origine a classi sociali. Idealmente, dovrebbe applicarsi equamente il principio di divisione. I salari sono un esempio di questo tipo di regolamentazione. Le regole economiche, come quelle politiche, possono operare sulla scala di più stati e caratterizzare il ricambio finanziario e delle merci tra di loro. Altri tipi operano su scala ridotta, in formazioni sociali specifiche.
Tipi di norme sociali. Esempi di stato singolo
Le norme giuridiche sono il principale regolatore dei rapporti nello stato. Si tratta di un insieme di regole, per l'inosservanza cui è prevista una punizione sotto forma di sanzione pecuniaria, di responsabilità amministrativa o di reclusione. Se l'insegnante chiede: "Dare esempi di varie norme sociali di uno stato legale", come risposta possono essere chiamati il codice penale della Federazione Russa e il Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa.

Regolano il comportamento di una persona nella società a cui appartiene per nascita o tipo di hobby. Se ti viene chiesto: "Fornisci esempi di norme sociali di questo tipo", allora vale la pena parlare delle regole che una persona forma nel corso della sua vita in determinati ambienti. Lo stato gioca un ruolo importante in questa formazione. Più è sviluppata la cultura dell'intero paese, più norme culturali ha. Ad esempio, in alcuni paesi musulmani, una donna non dovrebbe apparire nella società con una faccia aperta: questa è una norma culturale.
Regole pubbliche
Gli esempi di norme sociali nella società sono diversi, ma ce ne sono diversi globali. Le comunità più grandi sono Le norme religiose servono a regolare i rapporti non solo all'interno di tali comunità, ma anche nei rapporti con organizzazioni e persone che non appartengono alla stessa religione. Esempi di norme sociali di questa natura sono facili da raccogliere. I più comuni sono le cerimonie nuziali e il funerale del defunto. Allo stesso tipo di norme appartengono i rapporti tra l'abate del monastero ei monaci, il santo padre ei parrocchiani della sua chiesa.
Sono di natura storica. Costituiscono il concetto di bello e brutto. Queste regole si applicano non solo a una persona, ma anche alle sue azioni, nonché alle opere d'arte, ai tipi di animali, ecc. Nella società moderna, le norme estetiche a volte hanno un impatto negativo su una persona, sulla sua autostima e , di conseguenza, il suo posto nella vita. Ciò è dovuto al pensiero stereotipato sull'aspetto attraente. Di conseguenza, una persona che non rientra nel quadro generale con il suo aspetto o comportamento potrebbe non essere accettata da una determinata società. Un ottimo esempio di questo è il racconto "Il brutto anatroccolo".
Esempi di diverse norme sociali
Ci sono anche regole che non sono legate a una particolare società o stato. Questi sono i concetti di buono e cattivo. Si formano sulla base di un comportamento specifico preso come standard. Alcuni sono supportati da documenti legali. Fondamentalmente, sono progettati per la coscienziosità di una persona e la sua utilità morale. Il comportamento immorale è seguito dalla condanna da parte della società e in alcuni casi dalla punizione dalla legge.

Anche le norme dei costumi e delle tradizioni sono di natura storica. Sono stati stabiliti per molti secoli e rappresentano un modello di azioni in determinate situazioni. Quali sarebbero esempi di norme sociali in questo caso? Le consuetudini implicano il compimento di qualsiasi azione dovuta all'abitudine, e le tradizioni sono valori o un modello di comportamento adottato dalla società e rigorosamente seguito dai suoi membri. Usanze e tradizioni sono strettamente legate alle norme culturali.
Inoltre, le norme aziendali si distinguono da varie norme sociali, che regolano i rapporti tra dipendenti della stessa struttura o membri dello stesso club di interesse. Tali regole sono stabilite dai membri della comunità, inoltre scelgono e applicano misure per influenzare i trasgressori.
Regole nelle relazioni familiari
Gli esempi di norme sociali che regolano i rapporti familiari sono così diversi che è molto difficile individuarne di specifici. La famiglia è controllata dallo stato, dalle organizzazioni religiose e dalla società. Inoltre, ciascuna parte sta cercando di dirigere le relazioni familiari nella propria direzione. A volte questo numero di regole si ritorce contro.
Se l'insegnante chiede: "Date esempi di norme sociali che influenzano i rapporti familiari", rispondete che si tratta di norme legali e religiose, norme morali, tradizioni e costumi. Tuttavia, non dimenticare che anche il resto delle regole ha una certa influenza, poiché la famiglia è uno stato in miniatura con le sue leggi politiche ed economiche. Forse per questo molti giovani dell'attuale generazione non hanno fretta di mettere su famiglia. Quando a una persona viene detto da tutte le parti cosa deve fare per apparire completa agli occhi del pubblico, il desiderio di qualsiasi azione scompare.
Regole sociali legalizzate
È facile citare esempi di norme sociali che regolano i rapporti familiari, sancite dalla legge. Ad esempio, un evento fondamentale nella vita di una famiglia è il matrimonio. Legalmente, il matrimonio è regolato da norme legali. Stabiliscono la procedura per contrarre matrimonio (presentazione di una domanda, determinazione della data del matrimonio, rilascio di documenti che confermano lo stato civile), nonché la procedura per il processo di divorzio (domanda di divorzio, divorzio attraverso il tribunale, divisione dei beni, nomina di alimenti, ecc.).

Le norme economiche sociali hanno anche una certa influenza sulle relazioni familiari. Da loro dipende il reddito della famiglia, così come la possibilità di ricevere prestazioni sociali. Ciò è particolarmente vero per le famiglie monoparentali. In molti stati hanno diritto a un'assistenza materiale aggiuntiva per risolvere i problemi finanziari.
Questi tipi di norme hanno una base legislativa e la loro influenza è dovuta all'atteggiamento del potere statale nei confronti dell'importanza dell'istituzione della famiglia. Per il pieno sviluppo delle relazioni familiari, tale sostegno è necessario. Ma la sua selettività spesso ostacola solo questo sviluppo.
Regolazione dei rapporti familiari mediante norme sociali
Usanze e tradizioni hanno una grande influenza sui rapporti familiari. Iniziano la loro azione con la decisione di uno dei coniugi di sposarsi. Proposta di matrimonio, fidanzamento e altre usanze formano il concetto di come dovrebbe nascere una famiglia. E coloro che non rientrano in questo quadro sono spesso condannati dal pubblico.
Le norme religiose hanno anche un certo impatto sulle relazioni umane. Nella religione più comune - il cristianesimo - senza sposarsi e creare una famiglia, è impossibile avere figli. In caso contrario, seguirà la condanna della Chiesa. Queste circostanze storiche a volte interferiscono solo con la formazione di una nuova famiglia.

Diamo esempi di norme sociali responsabili del comportamento dei coniugi (norme di moralità). Ad esempio, l'adulterio nel matrimonio è inaccettabile solo dal punto di vista della moralità. Legislativamente, questo non è punito in alcun modo (negli stati democratici). Ma la condanna dell'opinione pubblica in questo caso porterà inevitabilmente al crollo dei rapporti familiari.
Esempi dell'impatto delle norme sociali sul carattere di una persona
Il carattere di una persona dipende in gran parte dalle tradizioni di educazione stabilite nella famiglia, nonché dalle norme e regole che operano nella società circostante. dovrebbe essere vaccinato dalla nascita. Questa è la chiave per la formazione in un bambino fin dalla tenera età dei concetti di cattivo e buon comportamento.
L'opinione degli altri influisce in modo significativo sul carattere di una persona. Il buon atteggiamento delle persone verso se stessi aggiunge fiducia. E capita spesso che un cattivo atteggiamento si basi esclusivamente su norme estetiche. Cioè, una persona per la società non è attraente esternamente. Tale opinione degli altri può portare alla rabbia e alla formazione di principi immorali.
Norme sociali contemporanee
Con l'emergere di un numero enorme di diverse organizzazioni pubbliche, è diventato necessario regolare i rapporti tra di loro e al loro interno. Le norme aziendali sono l'ultimo tipo di norme sociali. Come accennato in precedenza, sono regolati dai rappresentanti di tali organizzazioni.

Se ti viene detto: "Fornisci esempi di varie norme sociali che regolano le relazioni nella società moderna", quale definiresti il primo punto? È sicuro mettere le norme aziendali al primo posto. Dopotutto, senza di loro è impossibile immaginare relazioni civili.
Struttura e attività
Attività- un modo di relazione di una persona con il mondo esterno, consistente nella trasformazione e subordinazione dei suoi obiettivi a una persona.
L'attività umana ha una certa somiglianza con l'attività di un animale, ma differisce in un atteggiamento creativo e trasformativo nei confronti del mondo circostante.
Caratteristiche caratteristiche dell'attività umana:
· Carattere cosciente: una persona propone consapevolmente gli obiettivi dell'attività e ne prevede i risultati, pensa ai modi più opportuni per raggiungerli.
· Natura produttiva: finalizzato all'ottenimento di un risultato (prodotto)
- Carattere trasformativo: una persona cambia il mondo che lo circonda (influenza l'ambiente con mezzi di lavoro appositamente creati che migliorano le capacità fisiche di una persona) e se stesso (una persona mantiene inalterata la sua organizzazione naturale, cambiando allo stesso tempo il suo modo di vivere).
- Personaggio pubblico: una persona nel processo di attività, di regola, entra in varie relazioni con altre persone.
Principali tipi di attività umana:
1. Un gioco- questo è un tipo speciale di attività, il cui scopo non è la produzione di alcun prodotto materiale, ma il processo stesso: intrattenimento, ricreazione. Il gioco, come l'arte, offre una certa soluzione nella sfera condizionale, che può essere utilizzata in futuro come una sorta di modello della situazione. Il gioco permette di simulare specifiche situazioni di vita.
2. Dottrina- un tipo di attività, il cui scopo è l'acquisizione di conoscenze, abilità e abilità da parte di una persona. Le particolarità della dottrina sono che serve come mezzo di sviluppo psicologico di una persona. L'insegnamento può essere organizzato e disorganizzato (autoeducazione).
3. Comunicazione- questo è un tipo di attività in cui c'è uno scambio di idee ed emozioni (gioia, sorpresa, rabbia, sofferenza, paura, ecc.). In base ai mezzi utilizzati si distinguono i seguenti tipi di comunicazione: diretta e indiretta, diretta e indiretta, verbale e non verbale.
4. Lavoro-un tipo di attività finalizzata al raggiungimento di un risultato praticamente utile. Caratteristiche caratteristiche del lavoro: convenienza, concentrazione sul raggiungimento di un risultato specifico, utilità pratica, trasformazione dell'ambiente esterno.
5. Creazione - è un tipo di attività che genera qualcosa di qualitativamente nuovo, qualcosa che non è mai esistito prima. I meccanismi più importanti dell'attività creativa sono: 1) combinare le conoscenze esistenti; 2) immaginazione, cioè la capacità di creare nuove immagini sensoriali o mentali; 3) fantasia, che è caratterizzata dalla luminosità e dall'insolito delle idee e delle immagini create; 4) intuizione - conoscenza, i metodi di ottenimento che non si realizzano.
La struttura dell'attività è solitamente presentata in modo lineare, in cui ogni componente segue l'altra nel tempo:
Bisogno → Motivo → Scopo → Mezzi → Azione → Risultato
Pensiero
Pensiero- un processo attivo di riflessione del mondo oggettivo in concetti, giudizi, teorie, ecc. Il mezzo per esprimere il pensiero è il linguaggio.
TIPI DI PENSIERO
| Digita il nome | La sua essenza |
| Pensiero creativo | Il compito è dato in forma concreta e visiva. L'azione pratica diventa un modo per risolvere un problema. È tipico dei popoli primitivi e delle prime civiltà terrene. |
| Pensiero teorico (concettuale, astratto). | Il problema è formulato in forma teorica. La conoscenza teorica diventa un modo per risolvere un problema. caratteristico delle persone moderne. |
| Segno di pensiero | È collegato alla penetrazione delle scienze esatte e delle lingue dei segni artificiali nella visione del mondo delle persone. La conoscenza è sotto forma di segni linguistici. Il simbolismo è usato nella scienza per esprimere i risultati dell'attività mentale. |
Mobilità sociale
La mobilità sociale è un cambiamento da parte di un individuo o di un gruppo della propria posizione sociale nello spazio sociale. Il concetto è stato introdotto nella circolazione scientifica da P. Sorokin nel 1927. Ha individuato due tipi principali di mobilità: orizzontale e verticale.
Mobilità verticale implica un insieme di movimenti sociali, che è accompagnato da un aumento o una diminuzione dello status sociale di un individuo. A seconda della direzione del movimento, ci sono mobilità verticale ascendente(elevazione sociale) e mobilità verso il basso(declino sociale).
Mobilità orizzontale- questo è il passaggio di un individuo da una posizione sociale ad un'altra, situata allo stesso livello. Un esempio è il passaggio da una cittadinanza all'altra, da una professione all'altra, che ha uno status simile nella società. La mobilità è spesso definita mobilità orizzontale. geografico, il che implica lo spostamento da un luogo all'altro mantenendo lo status esistente (trasferimento in un altro luogo di residenza, turismo, ecc.). Se lo stato sociale cambia quando ci si sposta, allora si trasforma in mobilità geografica migrazione.
Canali social Mobilità - le modalità con cui un individuo si sposta da un gruppo all'altro I canali della mobilità sociale possono essere: scuola, istruzione in generale, famiglia, organizzazioni professionali, esercito, partiti e organizzazioni politiche, chiesa. Queste istituzioni sociali fungono da meccanismi per la selezione e la selezione degli individui, collocandoli nello strato sociale desiderato. Naturalmente, nella società moderna, l'istruzione è di particolare importanza, le cui istituzioni svolgono la funzione di una sorta di "ascensore sociale" fornendo mobilità verticale.
4. Marginale + piccolo
Sotto marginalità si riferisce a uno stato intermedio, “borderline” di un soggetto sociale. Marginale(dal lat. marginale- al limite) mentre si sposta da un gruppo sociale all'altro conserva il vecchio sistema di valori, connessioni, abitudini e non può impararne di nuovi (migranti, disoccupati). In generale, gli emarginati sembrano perdere la loro identità sociale e quindi vivono un grande stress psicologico. grumo
norme sociali.
Secondo le norme sociali comprendere le regole e gli schemi generali, il comportamento delle persone nella società, dovuto alle relazioni sociali e risultante dall'attività consapevole delle persone.
Esistono varie classificazioni delle norme sociali. La più importante è la divisione delle norme sociali in base alle caratteristiche della loro comparsa e attuazione. Su questa base si distinguono cinque varietà di norme sociali: norme morali, norme consuetudinarie, norme estetiche, norme di etichetta, norme religiose e norme giuridiche.
Disposizioni legali- queste sono le regole di comportamento, stabilite o sanzionate dallo Stato, dalla Chiesa. Differenze delle norme legali da tutte le altre:
Istituito solo per conto dello Stato,
obbligatorio
Per non conformità - sanzioni formali
sancito dalla legge (o da altri regolamenti);
Standard morali- valutazione delle azioni sulla scala del morale-immorale, del bene-male, del bene-cattivo.
Norme doganali- si tratta di regole di comportamento che sono diventate un'abitudine a seguito della loro ripetuta ripetizione. L'attuazione delle norme consuetudinarie è assicurata dalla forza dell'abitudine. I costumi di contenuto morale sono chiamati costumi.
Sotto norme religiose si riferisce alle regole di comportamento contenute in vari libri sacri o stabilite dalla chiesa. L'attuazione di questo tipo di norme sociali è fornita dalle convinzioni interne delle persone e dalle attività della chiesa.
STANDARD ESTETICI- queste sono le regole di comportamento che regolano il rapporto con il bello e il brutto. Principi generalmente accettati di attività estetica, creatività e percezione, nonché esempi di valori artistici ed estetici in una determinata comunità sociale e nella sua cultura, regole per creare e percepire opere d'arte
Etichetta- un insieme di regole formali di condotta in situazioni predeterminate, comprese le norme di comunicazione, il protocollo aziendale, ecc.;
Forme di norme sociali (giuridiche).
Secondo la natura delle regole di condotta in esse contenute, le norme di diritto si dividono in autorizzante, vincolante e interdittiva.
Forme di regolazione della legge- Permesso, ordine, divieto.
Norma abilitanteÈ una norma-autorizzazione che stabilisce cosa si può fare.
norma vincolanteÈ una regola che ti dice cosa fare.
Norma proibitivaÈ una regola che ti dice cosa non puoi fare.
©2015-2019 sito
Tutti i diritti appartengono ai loro autori. Questo sito non rivendica la paternità, ma fornisce un uso gratuito.
Data di creazione della pagina: 11-06-2017
Una norma sociale è una regola di comportamento stabilita nella società che regola le relazioni tra le persone, la vita sociale.
Le norme sociali definiscono i confini del comportamento accettabile delle persone in relazione alle condizioni specifiche della loro vita.
Le norme sociali hanno le seguenti caratteristiche comuni: non hanno un destinatario specifico e operano con continuità nel tempo; sorgono in connessione con l'attività volitiva e cosciente delle persone; finalizzato alla regolazione delle relazioni sociali; sorgere nel processo di sviluppo storico; il loro contenuto corrisponde al tipo di cultura e alla natura dell'organizzazione sociale della società.
Caratteristiche chiave di varie norme sociali:
1) Dogana - campioni di azioni di massa approvate dalla società, che si consiglia di eseguire. Ad esempio, la celebrazione del nuovo anno la notte del 1 gennaio, ecc.
2) Tradizioni - valori, norme, modelli di comportamento, idee, atteggiamenti sociali, ecc., ereditati dai predecessori. Le tradizioni si riferiscono al patrimonio culturale; tendono ad essere venerati dalla maggior parte dei membri della società. Ad esempio, riunioni regolari di laureati di un istituto di istruzione, ecc.
3) Norme morali - regole di condotta che esprimono le idee delle persone sul bene o sul male, sul bene e sul male, ecc. Il rispetto delle regole morali è assicurato dall'autorità della coscienza collettiva, la loro violazione è condannata nella società. Ad esempio, "Fai verso gli altri come vorresti che facessero verso di te" ("Regola d'oro" della moralità), ecc.
4) Norme giuridiche - regole di condotta formalmente definite, stabilite o sanzionate dallo Stato e sostenute dal suo potere coercitivo; le norme giuridiche sono necessariamente espresse in forma ufficiale: in leggi o altri atti normativi; queste sono sempre norme scritte; in ogni società particolare / c'è un solo sistema legale. Ad esempio, "È vietato promuovere la superiorità sociale, razziale, nazionale, religiosa o linguistica" (Costituzione della Federazione Russa, articolo 29, paragrafo 2), ecc.
5) Norme religiose - regole di comportamento formulate nei testi dei libri sacri o stabilite da organizzazioni religiose. In termini di contenuto, molti di essi, agendo come norme morali, coincidono con le norme del diritto, rafforzano tradizioni e costumi. Il rispetto delle norme religiose è supportato dalla coscienza morale dei credenti e dalla fede religiosa nell'inevitabilità della punizione per i peccati - deviazione da queste norme. Ad esempio: «Non ripagare male per male a nessuno, abbi cura del bene fra tutti gli uomini... Non vendicarti, amato, ma lascia posto all'ira di Dio» (Nuovo Testamento. Epistola ai Romani, cap. XII), ecc.
6) Norme politiche - regole di condotta che regolano l'attività politica, i rapporti tra il cittadino e lo Stato, tra i gruppi sociali. Si riflettono in leggi, trattati internazionali, principi politici, norme morali. Ad esempio: "Il popolo esercita il suo potere direttamente, nonché attraverso le autorità statali e i governi locali" (Costituzione della Federazione Russa, art. 3, p. 2), ecc.
7) Norme estetiche: fissa le idee sul bello e sul brutto non solo nella creatività artistica, ma anche nel comportamento delle persone al lavoro e nella vita di tutti i giorni. Di solito sono di natura storica. Ad esempio, il sistema di proporzioni ideali del corpo umano sviluppato dall'antico scultore greco Policleto, che divenne la norma nell'era dell'antichità, ecc.
Inoltre, ci sono norme universali, nazionali, di classe, di gruppo, interpersonali.
Le norme differiscono l'una dall'altra nel grado di esecuzione obbligatoria:
- incoraggiante;
- vietare;
- imperativo (lat. imperativus - imperativo); consultivo.
Le norme sociali svolgono le seguenti funzioni nella società: regolano il corso generale della socializzazione; integrare la personalità nell'ambiente sociale; fungere da modelli, standard di comportamento appropriato; controllare il comportamento deviante. La regolamentazione del comportamento umano da parte delle norme sociali viene effettuata in tre modi:
- permesso - indicazione di comportamenti desiderabili, ma non obbligatori;
- prescrizione - un'indicazione dell'azione richiesta;
- divieto - indicazione di azioni che non dovrebbero essere eseguite.
Nelle società sviluppate, le norme sociali stanno diventando sempre più astratte, non regolano le attività degli individui, lasciando loro una certa libertà di autoregolazione del loro comportamento. Ma in questo modo l'individuo è reso responsabile dell'adempimento o del mancato rispetto delle norme sociali. Diventano un criterio e uno strumento per valutare una persona e le sue attività. Concentrandosi sulle norme sociali, l'individuo fa emergere in sé alcune qualità personali.
La regolamentazione normativa delle relazioni sociali nel periodo moderno viene effettuata con l'aiuto di un insieme piuttosto complesso e diversificato di norme sociali. Le norme sociali sono determinate dal livello di sviluppo della società e il loro scopo sono le relazioni sociali. Determinando il comportamento corretto o possibile di una persona, sono creati da gruppi di persone.
Quindi, norme sociali Queste sono le regole che regolano il comportamento delle persone e le attività delle organizzazioni che creano in relazione tra loro. Le norme sociali sono caratterizzate dal fatto che sono:
Regole per la condotta delle persone, indicando quali dovrebbero essere le loro azioni;
Regole di comportamento di carattere generale (in opposizione alle regole individuali);
Non solo regole generali, ma anche obbligatorie per il comportamento delle persone nella società, che sono previste a tal fine da misure di influenza coercitive.
Grazie a queste proprietà, le norme sociali sono in grado di avere un impatto normativo sulle relazioni sociali e sulla coscienza dei loro partecipanti.
La varietà dei tipi di norme sociali è spiegata dalla complessità del sistema delle relazioni sociali, nonché dalla molteplicità dei soggetti che svolgono la regolazione normativa delle relazioni sociali.
Tutte le norme sociali che operano nella società moderna sono divise secondo due criteri principali:
Il metodo della loro formazione (creazione);
Metodo di garanzia (protezione, protezione).
In base a questi criteri, si distinguono i seguenti tipi di norme sociali:
Legge- regole di comportamento stabilite e tutelate dallo Stato.
Standard morali(morale, etica) - regole di condotta che sono stabilite nella società in conformità con le idee delle persone su bene e male, giustizia e ingiustizia, dovere, onore, dignità e sono protette dalla violazione dal potere dell'opinione pubblica o dalla convinzione interiore.
Norme doganali- queste sono le regole di comportamento che si sono sviluppate nella società a seguito di ripetute ripetizioni in un arco di tempo storicamente lungo e sono diventate un'abitudine delle persone; sono protetti dall'essere violati dal naturale bisogno interiore delle persone e dalla forza dell'opinione pubblica.
Norme degli enti pubblici(norme aziendali) - regole di condotta stabilite dagli stessi organismi pubblici e protette da misure di influenza pubblica previste dagli statuti di tali organismi.
Norme religiose- le regole di condotta, che sono stabilite dai vari credi, sono utilizzate nello svolgimento dei riti religiosi e sono protette dalle misure di pubblica influenza previste dai canoni di queste religioni.
Le caratteristiche distintive del diritto come regolatore sociale sono la sua natura formale, ad es. la sua espressione esterna nelle fonti giuridiche ufficiali (leggi, convenzioni internazionali, decisioni giudiziarie, ecc.), interconnessione sistemica o chiara di norme giuridiche, prescrizioni universalmente vincolanti, sicurezza con coercizione statale in caso di violazione delle norme di legge.
La divisione delle norme sociali è possibile anche per contenuto. Su questa base si distinguono le norme economiche, politiche, ambientali, lavorative, familiari, ecc. Le norme sociali nella loro totalità sono chiamate regole della società umana.
Diritto e morale
I più importanti regolatori del comportamento umano sono sempre stati i costumi, la legge e la moralità. Come sapete, le regole più antiche del comportamento umano erano le consuetudini. L'usanza è più vicina all'istinto, perché la gente la esegue senza pensare al motivo per cui è necessaria: è proprio così da tempo immemorabile. Il costume ha radunato e razionalizzato la comunità primitiva di persone, ma dove non hanno superato il suo dominio, lo sviluppo della società si è bloccato a un punto morto, perché i costumi soffocavano l'immaginazione creativa, il desiderio di qualcosa di nuovo, di insolito.
La sorella minore della consuetudine era un altro sistema di regole di condotta: la moralità. Le regole morali sorgono spontaneamente come le consuetudini, ma differiscono dalle consuetudini in quanto hanno una base ideologica. Una persona non si limita a ripetere meccanicamente ciò che è stato eseguito prima di lui da tempo immemorabile, ma fa una scelta: deve agire come gli prescrive la moralità. Cosa guida una persona, giustificando la sua scelta? Una coscienza che fa nascere il senso del dovere. Il significato del dovere morale è che una persona si riconosce in un'altra, simpatizza con un'altra.
Sebbene la morale, come la consuetudine, orientasse una persona all'osservanza degli interessi collettivi, all'azione collettiva, fu un importante passo avanti rispetto alla consuetudine nella formazione di un principio individuale nelle persone in quanto esseri naturali. La moralità è un sistema di principi di una relazione profondamente personale di una persona con il mondo dal punto di vista del dovuto. La moralità è, prima di tutto, una guida di vita, che esprime il desiderio di auto-miglioramento di una persona. La sua funzione principale è l'affermazione del vero umano nell'uomo. Se la ripetizione meccanica dei costumi è ancora vicina all'istinto, allora la coscienza, il dovere, il senso di responsabilità insito nella morale sono assolutamente estranei al mondo naturale, sono i frutti della "seconda natura" dell'uomo - la cultura.
È con lo sviluppo culturale della società che le persone iniziano gradualmente a formare i propri bisogni e interessi individuali (economici, politici, sociali). E in connessione con la protezione dell'individuo, dell'individuo e dei suoi interessi personali, è sorto un terzo sistema di regole di condotta: il diritto. La formazione di questo sistema è strettamente connessa con l'emergere della disuguaglianza all'interno della comunità di persone che seguì la rivoluzione neolitica (il passaggio da un'economia di appropriazione a una produttiva). La disuguaglianza si sviluppò in due direzioni: disuguaglianza di prestigio e, di conseguenza, di influenza e potere, e disuguaglianza di proprietà. Naturalmente, i proprietari di questi valori (prestigio o proprietà) hanno la necessità di proteggerli dalle usurpazioni degli altri, così come la necessità di snellire nuove relazioni sociali in modo che ognuno "conosca il suo posto" secondo le capacità personali.
Sorge quindi inizialmente il diritto di esprimere le pretese delle persone per determinati benefici come un permesso ottenuto da un individuo al fine di soddisfare i propri bisogni attraverso un forte impatto su altri individui. Ma questo metodo di protezione non era abbastanza affidabile. Inoltre, usando la forza, non puoi tanto proteggere i tuoi quanto appropriarti dei diritti degli altri. Ciò ha portato al disordine, minacciando la morte della società. Nasceva così nella società una nuova organizzazione, volta a snellire i rapporti tra le persone - lo Stato, e lo strumento dello Stato era la legge - atto emanato dallo Stato e vincolante a pena di coercizione fisica. La legge (e altre fonti ufficiali) fissava i diritti riconosciuti dalla società (pretese alle prestazioni sociali). Pertanto, il diritto può essere caratterizzato come un insieme di regole di condotta che definiscono i confini della libertà e dell'uguaglianza delle persone nell'attuazione e nella tutela dei loro interessi, che sono sancite dallo Stato nelle fonti ufficiali e la cui attuazione è assicurata dal potere coercitivo dello Stato.
Attualmente, le norme giuridiche e morali occupano una posizione dominante e dominante nel sistema normativo. Ciò è dovuto non da ultimo al fatto che entrambi hanno la portata più ampia: potenzialmente coprono l'intera società. A questo proposito, la portata della moralità e della legge si sovrappone in larga misura. Allo stesso tempo, sono elementi indipendenti del sistema normativo, la cui unità, interrelazioni e interazioni meritano un'attenzione particolare.
L'unità delle norme giuridiche e delle norme morali si basa sulla comunanza degli interessi socio-economici, della cultura della società e dell'impegno delle persone per gli ideali di libertà e giustizia. L'unità tra diritto e morale si esprime nel fatto che:
Nel sistema delle norme sociali, esse sono le più universali, estendendosi all'intera società;
Le norme della morale e del diritto hanno un unico oggetto di regolamentazione: le pubbliche relazioni;
Come le regole del diritto, le norme della moralità provengono dalla società;
Le norme di diritto e le norme di moralità hanno una struttura simile;
Le norme del diritto e le norme della morale si distinguevano dai costumi fusi (sincretici) della società primitiva nel corso della sua decomposizione.
Legge e moralità perseguono un obiettivo comune: armonizzare gli interessi dell'individuo e della società, lo sviluppo e l'elevazione spirituale di una persona, la protezione dei suoi diritti e libertà, il mantenimento dell'ordine pubblico e dell'armonia. La morale e il diritto agiscono come misura della libertà personale dell'individuo, fissano i confini dei comportamenti consentiti e possibili nella situazione da essi regolata e contribuiscono all'equilibrio di interessi e bisogni. Sono valori storici generali fondamentali, fanno parte del contenuto della cultura delle persone e della società, mostrano il livello di progresso sociale della civiltà.
Tuttavia, le norme di legge e le norme di moralità differiscono ancora l'una dall'altra per le seguenti caratteristiche:
Per origine. Le norme morali si formano nella società sulla base di idee sul bene e sul male, sull'onore, sulla coscienza, sulla giustizia. Acquisiscono un significato obbligatorio in quanto sono riconosciuti e riconosciuti dalla maggioranza dei membri della società. Le norme di diritto stabilite dallo Stato, dopo la loro entrata in vigore, diventano immediatamente vincolanti per tutte le persone che rientrano nel loro ambito.
La forma espressiva. Le norme di moralità non sono fissate in atti speciali. Sono contenuti nella mente delle persone, esistono e agiscono come un insieme di regole non scritte sotto forma di insegnamenti e parabole. I recenti tentativi di imporre alla società i comandamenti chiaramente formulati dalle autorità di partito superiore nella forma del Codice morale del costruttore del comunismo ("L'uomo è amico, compagno e fratello") difficilmente possono essere considerati un esperimento riuscito. A loro volta, le norme legali nelle condizioni moderne ricevono molto spesso un'espressione scritta negli atti ufficiali dello stato (leggi, decreti, decisioni, decisioni dei tribunali, ecc.), Il che aumenta la loro autorità, rende i loro requisiti chiari e definiti.
Secondo il meccanismo di influenza. La legge può regolamentare solo le azioni delle persone, ad es. solo quelle azioni (o inazione) di esse che sono percepite e riconosciute dallo stesso soggetto agente come atti sociali, come manifestazioni del soggetto, che esprimono il suo atteggiamento verso le altre persone. Le norme legali non possono interferire direttamente con il mondo dei pensieri e dei sentimenti. Ha valore giuridico solo il comportamento di una persona o di un gruppo che si esprime all'esterno, nell'ambiente fisico esterno, sotto forma di movimenti del corpo, azioni, operazioni, attività svolte nella realtà oggettiva.
«Solo nella misura in cui mi manifesto, nella misura in cui entro nel regno della realtà, entro nel regno che è soggetto al legislatore. A parte le mie azioni, - scriveva Marx, - non esisto affatto per la legge, non ne sono affatto l'oggetto. Pertanto, una persona non può essere ritenuta legalmente responsabile dei sentimenti vili e dei pensieri sporchi se non sono stati oggettivati all'esterno in una o nell'altra forma pubblica, ma la moralità condanna inequivocabilmente entrambi. La moralità esige non solo la nobiltà delle azioni, ma anche la purezza dei pensieri e dei sentimenti. L'azione delle norme morali si realizza attraverso la formazione di atteggiamenti interni, motivazioni di comportamento, valori e aspirazioni, principi di comportamento, e in un certo senso non implica la presenza di alcuni meccanismi regolatori prestabiliti esternamente. Come sapete, il principale meccanismo interno di autoregolazione morale è la coscienza, e il meccanismo esterno informale sono i costumi e le tradizioni come la saggezza collettiva secolare del popolo.
A titolo di tutela dalle violazioni. Nella stragrande maggioranza dei casi, le norme morali e le norme giuridiche sono osservate volontariamente sulla base della naturale comprensione delle persone della giustizia delle loro prescrizioni. L'attuazione di entrambe le norme è assicurata dalla convinzione interna, oltre che dall'opinione pubblica. La società stessa, le sue istituzioni civiche, i collettivi decidono le forme di risposta alle persone che non rispettano i divieti morali. Allo stesso tempo, l'influenza morale non può essere meno efficace di quella legale, e talvolta anche più efficace. "Le lingue malvagie sono peggio di una pistola!" esclamò Molchalin nella famosa commedia di Griboedov. Tali metodi di protezione sono abbastanza sufficienti per gli standard morali. Per garantire le norme legali, vengono utilizzate anche misure di coercizione statale. Le azioni illegali comportano la reazione dello Stato, ad es. responsabilità giuridica speciale, la procedura di imposizione che è strettamente regolata dalla legge ed è di natura procedurale. Una persona è punita per conto dello Stato. E sebbene in ogni singolo caso gli interessi dei singoli "privati" possano essere direttamente violati, lo Stato non può affidare a tali "privati" l'applicazione di misure di responsabilità legale all'autore del reato. L'autore del reato si opponeva apertamente alla sua volontà alla volontà generale incarnata dallo stato nelle norme del diritto, e la sua condanna e punizione non dovrebbero essere solo personali, ma anche statali. Lo Stato, anche nell'autore del reato, deve vedere «una persona, una particella viva della società in cui batte il sangue del suo cuore, un soldato che deve difendere la patria, un membro della comunità che svolge funzioni pubbliche, il capo della famiglia, la cui esistenza è sacra, e, infine, soprattutto, cittadino dello stato. Lo stato non può sottrarre con leggerezza uno dei suoi membri a tutte queste funzioni, perché lo stato si sottrae le sue parti viventi ogni volta che fa di un cittadino un criminale.
Anche le conseguenze di un comportamento immorale e immorale possono essere gravi e irreparabili. Tuttavia, la violazione delle norme morali, in generale, non comporta l'intervento degli organi statali. In termini morali, una persona può essere una persona estremamente negativa, ma non è soggetta a responsabilità legale se non commette atti illegali. La responsabilità per violazione degli standard morali è di natura diversa e non ha una forma e una procedura di attuazione rigorosamente regolamentate. La moralità ha un sistema sanzionatorio tradizionale e piuttosto limitato. La punizione si esprime nel fatto che il trasgressore è soggetto a condanna morale o addirittura coercizione, gli vengono applicate misure di influenza sociale e individuale (osservazione, richiesta di scuse, cessazione di rapporti amichevoli e di altro tipo, ecc.). Questa è una responsabilità verso le persone circostanti, i collettivi, la famiglia e la società, e non verso lo stato.
In termini di dettaglio. Le norme morali agiscono come le regole di comportamento più generalizzate (sii gentile, giusto, onesto, non invidiare, ecc.). I requisiti della moralità sono categorici e non conoscono eccezioni: “non uccidere”, “non mentire”. Le norme legali sono dettagliate, rispetto alle norme morali, alle regole di condotta. Stabiliscono diritti e obblighi legali chiaramente definiti dei partecipanti alle pubbliche relazioni. Dando una formula specifica di comportamento lecito, il diritto cerca di designare in dettaglio tutte le opzioni per i divieti. Ad esempio, il comandamento “Non uccidere” nel diritto penale è rappresentato da un intero registro di componimenti: semplice omicidio; l'omicidio di un neonato da parte di una madre; omicidio commesso in uno stato passionale; un omicidio commesso quando sono stati superati i limiti della difesa necessaria o sono state superate le misure necessarie per trattenere una persona che ha commesso un reato; e anche causando la morte per negligenza. Inoltre, come si vede, la legge ritiene lecito (fatte salve le condizioni previste dalla legge) cagionare la morte in stato di necessaria difesa, ovvero durante l'arresto di un criminale.
Per ambito. Le norme morali coprono quasi tutte le aree delle relazioni umane, compresa la sfera giuridica. La legge interessa solo gli ambiti più importanti della vita pubblica, regolando solo le pubbliche relazioni controllate dallo Stato. Come già notato, la moralità è progettata per influenzare il mondo interiore di una persona, per formare una personalità spirituale, mentre la legge non è in grado di invadere la sfera dei sentimenti e delle emozioni, nel profondo mondo interiore di una persona. Tuttavia, la portata della moralità non è illimitata. La maggior parte degli aspetti procedurali e procedurali legali (la sequenza delle fasi del processo legislativo, la procedura per lo svolgimento di un'udienza giudiziaria, l'ispezione del sito durante un incidente stradale) sono eticamente neutri e, pertanto, non possono essere regolati dalla moralità.
Non dobbiamo dimenticare che in ogni Paese, come regola generale, è ufficialmente riconosciuto un unico e unico sistema di diritto, al quale l'intera popolazione di questo Paese deve obbedire. I requisiti morali non costituiscono un sistema così unico e unico. La moralità può essere differenziata in base alla classe, alla divisione nazionale, religiosa, professionale o di altro tipo della società: la moralità dominante è quella aziendale, la moralità dell'élite dominante e quella dei governati. La "moralità" di gruppo delle parti della società particolarmente criminalizzate ed emarginate si discosta più spesso dalle norme legali comuni a tutti i cittadini, di cui si possono trovare esempi sorprendenti in un numero considerevole nella vita della moderna società russa. Tuttavia, la loro replicazione attraverso i media senza la dovuta enfasi sulla negatività e la patologia estrema di tali fenomeni porta già alla diffusione di tali sottoculture di singoli gruppi nell'intera società (ad esempio, nel linguaggio della comunicazione quotidiana).
Esistono differenze nei principi morali e negli atteggiamenti morali non solo tra determinati gruppi sociali (si possono indicare le peculiarità dell'etica professionale di medici, avvocati, insegnanti, ecc.), ma anche tra persone dello stesso gruppo sociale. Basti ricordare la morale individuale di uno degli eroi dei romanzi di L.N. Tolstoj - Vronsky: “La vita di Vronsky è stata particolarmente felice perché aveva una serie di regole che senza dubbio determinavano tutto ciò che doveva e non doveva essere fatto. Queste regole senza dubbio stabilivano che l'imbroglione doveva essere pagato, ma il sarto no; che gli uomini non dovrebbero mentire, ma le donne possono; che non puoi ingannare nessuno, ma puoi ingannare tuo marito; che non si possono perdonare insulti e si possono insultare, ecc. È chiaro che tali norme giuridiche "individuali" non possono esistere.
Secondo il principio di azione. Nella letteratura giuridica, è stato a lungo notato che lo stato di diritto deriva dall'uguaglianza formale tra le persone a cui si applica. La legge in questo senso è l'applicazione di una scala uguale a persone diverse. Ad esempio, nella società moderna operano i principi del suffragio universale ed eguale, secondo il quale tutti gli elettori hanno un voto, anche se qualcuno è istruito, e qualcuno non è molto versato nei problemi politici, e qualcuno è peggio, ecc. Ma la legge non può agire diversamente, perché tutela ed esprime l'interesse di ciascuno - in questo caso - l'elettore, e gli interessi di tutti gli elettori sono uguali. La moralità non riconosce questa uguaglianza. Secondo i suoi canoni, a chi più è dato, più sarà richiesto.
Le differenze tra legge e moralità servono come base per la loro interazione e cooperazione. Servono obiettivi elevati: gli ideali di bontà e giustizia, il raggiungimento dell'armonia e della prosperità, lo sviluppo dell'individuo e della società, la fornitura e il mantenimento dell'ordine pubblico. L'attuazione delle norme legali, la loro attuazione è in gran parte determinata dalla misura in cui rispettano le norme morali. Affinché le norme giuridiche operino efficacemente, devono almeno non contraddire i valori morali della società. In alcuni casi, la legge aiuta a liberare la società da norme morali obsolete. Ad esempio, è stato attraverso il diritto che è andato il processo di superamento delle faide di sangue, uno dei postulati della moralità del passato. Allo stesso tempo, una serie di norme legali (in particolare le norme penali) fissano direttamente le norme morali nella legge, rafforzandole con sanzioni legali.
La moralità non è solo relativamente indipendente rispetto alla legge e alle numerose condizioni esterne, ma per molti aspetti un fenomeno immutato in periodi di tempo significativi. È caratterizzato da una certa costante, che, nonostante tutti i cambiamenti nell'economia, nella politica e nelle strutture di potere, conserva un certo tipo di pensiero morale originario, che è alla base, tra l'altro, della tradizione giuridica russa. È la mentalità come riflesso degli strati più profondi della psicologia morale e giuridica che permette di vedere come si formi un modello efficace di organizzazione della vita sociale di un individuo e di un popolo all'interno di una specifica cultura e tradizione.
Al riguardo, non si può categoricamente sostenere che la legge venga applicata solo con metodi coercitivi. Dopotutto, la maggior parte dei cittadini rispetta le norme legali volontariamente e non temendo una punizione. Naturalmente, l'attuazione della legge è un processo complesso in cui vengono utilizzati anche metodi di persuasione, prevenzione ed educazione al fine di incoraggiare i soggetti a obbedire alla legge. La ricerca psicologica ha dimostrato che fattori come la fiducia, l'onestà, la veridicità e il senso di appartenenza sono molto più importanti della coercizione per garantire il rispetto delle regole. Come G.J. Berman, è proprio quando si dà fiducia alla legge, e non sono richieste sanzioni coercitive, che essa diventa efficace: chi governa la legge non ha bisogno di essere ovunque con il suo apparato di polizia. Ciò è dimostrato oggi per contraddizione, dal fatto che nelle nostre città quel ramo del diritto, le cui sanzioni sono le più severe, cioè quella penale, si è rivelato impotente e non può generare timore là dove non è riuscito a creare rispetto per Altri significati. Oggi tutti sanno che nessuna forza che la polizia può usare può fermare la criminalità urbana. In definitiva, il crimine è frenato dalla tradizione del rispetto della legge, che, a sua volta, si basa proprio sulla profonda convinzione che il diritto non è solo un'istituzione di politica laica, ma è anche legato al fine e al significato più alto della nostra vita . Strettamente contigui, diritto e moralità, di regola, si sostengono a vicenda nello snellire le relazioni sociali, nell'influenzare positivamente l'individuo, nel plasmare una corretta cultura morale e giuridica tra i cittadini e nella prevenzione di una serie di reati. Reati come il gioco d'azzardo, la prostituzione o la tossicodipendenza generalmente non implicano un desiderio consapevole di causare danni, ma sono indicati come "crimini senza vittima". In questo caso, non basta abolire per loro le consuete sanzioni penali legate alla reclusione o alle multe, liberando così molto tempo ed energie per le forze dell'ordine, i tribunali e le autorità penitenziarie. In questo caso, è più opportuno creare nuove procedure legali, sia nell'ambito degli stessi tribunali penali sia al di fuori di essi: nuovi servizi pubblici come le liturgie - per prendere decisioni (purché il comportamento di tali persone sia antisociale), compreso il partecipazione di psicologi, assistenti sociali, clero, ma anche familiari, amici, vicini di casa - prima, durante e dopo l'udienza. La maggior parte dei delinquenti non sono affatto malati e dobbiamo affrontare questi casi in modo più umano e creativo, condannando non le persone, ma il loro comportamento e le condizioni specifiche che danno origine a questo comportamento.
Quindi, nel processo di esercizio delle loro funzioni, legge e moralità dovrebbero aiutarsi a vicenda nel raggiungimento di obiettivi comuni, usando i propri metodi per questo. E la sfida è rendere questa interazione il più flessibile e profonda possibile. Ciò è particolarmente importante in quei rapporti in cui ci sono dei confini tra il legalmente punibile e il socialmente riprovevole, dove i criteri legali e morali sono strettamente intrecciati. I criteri morali e legali sono i concetti di base - bene, male, onore, dignità, dovere, ecc., così come i principi - giustizia, umanesimo, rispetto, apertura, uguaglianza formale, ecc.
Questa complessa interdipendenza tra diritto e moralità si esprime nel fatto che questi principi fondamentali sono tuttavia comuni, universali per l'intero sistema normativo e normativo della società. Tuttavia, è nel diritto che la giustizia, come espressione formale dell'eguaglianza nella libertà, caratterizza principalmente l'impegno esterno alla morale, connesso ad essa solo attraverso la forma normativa, e non il contenuto interno. Approssimativamente la stessa opinione è condivisa da V.S. Nersesyants: “... la giustizia è inclusa nel concetto di diritto... il diritto è per definizione giusto, e la giustizia è una proprietà interna e una qualità del diritto, una categoria giuridica e caratteristica, non extragiuridica... solo diritto e giusto. La giustizia, infatti, è proprio giusta perché incarna ed esprime una correttezza universalmente valida, e questo, nella sua forma razionalizzata, significa legittimità universale, vale a dire. l'essenza e l'inizio del diritto, il significato del principio giuridico dell'uguaglianza e della libertà universali. Sia nel significato che nell'etimologia (iustitia) risale al diritto (ius), denota la presenza di un principio giuridico nel mondo sociale ed esprime la sua correttezza, imperatività e necessità.
Diritto e moralità "collaborano" fruttuosamente nel campo dell'amministrazione della giustizia, delle attività di contrasto e della giustizia. Questo può essere espresso in varie forme: quando si risolvono casi specifici, si analizzano tutti i tipi di situazioni di vita, azioni illegali e la personalità dell'autore del reato. Spesso la legge non può qualificare questo o quell'atto come reato (delitto) senza criteri morali appropriati (un atto del genere è malvagio), poiché altrimenti è impossibile determinare correttamente i segni e la misura di responsabilità di atti come "teppismo", " insulto", " calunnia", "umiliazione dell'onore e della dignità", concetti valutativi di "cinismo", "crudeltà speciale", "interesse personale", "motivi vili", "ostilità personale", "danno morale", ecc. , fungendo da moventi ed elementi di molti reati.
La stretta interazione delle norme del diritto e della moralità non significa che questo processo sia regolare, regolare e privo di conflitti. Tra di loro possono spesso sorgere forti contraddizioni, collisioni e discrepanze. I requisiti morali e legali non sempre e non in tutto concordano, e spesso si contraddicono direttamente. Ad esempio, in Russia, l'assistenza reciproca era ampiamente nota nel catturare un criminale sulla scena di un crimine, un ladro in un furto o un adultero tra le braccia della moglie di qualcun altro. La punizione seguì immediatamente e non comportò conseguenze: vendetta di sangue, poiché era considerata una cosa ovvia (eseguita secondo coscienza, secondo consuetudine). Anche in epoca sovietica la poligamia era condannata sia dalla moralità che perseguita dal codice penale (punito con la reclusione). Nel frattempo, il moderno codice penale della Federazione Russa in relazione a tali atti è semplicemente silenzioso, ad es. del tutto neutrale, e in ambito morale, tale reato si riferisce a un comportamento immorale molto grave che distrugge l'unione familiare come base della socializzazione morale dell'individuo e fondamento della società.
Le ragioni delle contraddizioni emergenti tra diritto e morale risiedono nella loro specificità, nel fatto che hanno differenti modalità di regolazione, differenti approcci, differenti criteri di valutazione del comportamento dei soggetti. Ciò che conta è l'inadeguatezza della loro riflessione sui processi sociali reali, gli interessi dei vari strati sociali, gruppi, classi. La discrepanza tra diritto e moralità è causata dalla complessità e dall'incoerenza, dallo squilibrio della vita sociale stessa, dall'infinita varietà di situazioni di vita che si presentano in essa, dall'emergere di nuove tendenze nello sviluppo sociale, dal livello ineguale di sviluppo morale e giuridico di la coscienza delle persone, la variabilità delle condizioni sociali e naturali, ecc.
La morale è per sua natura più conservatrice del diritto, inevitabilmente è in ritardo rispetto al flusso della vita, alle tendenze dello sviluppo economico, scientifico, tecnologico e politico della società e, di conseguenza, ai racconti dei legislatori che cercano di rifletterli in atti normativi. La moralità si è formata nel corso dei secoli e il contenuto delle norme legali è cambiato in un modo o nell'altro con ogni nuovo sistema politico. E ora la legge è più mobile, dinamica, attiva ed elastica nella sua risposta ai cambiamenti in atto (problemi di cambio di sesso, omosessualità, eutanasia e aborto, modifica del sesso del feto nelle prime fasi della gravidanza su richiesta dei genitori, ecc.). Il diritto, con il suo temperamento instancabile e la sua giovinezza, la novità e il carattere rivoluzionario, la formalità e l'utilitarismo, per così dire, spinge la moralità nel suo sviluppo a cambiamenti corrispondenti all'attuale livello di sviluppo della società.
Possono sorgere anche situazioni di conflitto tra le norme del diritto e della morale, che sono negative non solo per l'individuo, ma anche per l'intera società nel suo insieme. Molto di ciò che è consentito dalla legge può essere proibito dalle norme morali e viceversa, ciò che vieta la legge consente la moralità. Così, ad esempio, le norme della legislazione russa (la legge del 1992 "Sul trapianto di organi e (o) tessuti umani") fissano la presunzione del "consenso individuale al trapianto". Nel frattempo, alcuni cittadini, a causa di varie convinzioni morali e religiose, sono categoricamente contrari al fatto che il loro parente defunto sia un donatore, tuttavia, la legge richiede il trapianto per salvare la vita di altre persone, se il defunto non si è espresso nella forma prescritta la sua riluttanza a essere oggetto di trapianto. Altrettanto acuto è il problema dell'eutanasia. Alcuni ritengono che il dovere morale del medico sia la cessazione umana della sofferenza, mentre altri ritengono immorale l'intervento di altre persone in materia di vita o di morte. Ci sono sostenitori e oppositori dell'eutanasia sia nei paesi in cui è ufficialmente consentita (la legge lo consente, ma la moralità condanna), sia in quelli in cui è ufficialmente vietata (la legge vieta, ma la moralità consente).
Valutati anche ambiguamente dalla legge e dalla morale, ad esempio, clonazione (ripetizione del genotipo da cellule staminali) di animali e umani, matrimoni multipli e divorzi della stessa persona. Nel frattempo, è ovvio che qui sorge un altro problema più acuto: gli obiettivi morali e le linee guida per la scienza stessa, l'attività scientifica e l'esperimento scientifico. Può la scienza, percorrendo la via del progresso e dell'evoluzione, anche ai fini più nobili dell'illuminazione e della conoscenza della verità scientifica, violare gli imperativi morali?
Le conseguenze dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, così come la creazione nel 1953 dell'A.D. La bomba all'idrogeno di Sacharov, in grado di distruggere tutta la vita entro un raggio di diverse decine di chilometri, avrebbe dovuto rendere sobria l'umanità e porre fine a questo problema per tutta la scienza. E il punto qui non è nei politici immorali e senza principi che possono usarlo per i propri interessi egoistici, ma nella scienza stessa, che, deificandosi, si è staccata (in parte per colpa dello stato) dalla società, dal suo ambiente morale e spirituale , i suoi interessi vitali . Non può essere al di fuori dei principi morali, ma, al contrario, deve osservarli, affermarli e perfino lottare per essi insieme alla parte attiva della società, indicando le direzioni per un equilibrato, e non patologico, progresso della civiltà. E, purtroppo, il diritto, essendo in prima linea nel cambiamento sociale, non può far fronte al difficile compito di contenere le patologie spirituali e morali in tutti gli ambiti della vita sociale, e talvolta le intensifica.
Pertanto, il peso specifico, la portata di questo o quel regolatore in diverse epoche storiche si espanse o si restrinse. Nelle condizioni attuali dello stato di crisi della società russa e dell'intera civiltà, le contraddizioni tra diritto e moralità si sono estremamente aggravate. La soglia dei requisiti morali per l'individuo e la società è fortemente diminuita. La legalizzazione di molte forme dubbie di arricchimento, la ricerca sfrenata del profitto e del piacere delle anime non sviluppate hanno gravemente minato le basi morali della società.
I valori sociali e spirituali sono cambiati. La moralità della maggioranza sottosviluppata della società è diventata più tollerante e indulgente verso ogni tipo di destrezza e azioni illegali. A causa della dilagante criminalizzazione della società, il diritto non esercita efficacemente le sue funzioni regolatorie e protettive, a volte semplicemente “non si accorge” di molti pericolosi fenomeni antisociali.
Va notato che la combinazione ottimale di etico e giuridico è sempre stata un problema intrattabile di tutti gli ordinamenti giuridici. E, come mostra l'esperienza, qui non è possibile raggiungere l'armonia ideale: le contraddizioni inevitabilmente persistono, ne sorgono di nuove, quelle vecchie si aggravano. Possono essere ridotti in una certa misura, indeboliti e levigati, ma non completamente rimossi.
Non una sola società ha raggiunto le vette della moralità, poiché la moralità non è una costante assoluta, ma relativa. Questa è una ricerca senza fine dell'ideale e dell'armonia, dell'equilibrio e del conformismo, dell'adeguatezza e della proporzionalità, della giustizia e dell'opportunità, dell'umanesimo e della retribuzione. Questo è un movimento verso lo sviluppo, il miglioramento e l'auto-miglioramento, l'infinito e il progresso.
Domande e compiti per il lavoro indipendente:
- 1. Dare il concetto di sistema socio-normativo.
- Qual è l'essenza della non regolamentazione? Descrivi i suoi tipi.
- Quali sono i tipi di regolatori sociali e ne elencano le caratteristiche principali?
- Qual è il rapporto tra diritto e moralità?
- Mostra le differenze tra legge e moralità secondo i criteri principali.
Letteratura aggiuntiva sull'argomento:
- Ageshin Yu.A. Politica, diritto, moralità. Giusto. M. 1982.
- Baranov VM Norme societarie e legali: alcuni problemi di interazione nella Russia moderna // Potere e società Aspetti sociali dell'interazione. N.Novgorod. 1997.
- Baturin Yu.M. Problemi di diritto informatico. M. 1991.
- Golovkin RB Il diritto nel sistema di regolamentazione normativa della società moderna. Vladimir. 1999.
- Emelyanov SA Diritto: definizione del concetto. M. 1992.
- Kozlikhin I..Yu. Diritto e politica. SPb. 1996.
- Maltsev GV Giustizia sociale e diritto. M. 1977.
- Maltsev GV Fondamenti sociali del diritto. M., 2008.
- Maltsev GV Fondamenti morali del diritto. M., 2008.
- Marx K., Engels F. Critica del programma di Gotha (qualsiasi edizione).
- Matuzov NI Il diritto nel sistema delle norme sociali //Giurisprudenza. 1996. N. 2.
- Motovilovker E.Ya. Teoria del diritto normativo e di tutela. Voronez. 1990.
- Cherdantsev AF Il concetto di norme tecniche e giuridiche e il loro ruolo nella formazione delle relazioni sociali /\Stato e diritto sovietico. 1964. N. 1.
- La pura dottrina del diritto di Hans Kelsen. M. 1987.
LEZIONE 8. PROBLEMI DELL'ESSENZA DEL DIRITTO
8.1. I principali concetti di comprensione del diritto (marxista, psicologico, normativo, diritto naturale, sociologico)
Le persone cercano un concetto di diritto che assorba tutta la ricchezza di questo fenomeno sociale. Comprendere la natura del diritto ha una ricca storia. Sono note il diritto naturale, storico, realistico, psicologico, normativo, sociologico, positivista e alcune altre dottrine del diritto. Differiscono in modo significativo l'uno dall'altro. Se per uno di essi il diritto è prima di tutto un fenomeno naturale (Cicerone, Locke), per l'altro è espressione dello spirito storicamente sviluppato del popolo (Savigny, Pukhta), per il terzo è un interesse protetto dallo stato (Iering, Trubetskoy), per il quarto - l'esperienza imperativa delle persone (Petrazhitsky, Merilla, Frazer), per il quinto - il regolatore esterno della vita sociale (Stammer, Kelsen), per il sesto - il sistema dei rapporti giuridici, comportamento delle persone (Erlich, Shershenevich), ecc. Nonostante tutte le differenze, molte di queste dottrine hanno rappresentato un passo nella conoscenza della natura del diritto. Insieme a idee che si sono rivelate ingiustificate, contenevano punti razionali che hanno contribuito alla dottrina generale del diritto. A questo proposito, è necessario caratterizzarli in modo più dettagliato.
Lo studio del fenomeno del diritto come istituzione sociale integrale si chiama conoscenza giuridica. Metodologia della conoscenza giuridica- si tratta di aree speciali della scienza che studiano la natura, i principi ei metodi di studio del diritto. Questi principi e metodi di conoscenza del diritto si basano, a loro volta, su assiomi-postulati ontologici sulle specificità (natura) della realtà sociale. Pertanto, a seconda della visione del mondo del ricercatore, nell'ambito della metodologia della conoscenza giuridica, esistono diversi tipi di comprensione giuridica che corrispondono alle principali direzioni del pensiero filosofico. Tipi di comprensione giuridica- questi sono concetti filosofici e legali contenenti i principi originali della visione del mondo per spiegare il diritto come fenomeno sociale indipendente. Questi concetti fondamentali della visione del mondo, in virtù della loro universalità e del carattere fondamentale per il ricercatore, sono per loro stessa natura filosofici. Quella parte della filosofia che si occupa della spiegazione del significato, dei modelli, della natura del diritto è chiamata filosofia del diritto. Pertanto, vari concetti della filosofia del diritto costituiscono il contenuto principale dei tipi di comprensione giuridica, rivelando l'essenza del diritto come fenomeno socio-giuridico in modi diversi.
Le principali scuole filosofiche corrispondono a diversi tipi di comprensione giuridica. Consideriamo i principali approcci metodologici alla conoscenza giuridica nel quadro del materialismo e dell'idealismo.
Il marxismo può servire da esempio del tipo materialistico della conoscenza giuridica. Per Tipo di concezione giuridica marxista sono caratterizzati dalle seguenti disposizioni.
1. L'essenza e lo sviluppo del diritto, così come lo stato, sono in definitiva determinati dalle condizioni materiali della società, in primo luogo dal tipo di rapporti di produzione, determinati, a loro volta, dalle forme dominanti di proprietà dei mezzi di produzione. «La mia ricerca mi ha portato al risultato», scriveva K. Marx nella prefazione alla sua opera «Sulla critica dell'economia politica», «che i rapporti giuridici, proprio come le forme dello Stato, non possono essere compresi né da se stessi né da tale chiamato sviluppo generale dello spirito umano, al contrario, sono radicati nei rapporti di vita materiale, la cui totalità Hegel, sull'esempio degli scrittori inglesi e francesi del Settecento, chiama "società civile", e che l'anatomia della società civile va ricercata nell'economia politica.
2. Il diritto, come lo stato, è un fenomeno di classe nella sua natura sociale. Ciò significa che è possibile solo in una società di classi; appare con la divisione della società in classi; esprime, in ultima analisi, gli interessi della classe economicamente e politicamente dominante (ad esempio: in una società capitalista - la borghesia, in una società socialista - la classe operaia e tutti i lavoratori).
3. Il diritto, pur condizionato dai rapporti economici, ha, tuttavia, una relativa autonomia come fenomeno di coscienza pubblica e di cultura nazionale, avendo un effetto di retroazione attivo su tutte le sfere della società, compresa quella economica.
4. Con il cambiamento del tipo di rapporti di produzione, che, di regola, avviene nel corso di una rivoluzione sociale, cambia anche l'essenza di classe del diritto, poiché comincia a riflettere gli interessi, in primo luogo, della classe che riceve potere politico ed economico.
5. Con la scomparsa delle classi nel quadro della formazione comunista, il diritto perderà il suo carattere politico e progressivamente si estinguerà insieme allo Stato. Le relazioni umane saranno regolate da norme sociali non politiche (le regole della comunità comunista), che riflettono gli interessi armoniosi e non antagonisti dei membri della società.
Così, il marxismo vede l'essenza del diritto, in primo luogo, nel fatto che è la volontà statale della classe dirigente eretta a legge, il cui contenuto è determinato (in definitiva) dalle condizioni materiali e produttive della sua esistenza.
Sulla base dell'idealismo filosofico e delle sue correnti, si sono formati diversi tipi di conoscenza giuridica, tra cui le più fondamentali sono il positivismo giuridico e la dottrina del diritto naturale.
Interpretazione giuridica di tipo naturale-giuridico ha profonde fonti nel pensiero politico e giuridico dell'Antica Grecia, dell'Antica Roma, sviluppatasi nel Medioevo, e la più grande fioritura e suono moderno - durante le rivoluzioni borghesi dei secoli XVII-XVIII. L'essenza di questo approccio alla conoscenza giuridica risiede nella valutazione del diritto dal punto di vista della giustizia, dove solo le norme del legislatore che corrispondono alla "natura naturale" - la natura umana, la natura delle cose, la natura dell'universo possono essere considerato vero e proprio diritto “naturale”. Il tipo naturale di intesa giuridica è caratterizzato dalle seguenti disposizioni principali.
1. Distinzione teorica e pratica tra diritto e diritto. Insieme alla legge positiva (accettata dal legislatore), esiste un diritto superiore, reale - "naturale" inerente all'uomo per natura (il diritto alla vita, alla libertà, alla resistenza all'oppressione, alla proprietà, ecc.). Come osserva V. A. Chetvernin, la metodologia del diritto naturale nello spiegare e valutare i fenomeni giuridici procede dal fatto che il "diritto" è un fenomeno sociale di razionalizzazione della vita umana, immanente all'esistenza umana, che in tale veste ha un valore maggiore del diritto, che il diritto è un necessario regolatore delle relazioni interpersonali, che differisce dal diritto “derivato”, “imperfetto”, “insufficiente” e talvolta anche “inaccettabile” in quanto il diritto è sempre “vero”, “ragionevole”, “naturale”, “realmente” , "umano", ecc.".
2. Non ogni legge giuridica, anche se perfetta nella forma, contiene legge. Il contenuto di ogni legge deve essere sottoposto a verifica dal punto di vista della sua rispondenza a norme “naturali” umane, sociali, naturali, ecc.: tutto ciò che contraddice la legge “naturale” nel diritto positivo non può essere considerato legge.
3. Diritto e moralità sono concettualmente la stessa cosa: il termine stesso “giuridico” indica l'osservanza sostanziale delle prescrizioni legali con i requisiti della moralità, laddove la moralità è la determinante che definisce il potere legislativo e l'applicazione della legge.
4. La fonte dei diritti umani si trova nella stessa "natura umana". Una persona acquisisce i suoi diritti e le sue libertà dalla nascita, e questi diritti non possono essere né "concessi" a una persona dallo stato, né alienati a favore di quest'ultimo.
Questa dottrina ha giocato un ruolo importante nella critica del feudalesimo come sistema che non corrispondeva alla "natura dell'uomo", servendo come base teorica per le rivoluzioni borghesi dei secoli XVII-XVIII. Le idee di questa scuola si riflettono nella Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti del 1776, nella Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Attualmente, questo tipo di comprensione giuridica è diventato la base di vari concetti giuridici e filosofici del diritto.
Tipo positivista di pensiero giuridico si basa sul positivismo (positivus - lat.: positivo) - la direzione dell'idealismo filosofico, che sostiene il principio che l'unica fonte di conoscenza vera, valida ("positiva") può essere solo qualcosa di concreto (concreto, cioè scienza naturale, concreto , cioè in leggi, decreti, delibere, ecc. legge, ecc.). Le posizioni di moralità, filosofia, assiologia (teoria dei valori), per la loro elevata astrattezza, non sono verificabili attraverso l'esperienza e quindi sono false, prive di un criterio oggettivo di verifica (verifica), cioè speculative. Solo ciò che può essere verificato dall'esperienza è vero, ciò che esiste positivamente è fissato dai nostri organi di senso. In accordo con questi presupposti filosofici, la conoscenza del diritto positivista procede dalle seguenti disposizioni.
1. In contrasto con la dottrina del diritto naturale, il positivismo identifica il diritto e il diritto emanato dal potere statale. Qualsiasi norma di contenuto è riconosciuta come legge valida, se solo ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato secondo i suoi criteri procedurali formali. I positivisti ritengono assolutamente superfluo che il diritto verifichi il rispetto di alcuni principi astratti della "natura umana", vista l'insensatezza di tale controllo. Qualsiasi criterio di "verità" e "naturalezza" di una norma sarà solo un prodotto delle preferenze del verificatore, non suscettibile di verifica scientifica. L'unica base per la legge può essere solo il fatto stesso della sua esistenza in alcune fonti ufficiali - leggi, decreti, ecc.
2. Se il tipo di interpretazione giuridica di tipo naturale-giuridico identifica significativamente diritto e moralità, allora il positivismo, al contrario, le distingue rigorosamente. Per il diritto è determinante la forma giuridica stessa, e non il contenuto morale della legge, decreto, ecc. Certo, la forma e il contenuto devono essere adeguati, ma in caso di discrepanza, la sanzione dello Stato e l'inclusione in l'ordinamento giuridico esistente sono determinanti per il diritto.
3. La fonte dei diritti umani, secondo questo approccio, è nella legislazione. Una persona ha diritti non in virtù di una parte della sua “natura”, ma come cittadino di un determinato Stato, e quest'ultimo definisce questi diritti nella Costituzione.
4. Oggetto dello studio del diritto non dovrebbero essere alcuni principi extrastatali di bontà e giustizia, ma solo le norme stesse “positive”, scritte nei testi delle leggi e quindi accessibili per l'osservazione e la percezione diretta. Il ricercatore deve analizzare questi testi secondo le regole della logica, della grammatica, della tecnica giuridica, ecc.
Pertanto, il positivismo nega il "diritto naturale" e comprende per legge solo gli atti giuridici - i risultati dell'attività legislativa dello stato, o qualche altro fatto empirico (concreto) della realtà.
Nell'ambito della concezione del diritto di tipo positivista, si sono sviluppati diversi concetti di diritto indipendenti e distinti.
normativismo, il cui autore era l'avvocato tedesco Hans Kelsen, divide la sfera della vita del soggetto in due aree: l'area del reale e l'area del dovuto, a cui fa riferimento anche il diritto . Pertanto, non ha giustificazione al di fuori della sfera delle norme di obbligo e la sua forza dipende dalla coerenza e dall'armonia del sistema delle norme giuridiche - la piramide delle norme, dove ogni norma trae la sua legalità da una norma di forza giuridica superiore. La forza di ogni diritto si basa sulla "regola di base" adottata dal legislatore. Alla base della piramide delle norme ci sono gli atti individuali - decisioni dei tribunali, contratti, istruzioni dell'amministrazione, che sono quindi inclusi nel concetto di diritto. “La norma”, scriveva G. Kelsen, “dando all'atto il significato di atto legale (o illegale), è essa stessa creata per mezzo di un atto giuridico, che, a sua volta, riceve significato giuridico da un'altra norma. Se una certa composizione fattuale dal punto di vista del diritto è l'esecuzione di una condanna a morte, e non un omicidio premeditato, allora questa sua qualità - che non può essere percepita dai sensi - è rivelata solo da uno sforzo di pensiero, ad es. rispetto al codice di procedura penale e penale. Che uno scambio di lettere significhi, dal punto di vista del diritto, la conclusione di un contratto deriva solo ed esclusivamente dal fatto che le circostanze effettive di tale corrispondenza corrispondono alle condizioni previste dal codice civile. Che una certa assemblea di uomini sia un parlamento, e che, in termini giuridici, il risultato della loro attività sia una legge - in altre parole, che questi eventi abbiano un tale significato - significa che la totalità delle circostanze che li riguardano corrisponde a la norma della costituzione. In altre parole, il contenuto degli eventi reali è coerente con il contenuto di una certa norma, che viene riconosciuta come valida. La conoscenza giuridica ha lo scopo di studiare quelle norme che hanno il carattere di norme legali e conferiscono a determinate azioni il carattere di atti legali o illegali.
Un'altra corrente di positivismo è teoria psicologica L.I. Petrazhytsky, che, come altre dottrine positiviste, esclude dal concetto di diritto i suoi aspetti essenziali e assiologici (di valore), definendo questo concetto per tratti empirici (concreti). Nella teoria di L.I. Petrazhitsky, la legge non riconosce la norma formale del legislatore, ma la realtà mentale data: le emozioni legali delle persone. Queste emozioni sono della cosiddetta natura imperativo-attributiva, cioè rappresentano l'esperienza di un senso del dovere di fare qualcosa (imperativo) e un senso di diritto a qualcosa (norma attributiva). Nell'emozione, questi due sentimenti sono indissolubilmente legati. Tutte le esperienze legali sono divise in due tipi: l'esperienza del diritto positivo (stabilito dallo stato) e l'esperienza del diritto intuitivo (autonomo, personale), che non sono legate al positivo. Il diritto intuitivo, contrariamente a quello positivo, funge da vero regolatore dei comportamenti e pertanto va considerato come un diritto valido. Le sue caratteristiche universali e specifiche L.I. Petrazhitsky considerava le esperienze umane attive-passive bilaterali: le emozioni, che avrebbero dovuto essere particelle elementari del fenomeno del diritto. Pertanto, questa dottrina considera l'esperienza del debito di gioco, l'esperienza dei bambini dei loro doveri nel gioco, la reciproca esperienza di diritti e doveri nelle comunità criminali, che, quindi, formano "diritto del gioco", "diritto dei bambini", "diritto patologico legge » (malato mentale), ecc. Come si vede, i confini del concetto di diritto delineato dal normativismo (atti formali del potere statale) sono notevolmente ampliati e questo concetto include le funzioni mentali di una persona. L.I. Petrazhitsky credeva che il riconoscimento per legge solo di ciò che è stato stabilito dal potere statale restringe ingiustificatamente il cerchio dei fenomeni che rappresentano il diritto. “... Nel profondo del fenomeno dello spirito umano sta, per così dire, il terzo tipo di diritto, la terza idea di diritto, la madre e la fonte comune delle due categorie stabilite di diritto e la ragione di il fatto che entrambi questi diversi fenomeni sono chiamati legge”. Per questo motivo, la dottrina psicologica di L.I. Petrazhitsky, secondo i principi metodologici iniziali, confina con il positivismo: per il diritto, il contenuto delle esperienze giuridiche è indifferente: la descrizione di queste ultime si sostituisce allo studio degli aspetti essenziali e assiologici del diritto.
Il terzo tipo di metodologia del positivismo giuridico è teoria sociologica del diritto. Infatti è caratteristica, oltre che per la dottrina del diritto naturale, la distinzione tra diritto e diritto. Tuttavia, l'essenza di questa distinzione è diversa. Il diritto di fatto (nelle leggi) non è posto accanto ai principi essenziali dello spirito umano (diritto naturale), ma al cosiddetto “diritto reale”, o “diritto esistente”, o “diritto vivente”, incarnato nei rapporti giuridici, creato dai vari soggetti delle relazioni sociali nel processo della vita. Il diritto qui non è il massimo dovuto - ideali, valori, ragione superiore, volontà divina, come nel diritto naturale, ma fatti empirici del comportamento dei soggetti di rapporti giuridici - individui e persone giuridiche. Le norme del diritto “vivente” devono in qualche modo distinguersi dai comportamenti concreti. Tale funzione - la formulazione del diritto - è svolta, secondo tale approccio, dai giudici nel processo di attività giurisdizionale. Cercano le norme del "diritto reale" e sulla loro base prendono una decisione senza essere rigidamente vincolati dalle normative statali. In questo caso, il giudice agisce non solo come garante, ma anche come soggetto di legiferazione, rendendo la legge concreta sulla base di specifica opportunità.
Così, nei tipi di conoscenza giuridica, si esprimono diversi orientamenti metodologici sui problemi iniziali del rapporto tra essere e coscienza, dovuto ed esistente, materia e spirito. Questi fenomeni sono strettamente correlati: non esistono quindi partizioni impenetrabili tra i tipi di conoscenza giuridica, nonostante le differenze significative nelle loro posizioni epistemologiche. Così, ad esempio, nella questione della natura dei diritti umani, il marxismo converge largamente con la scuola di diritto naturale, riconoscendo l'origine pre-legislativa dei diritti umani, ma, a differenza di esso, interpreta questi diritti non idealisticamente, ma concretamente storicamente e materialisticamente - come fenomeno determinato dalla totalità delle relazioni sociali in cui una persona è inclusa. Entrambe le dottrine negano che i diritti umani siano concessi (concessi) dallo stato.
Ci sono molti punti di contatto tra marxismo e positivismo. Tutto ciò testimonia l'integrità e la continuità del processo di conoscenza giuridica.
L'esistenza di vari concetti di comprensione del diritto spesso non risolve il problema di un'adeguata conoscenza dei fenomeni giuridici, ma lo complica solo, poiché le opzioni per una comprensione "estesa" del diritto entrano in conflitto con le costruzioni tradizionali della teoria giuridica.
D'altra parte, una delle ragioni della critica permanente della comprensione giuridica normativa è l'incoerenza del tradizionale apparato categorico della giurisprudenza con l'emergere di nuove categorie e concetti giuridici.
Nella sua famosa opera "Pure Theory of Law", G. Kelsen ha sottolineato che per definire il diritto si dovrebbe iniziare con l'uso delle parole, cioè stabilire cosa significhi la parola "diritto" in tedesco e suoi equivalenti in altre lingue (diritto, diritto, diritto, ecc.). Inoltre, ha proposto di scoprire se i fenomeni sociali indicati con questa parola hanno caratteristiche simili che li distinguono da altri fenomeni simili e se queste caratteristiche sono sufficientemente significative da servire come elementi del concetto di scienza sociale. Come risultato di tale studio, conclude l'autore, potrebbe risultare che la parola "diritto" e i suoi equivalenti in lingua straniera si riferiscono a materie così diverse che nessun concetto generale può coprirle tutte.
Basato sul significato etimologico della parola "legale" in russo, dovrebbe essere associato a tutto ciò che è giusto e giusto nella nostra vita. Tradizionalmente, nella letteratura giuridica nazionale, si credeva che la legge in questo senso fosse inseparabile dalla giustizia. "Giusto", "legale", "giusto" - questa è una serie di parole che hanno un significato vicino.
Ci sono diversi significati quando si usa il termine "diritto". In primo luogo, "giusto" come parola russa è usato nel senso che qualcosa appartiene a qualcuno: potere, volontà, possibilità di comportamento. Qui la parola "diritto" è usata in opposizione a parole come "dovere", "dovere". In secondo luogo, è noto l'uso del termine "diritto" nel senso di una norma di comportamento stabilita o accettata nella vita pubblica. Il diritto, inteso in questo senso, ha attualmente molte varietà: diritto comune, diritto naturale, diritto canonico (ecclesiastico), diritto islamico, diritto internazionale, diritto societario, diritto ombra.
Nella scienza giuridica, queste differenze semantiche sono tracciate in misura maggiore in relazione all'uso di concetti come "diritto oggettivo" e "diritto soggettivo", e in misura minore - in relazione alla considerazione del diritto naturale e positivo.
I concetti di diritto soggettivo e oggettivo non devono essere confusi con il problema del diritto oggettivo e soggettivo. Come AB Vengerov, il risultato della determinazione del diverso contenuto del diritto a livello teorico è la sua comprensione come oggettiva e soggettiva nel diritto. Obiettivo quando questo contenuto è determinato da esigenze socioeconomiche, politiche e di altro tipo. E soggettivo quando questo contenuto non è giustificato, ma, al contrario, arbitrariamente, è confutato da ogni pratica sociale.
Quanto alle categorie “diritto oggettivo” e “diritto soggettivo”, si tratta di concetti fraseologici condizionali (espressioni, locuzioni) accettati nella scienza giuridica mondiale. È impossibile non notare che se il concetto di “diritto” è stato utilizzato senza alcuna riserva, significava sempre diritto oggettivo. Senza l'uso della parola "soggettivo" il diritto è generalmente considerato oggettivo (un insieme di norme), anche se la parola "oggettivo" era assente.
Tuttavia, va segnalato che in giurisprudenza esiste da tempo una protesta contro la parola “soggettivo”. Alcuni autori hanno addirittura suggerito di sostituirlo con i termini “personale”, “individuale”, “concreto”, ecc. La parola “soggettivo” suggeriva un diritto insolito e misterioso, e non quello di tutte le persone nella vita quotidiana. Tuttavia, questa protesta non era diretta contro l'essenza stessa della separazione in atto.
La maggior parte degli scienziati domestici è convinta che la scienza giuridica abbia usato i termini "oggettivo" e "soggettivo" non a caso e non solo per distinguere tra due fenomeni strettamente correlati, ma per riflettere più pienamente la loro natura socio-giuridica, il ruolo funzionale e sociale scopo.
È curioso che anche L. Dyugy, che ha costantemente negato l'importanza dei diritti soggettivi dell'individuo e li ha sostituiti con la teoria delle "funzioni sociali", ha tuttavia scritto che le espressioni "diritto oggettivo" e "diritto soggettivo" sono convenienti, chiaro e preciso, e quindi il loro uso "perfettamente legale". In primo luogo, la ben nota opportunità del termine “soggettivo” è legata al fatto che tutti i portatori (titolari) dei diritti e degli obblighi previsti dalla legge nella scienza giuridica sono chiamati “soggetti di diritto”. In secondo luogo, le parole diritto “personale”, “individuale” esprimerebbero, in sostanza, solo il momento di titolarità del diritto del soggetto, ma non si rifletterebbe l'aspetto filosofico del concetto. Il fatto è che “diritto soggettivo” non solo indica che il diritto appartiene al soggetto, ma riflette anche il fatto che il diritto che appartiene al soggetto dipende, entro certi limiti, dalla sua personale volontà e discrezione, soprattutto nel senso dell'uso . Lo stato di diritto è oggettivo: non dipende dalla volontà e dal desiderio di un individuo, non può essere smaltito come qualcosa di personale, individuale. Essendo una regola generale, impersonale, astratta, la norma non è e non può appartenere a nessuno.
Quindi, il diritto soggettivo è soggettivo nel senso che, in primo luogo, è associato al soggetto e, in secondo luogo, dipende dalla sua volontà e coscienza. Il diritto oggettivo è oggettivo nel senso che, in primo luogo, non è confinato a un soggetto particolare e, in secondo luogo, non è associato alla sua volontà e alla sua discrezionalità personale.
In letteratura è stato più volte proposto di combinare due concetti di diritto in uno, più precisamente, di includere il sistema dei diritti soggettivi dei cittadini, insieme ai rapporti giuridici e alle opinioni giuridiche, nel contenuto del diritto oggettivo o semplicemente del diritto (S.F. Kechekyan, Ya.F. Mikolenko, A. A. Piontkovsky, L.S. Yavich e altri). Questa è la cosiddetta interpretazione estensiva del diritto. Queste aspirazioni si intensificarono con il riconoscimento della teoria del diritto naturale.
Tuttavia, anche una tale posizione (notiamo, non condivisa da noi) non impedisce di vedere nella legge, intesa in modo così ampio, due tagli, due rami: le norme imperative emanate dallo Stato e le possibilità giuridiche dei singoli. Un concetto non assorbiva l'altro. Il diritto oggettivo e quello soggettivo rimangono finora categorie indipendenti, strettamente correlate, ma che riflettono aspetti diversi della realtà giuridica. Possiamo essere d'accordo sul fatto che "i tentativi di combinare diritto oggettivo e soggettivo con un unico concetto di diritto non possono essere giustificati, poiché questi fenomeni giacciono su piani diversi della realtà giuridica".
Va affermato con certezza che il riconoscimento della teoria del diritto naturale non scuote l'intera dottrina del diritto oggettivo e soggettivo, perché in tutte le società civili in cui prevalgono le idee del diritto naturale, la divisione del diritto in oggettivo e soggettivo , tuttavia, è conservato. Del resto, anche i diritti "innati" senza che siano assicurati e garantiti dalla legislazione positiva dei rispettivi Stati possono rivelarsi vuote dichiarazioni.
Oggi pochi dubitano dell'esistenza parallela del diritto naturale e del diritto positivo: questi concetti sono stati diversi nell'esperienza politica e giuridica mondiale per migliaia di anni. Ecco perché è impossibile introdurre il diritto naturale nella definizione generale di diritto, perché ciò minerà l'idea principale della dottrina naturale. Dopotutto, l'essenza di questa dottrina sta proprio nel non confondere due diversi fenomeni: le leggi dello stato ei diritti "innati" dell'individuo. J. Del Vecchio ha osservato che sarebbe errato porre l'idea di diritto naturale, cioè ideale giuridico, in luogo del concetto di diritto, oltre a cercare di capire questo ideale definendo il concetto di diritto, poiché appartengono a diverse sfere dell'essere, il che consente loro di esistere indipendentemente l'uno dall'altro.
Sia l'identificazione che l'opposizione del diritto naturale e positivo sono inaccettabili e dannose. Il riconoscimento e il consolidamento legislativo dei diritti umani naturali conferisce alla divisione del diritto in oggettivo e soggettivo nuovo suono e significato, tanto più che si tratta in realtà dello stesso problema, solo nei suoi diversi aspetti, organicamente complementari.
Nelle condizioni moderne, i diritti e le libertà innati sono stati a lungo sanciti dalla maggior parte degli stati nei loro regolamenti e confermati in documenti internazionali interstatali. Così, i diritti e le libertà naturali sono sanzionati dallo stato, trasformati in una componente organica dei regolatori legali. Come rilevato nella letteratura giuridica, oggi in una società civile non vi sono motivi per opporsi al diritto naturale e positivo, poiché quest'ultimo consolida e tutela i diritti umani naturali, costituendo un unico sistema di regolamentazione giuridica.
Nella moderna letteratura straniera, il problema del rapporto tra diritto oggettivo e diritto soggettivo è naturalmente integrato da un'indicazione di diritto positivo: «Il diritto oggettivo è un sistema di regole che regolano la vita nella società, la cui osservanza, a sua volta, è garantita dalla autorità. Il diritto oggettivo viene spesso identificato con il diritto positivo, cioè con l'insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato momento e in una data società. Tuttavia, tale visione del soggetto risulta ristretta, poiché lo stato di diritto in una determinata società in un determinato momento non può essere considerato separatamente dai fenomeni di più ampia scala, non può essere considerato isolatamente dalle sue fonti o dal contesto generale , dalle tendenze nella sfera dell'ideologia. Tuttavia, a seconda della situazione (a differenza, ad esempio, dell'inglese), in francese (come in russo - dall'autore) lo stesso termine denota sia il diritto oggettivo stesso sia le prerogative riconosciute a individui o gruppi di individui. , cioè, quei diritti molto soggettivi che la legge oggettiva assegna alle persone giuridiche e che conferiscono a queste persone giuridiche il diritto di possedere proprietà o il diritto di potere su altri. Queste disposizioni molto eque possono essere prese come base per ulteriori ragionamenti.
È vero, nella letteratura interna degli ultimi anni sono emerse altre opinioni sulla relazione tra diritto positivo e diritto oggettivo. Quindi, Ya.V. Gaivoronskaya, distinguendo tra norme legali e norme legali, ritiene che il diritto nel suo insieme possa essere definito come un sistema di norme legali progettato per riflettere i momenti essenziali e sostanziali di un fenomeno legale e il diritto positivo apparirà come un sistema di norme legali - il più formalizzato e legato allo Stato in termini di modalità di formazione e di erogazione. Pertanto, il diritto positivo fa parte del diritto oggettivo.
Inoltre, questo articolo contiene anche l'opinione di V.K. Babaev, che considera le norme giuridiche come componenti del diritto positivo e le norme giuridiche come diritto naturale. Inoltre, una proposta di V.A. Muravsky per distinguere tra diritto (in quanto contenente norme giuridiche) e diritto reale (in quanto contenente norme giuridiche sviluppate nel processo di attuazione dell'attività sociale). Allo stesso tempo, se Ya.V. Gaivoronskaya crede che la norma legale sia incarnata nella coscienza pubblica o (in misura minore) nel processo comportamentale, quindi V.A. Muravsky sostiene che il diritto reale esiste solo come un'attività, un movimento sociale, compreso in termini e modelli di giurisprudenza.
Il difetto metodologico di questo tipo di concetti di "diritto" e delle definizioni corrispondenti, a nostro avviso, è che attraverso di essi cercano di coprire come propri fenomeni giuridici in senso giuridico, le cui idee sono molto specifiche e non causano gravi controversie (ad esempio, diritto soggettivo giuridico, diritto positivo), e quei fenomeni sociali che non possono essere considerati come diritto in senso giuridico (come il diritto naturale, come coscienza giuridica - diritto intuitivo, come "vivente", diritto sociale - il ordine delle relazioni, ecc.). Naturalmente, nella vita sociale reale, tutti questi fenomeni formano un complesso sistema di interazione, che esercita una certa influenza l'uno sull'altro, che la scienza giuridica sarà in grado di comprendere solo in combinazione con altre scienze sociali. Ma il fatto che il proprio (specifico) oggetto di conoscenza della teoria del diritto debba essere il “diritto degli avvocati”, cioè il diritto in senso giuridico non può essere messo in discussione (a proposito, come l'esistenza molto reale di un fenomeno sociale così peculiare). Nessun'altra scienza può rivendicarne lo studio esclusivo, mentre il diritto naturale, il diritto intuitivo o sociale (informale) possono e devono essere studiati in
In generale, ci sono due significati del termine "norma" :
1. norma come stato naturale di qualche oggetto (processo, relazione, sistema, ecc.) secondo la sua natura - stato naturale
2. norma come principio guida, regola di condotta connessa con la coscienza delle persone, che sorge nel processo di sviluppo culturale e di organizzazione sociale della società - norma sociale
Norme- si tratta di determinati standard, campioni, standard, modelli di comportamento dei partecipanti alla comunicazione sociale. Sono stabiliti dalla società stessa. Senza di loro, la società umana è impossibile. Normaè sempre uno stereotipo indefinito numero di casi. societàè una società.
Segni di norme sociali:
1. regolare i rapporti tra le persone
2. regolamentare situazioni ricorrenti (comuni, di massa, tipiche).
3. sono regole generali (cioè stabiliscono regole di comportamento nella società, cioè determinano quale può o dovrebbe essere il comportamento dei soggetti dal punto di vista degli interessi della società)
4. pensato per molte persone, e non specifico e non definito personalmente
5. sono creati da esseri intelligenti, creati dalla volontà delle persone, dalla loro coscienza
6. hanno una certa forma (può essere una forma sotto forma di un'azione - un rituale, una cerimonia, un'usanza)
7. ha una sanzione (può essere sotto forma di censura pubblica)
8. sorgono nel processo di sviluppo storico (come suo fattore e risultato) e nel funzionamento della società. inoltre, stabilizzano la società, il che significa che sono sia un prodotto che un regolatore delle relazioni sociali
9. corrispondono al tipo di cultura e alla natura dell'organizzazione sociale della società (cultura europea e asiatica)
norme sociali- relative alla volontà e alla coscienza delle persone, le regole generali per regolare le forme della loro interazione sociale che sorgono nel processo di sviluppo storico e nel funzionamento della società, corrispondenti al tipo di cultura e alla natura della sua organizzazione.
Si tratta di regole oggettivamente necessarie dell'esistenza umana congiunta, che indicano i confini del proprio e del possibile.
Si sviluppano e diventano più complessi con lo sviluppo della società. Riflettono le leggi dello sviluppo sociale, ma essi stessi non lo sono.
Tipi di norme sociali:
1. rituali- una regola di condotta in cui l'accento è posto sul lato esterno della sua esecuzione, e questa forma è rigorosamente canonizzata. Questa è una cerimonia, una dimostrazione. Caratterizzato da massa.
2. Riti- (separate dalle azioni rituali) si tratta di regole di condotta, consistenti in azioni simboliche, ma, a differenza del rituale, penetrano più a fondo nella psiche delle persone e perseguono obiettivi educativi. Viene eseguito da una persona speciale, "esperta". Colpisce le esperienze psicologiche delle persone. (rito del matrimonio, guarigione, sepoltura). Ogni azione è piena di un certo significato, è, per così dire, un simbolo.
3. miti- (sorgono con lo sviluppo del linguaggio) queste sono leggende, leggende, storie di dei, spiriti, eroi divinizzati, antenati, che cercano di spiegare il mondo che li circonda. Ha un carico ideologico, contiene esempi da seguire. Una specie di spiegazione. Ha un inizio emotivo-associativo.
4. dogana- (norme sociali piuttosto complesse, più sottili) regole di condotta che si sono sviluppate storicamente, nel corso di diverse generazioni, divenute universali a seguito di ripetute ripetizioni. Caratterizzato da stabilità. Rifletti il modello della vita. Sono universali. "abitudini domestiche". Includono anche le abitudini commerciali o le abitudini di rotazione aziendale. Le abitudini si basano su modelli di comportamento specifico e attività pratiche. Le loro istruzioni sono molto dettagliate.
5. Standard morali- regole di condotta che determinano cosa è bene e cosa è male. L'incentivo per la loro attuazione è la "voce di coscienza".
6. Etichetta- norme di comportamento quotidiano, quotidiano, "educato", comportamento corretto, regole di decenza. L'etica è la scienza della moralità (morale).
7. Norme politiche- regole di condotta che regolano i rapporti che si sviluppano nel campo della gestione, i rapporti tra i vari gruppi sociali legati all'esercizio del potere statale, il modo in cui è organizzato e nominato nella società.
8. Regolamenti aziendali- regole di comportamento che disciplinano i rapporti tra membri di enti pubblici, associazioni, movimenti di massa. Sono espressi in carte, regolamenti, programmi, decisioni. Sono obbligatorie solo per i membri di tali associazioni.
9. Norme economiche- le regole di comportamento umano che regolano i rapporti economici, assicurando l'inviolabilità delle varie forme di proprietà, ... Norme di religione - le regole di condotta che regolano i rapporti sociali attraverso le esigenze dei principi divini, i rapporti nel campo della religione.
10. norme familiari- regole di comportamento che si sviluppano tra i familiari.
11. Legge- regole di condotta stabilite dallo Stato e che rappresentano regole di condotta generalmente vincolanti formalmente definite, stabilite ufficialmente e dotate della possibilità di coercizione statale.
12. Norme tecniche e legali- queste sono le regole per il trattamento più razionale delle persone con strumenti e oggetti della natura. Riguardano le norme sociali nel senso che, se non vengono rispettate, possono essere imposte sanzioni. Diventano norme tecniche e legali. (le norme tecniche non si applicano a quelle sociali, perché non regolano i rapporti tra le persone)
Tre funzioni delle norme sociali:
1. regolamentare. Queste norme stabiliscono le regole di comportamento nella società, regolano l'interazione sociale. Garantire la stabilità del funzionamento della società.
2. stimato. Nella pratica pubblica fungono da criterio di atteggiamento verso determinati atti, base per valutare i comportamenti socialmente significativi di determinati soggetti (morale - immorale, lecito - illecito).
3. traslazionale. Fissando i principi culturali, spirituali, l'esperienza sociale di una generazione, le norme sociali sono una sorta di eredità per le generazioni future, vengono trasmesse nel futuro.
Le norme sociali differiscono nel processo di formazione, nella forma di fissazione (esistenza), nella natura dell'azione normativa, nei modi e nei metodi di assicurazione.