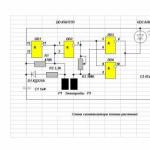Argomento Problemi del romanzo di Stendhal "Vanina Vanini" Gli eventi storici alla base delle opere di Stendhal, il periodo della Restaurazione in Francia e in Italia, le campagne d'Italia di Napoleone, il movimento dei Carbonari. L'Italia nella mente artistica di Stendhal
Vanina Vanini è una ricca principessa italiana. Questa ragazza ha uno sguardo focoso e un'anima appassionata. Essendo un'aristocratica di nascita, tratta con disprezzo i giovani della sua cerchia a causa della loro incapacità di fare grandi cose. Ma Vanina Vanini si innamora appassionatamente del giovane carbonari Pietro Missirilli, combattente contro la tirannia. I personaggi dei personaggi sono volutamente "romantici". Sia Missirilli che Vanina Vanini sono inseparabili dal loro tempo e l'originalità della loro situazione personale è in definitiva generata dalla situazione socio-politica in Italia. C'è uno scontro di due passioni, Pietro e la sua amata, pur innamorati, si trovano ai lati opposti della "barricata sociale". Missirilli, che si dedicò alla lotta rivoluzionaria, e l'espressiva ed energica Vanina Vanini sono tipici eroi di Stendhal. Nelle loro passioni sono romanticamente spericolati, ma la loro incoscienza - nonostante la somiglianza delle manifestazioni esterne - è di natura diversa. Missirilli si consegna nelle mani dei carnefici per senso del dovere, basato su un amore sconfinato per la patria, e Vanina Vanini, quasi senza esitazione, tradisce i compagni di Pietro per impossessarsi completamente del cuore del suo amato, per tenerlo vicino suo. Ma in cambio riceve l'odio ardente del suo amante, che non può perdonarla per quello che ha fatto. Vanina Vanini è condannata a fraintendere il suo amante. Stendhal ha mostrato poeticamente e tragicamente fino a che punto fosse andato l'egoismo, divenuto una caratteristica di quel tempo: l'immagine di Vanin Vanini lo dimostra. Non sorprende che l'opera prenda il nome dall'eroina, la cui "opposizione" alla società era in definitiva una posa quando messa alla prova dai tragici eventi dell'epoca. Dopo aver rotto con Pietro Vanina, Vanini si consolò subito sposando qualcun altro. Missirilli e Vanina Vanini sono persone provenienti da mondi alieni e ostili.
3.2 Classi pratiche (seminari), loro contenuto e volume in oreArgomento 1. Problemi del racconto di Stendhal "Vanina Vanini"
Le vicende storiche sottese alle opere di Stendhal, il periodo della Restaurazione in Francia e in Italia, le campagne d'Italia di Napoleone, il movimento dei Carbonari.
Il realismo di Stendhal nella rappresentazione dei grandi eventi storici.
Analisi del racconto di Stendhal "Vanina Vanini":
b) il problema di un giovane nel racconto di Stendhal;
c) l'immagine di Vanina, l'eroe e l'ambiente sociale;
d) l'eroe positivo di Stendhal, l'immagine di Pietro Missirilli.
Originalità artistica del romanzo.
LETTERATURA
Fritto gen. Stendhal. Saggio sulla vita e la creatività. - M, 1968.
Reizov BG Romanzo francese del XIX secolo. - M., 1969.
Prevost J. Stendhal. - M.-L., 1967.
Reizov BG Stendhal. Creatività artistica. - L., 1978.
Argomento 2. La storia di O. BALZAC "GOBSEK" / Il problema del determinismo sociale e temporale di natura realistica /
^
1. Le principali caratteristiche del realismo francescano / sulla materia della scrittura
F. Engels a M. Harkness/.
2. I principali requisiti di Balzac all'arte, esposti nella "Prefazione" alla "Commedia umana".
3. "Commedia umana" di O. Balzac e il luogo in essa del racconto "Gobsek".
4. Caratteristiche della composizione della storia, dandole un significato generalizzante.
5. Modi di creare un personaggio in Balzac e il contenuto ideologico dell'immagine di Gobsek:
a) un ritratto;
b) ambiente, principi di descrizione;
c) l'evoluzione dell'immagine;
d) la filosofia di Gobsek, l'autorivelazione del personaggio;
e) romantico e realistico nell'immagine;
6. Personaggi del secondo piano in Balzac, i principi della loro creazione e connessione con il personaggio principale.
7. Correlazione tra i principi estetici di Balzac e il metodo di rappresentare la realtà in Gobsek.
LETTERATURA
Balzac O. Sobr. operazione. in 15 volumi M. 1951-55. T.1
Engels F. Lettera a M. Garkness. // K. Marx, F. Engels Sobr. operazione. T.37. pp.35-37.
Vertsman I.E. Problemi di conoscenza artistica. M., 1967 /Cap. "Estetica di Balzac" /.
Oblomievsky D.D. Balzac: le tappe del percorso creativo. M., 1961.
Reizov BG Balzac. Sab. Arte. Università statale di Leningrado, 1960.
Puzikov Honoré Balzac. M., 1955.
Muravyova NI Onore Balzac. M., 1958.
Argomento 3. Il racconto di Prosper Merimee "Carmen" /problema di genere/.
I racconti di Prosper Merimee degli anni '30 e '40 dell'Ottocento alla luce del genere.
Analisi del racconto "Carmen":
b) conflitto nel romanzo;
c) due centri nella struttura dell'opera e delle loro funzioni;
d) scontro di due personaggi nazionali /Carmen e José/;
e) la funzione di una trama narrativa /narrazione etnografica/;
f) inizio romantico e realistico nel racconto.
Prosper Merimee è il fondatore del racconto realistico nella letteratura francese del XIX secolo.
LETTERATURA
Lukov VA Prospera Merimée. M., 1984.
Smirnov A.A. Prosper Merimee e i suoi racconti // Merimee P. Romanzi. M-
L., 1947. pp.5-38.
Frestier J. Prosper Merimee. M., 1987.
Storia della letteratura francese. M., 1956. T.2. pp.407-440.
Storia della letteratura straniera dell'Ottocento / ed. ID Solovyova. M., 1991. S.460-470.
Argomento 4. L'originalità del lavoro di Charles Dickens
/basato sul romanzo "Dombey and Son"/
Caratteristiche dello sviluppo della letteratura inglese nella seconda metà del XIX secolo. Il posto della creatività di Dickens nel processo letterario del paese. Valutazione del lavoro dello scrittore e dei realisti inglesi di Belinsky, Chernyshevsky, Turgenev, Tolstoj, Gorky.
I problemi dei romanzi di Dickens alla luce dell'ideale morale ed estetico dello scrittore.
"Dombey and Son" di Dickens - il significato del titolo e la sua realizzazione nel sistema di immagini e composizione dell'opera.
Personaggi:
Il ruolo del mondo oggettivo nel descrivere la scena dell'azione e nel creare il personaggio del personaggio.
Peculiarità della psicologia.
Leitmotiv e come crearli.
Il ruolo dell'iperbole e la sua connessione con una fiaba, un elemento fiabesco nello sviluppo della trama e nello sviluppo del conflitto.
Il genere del romanzo.
Il ruolo del lieto fine nella poetica dei romanzi di Dickens.
LETTERATURA
Anikin GV, Mikhalskaya NP Storia della letteratura inglese. M., 1998.
Katargsky LM Dickens. Saggio bibliografico critico. M., 1969.
Ivashov. Il lavoro di Dickens. M., 1954.
Silman TN Dickens. M., 1970.
Michalskaya.NP Charles Dickens - M., 1959.
Argomento 5. La tradizione satirica nella letteratura inglese della metà del XIX secolo e l'opera di W. Thackeray "Vanity Fair".
1. W. Thackeray. visioni politiche.
2. Il concetto di arte e storia (prefazioni ai romanzi "Newcomes" e "History of Pendeniss" come riflessione).
a) problemi: problemi socio-politici e morali nel romanzo, il problema dello snobismo,
b) l'originalità del genere e il problema di "un romanzo senza eroe",
c) composizione,
d) sistema di immagini; capacità socio-tipica delle immagini principali (Rebecca Sharp ed Emily Sedley) e la loro identità psicologica individuale,
4. L'innovazione di W. Thackeray nel rappresentare la realtà inglese del XIX secolo. Ironia e satira.
LETTERATURA
Vakhrushev VS Il lavoro di Thackeray. M., 1984.
Elistratova A.A. Thackeray // Storia della letteratura inglese. M., 55. T.2.
Ivasheva V.V. Thackeray è un satirico. M., 58
Argomento 6. L'opera satirica di G. Heine negli anni '40 dell'Ottocento (il poema "Germania. Racconto d'inverno")
Modelli estetici dello sviluppo della Germania a metà del XIX secolo: il romanticismo come componente indispensabile del realismo tedesco.
G. Heine. Periodizzazione della creatività.
Luogo della poesia "Germania. Winter Tale” nell'opera di G. Heine negli anni Quaranta dell'Ottocento.
Originalità di genere del poema “Germania. Fiaba d'inverno.
motivi politici nel poema.
Dualità nella percezione della rivoluzione e della religione.
Motivi che affermano la vita nella poesia.
La particolarità della satira e dell'ironia.
LETTERATURA
Stadnikov GV Heinrich Heine. M., 1984.
Deutsch A.I. Il mondo poetico di Heinrich Heine. M., 1963.
Gijdeu SP Heinrich Heine. M., 1964.
Schiller FP Heinrich Heine. M., 1962.
Argomento 7. Problemi e sistema delle immagini nel romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert.
Estetica G. Flaubert. Il significato dell'immagine della "torre d'avorio". Contraddizione tra estetica e pratica artistica dello scrittore.
La polemica di Flaubert con i romantici della seconda metà dell'Ottocento e la letteratura tendenziosa. L'immagine satirica della letteratura pseudo-romantica nel romanzo e il suo ruolo nel dramma del destino del personaggio principale.
Il problema dell'ideale nell'estetica e nella creatività di G. Flaubert e la sua soluzione nel romanzo Madame Bovary.
Il destino di Emma Bovary. La dualità dell'immagine.
Critica del filisteismo e povertà spirituale dell'ambiente filisteo nel romanzo.
L'immagine del farmacista Ome, il suo significato sociale.
LETTERATURA
Reizov BG opera di Flaubert. M., 1955.
Ivashchenko AF Gustave Flaubert. M., 1955.
Reizov BG Romanzo francese del XIX secolo. M., 1969.
Argomento 8
Il luogo della raccolta di poesie "Fiori del male" nell'opera di Baudelaire.
Le principali disposizioni del programma estetico di Baudelaire.
Struttura e cicli della collezione.
Destinatari delle poesie di Baudelaire.
Teoria della corrispondenza. Storia dell'idea delle corrispondenze. Collegamento con la filosofia mistica e l'estetica del romanticismo tedesco.
Il tema della natura e della città in "Fiori del male".
Il punto di vista di Baudelaire sulla religione e la sua riflessione nella collezione.
LETTERATURA
Baudelaire Sh. Fiori del male. M, 1970.
Baudelaire Sh. Fiori del male. Poesie in prosa. Diari. M., 1993.
Baudelaire Sh. Circa l'art. M, 1986.
Balashov N.Y. La leggenda e la verità su Baudelaire // Baudelaire S. Flowers of Evil. Mosca, 1970, pp. 233-288.
Bibikov V. Tre ritratti. Stendhal. Flaubert. Baudelaire. SPb., 1890.
Valerie P. Posizione di Baudelaire// Valerie P. Sull'art. M., 1993. S. 338-353.
Levik V. "Abbiamo una bellezza che gli antichi non conoscono" // Baudelaire Sh. A proposito dell'arte. M., 1986. SS 5-16.
Nolman M.L. Carlo Baudelaire. Destino. Estetica. Stile. M, 1979.
Nolman M.L. Coordinate Baudelaire. (Poesia "L "amor du mesonge") // Problemi stilistici della letteratura francese. L., 1974. S. 165-174.
Oblomievsky D.D. Simbolismo francese. M., 1973.
Etkind E.G. Sullo spazio esterno e interno nella poesia di Baudelaire // Problemi stilistici della letteratura francese. L, 1974. S. 189-208.
Argomento 9. Romanzo filosofico-parabola di G. Melville "Moby Dick, o la balena bianca"
G. Melville come rappresentante della corrente filosofica nella letteratura americana. Opinioni estetiche dello scrittore.
Originalità di genere del romanzo "Moby Dick, o la balena bianca" come romanzo-parabola filosofica.
Problematiche e sounding ideologico del romanzo.
Sistema di immagini.
Combinazione di inizi romantici e realistici.
L'influenza del lavoro di Melville sugli scrittori americani del ventesimo secolo: E. Hemingway, W. Faulkner e altri.
LETTERATURA
Melville G. Moby Dick (qualsiasi edizione).
Kovalev Yu.P. Herman Melville e il Romanticismo americano. L., 1972.
Nikolyukin AN Romanticismo americano e modernità. M., 1968.
Tradizioni romantiche della letteratura americana e della modernità del XIX secolo. M., 1982.
L'Italia, che Stendhal aveva amato fin dalla giovinezza, era percepita da lui come un paese di forti passioni e di bella arte. I personaggi degli italiani sono sempre stati di particolare interesse per Stendhal.
Il soggiorno in Italia ha segnato profondamente il lavoro di Stendhal. Ha studiato con entusiasmo l'arte italiana, la pittura, la musica. L'amore per l'Italia cresceva in lui sempre di più. Questo paese lo ha ispirato a una serie di opere. Si tratta, in primis, dell'opera sulla storia dell'arte "La storia della pittura in Italia", "Roma, Firenze, Napoli", "Le passeggiate a Roma", i racconti "Cronache italiane"; infine, l'Italia gli ha dato la trama di uno dei suoi più grandi romanzi: Il Monastero di Parma.
Le "Cronache Italiane" riproducono diverse forme di passioni. Vengono pubblicati quattro racconti: "Vittoria Accoramboni", "Duchessa di Palliano", "Cenci", "Badessa di Castro". Sono tutte elaborazioni artistiche di antichi manoscritti ritrovati dallo scrittore negli archivi, che raccontano i tragici eventi sanguinosi del Rinascimento. Insieme a "Vanina Vanini" compongono il celebre ciclo delle "Cronache Italiane" di Stendhal.
Lo scrittore deve all'Italia la nascita dell'idea di un nuovo romanzo: nel 1839, in 52 giorni, Stendhal scrive Il chiostro di Parma. Tutti i romanzi di Stendhal, tranne l'ultimo, non sono ricchi di intrighi: la trama di Rosso e Nero, ad esempio, può essere definita complessa? L'evento qui è la nascita di un pensiero, l'emergere di un sentimento. Nell'ultimo romanzo, Stendhal si mostra un maestro insuperabile nella costruzione della trama: ecco il tradimento di un padre, e il segreto della nascita di un figlio, e una misteriosa predizione, e omicidi, e prigionia, e una fuga da it, date segrete e molto altro.
Stendhal considerava l'analisi psicologica il compito più importante della letteratura moderna. In uno degli aspetti - in termini di specificità della psicologia nazionale - sviluppa personaggi ed eventi conflittuali nel racconto "Vanina Vanini" (1829) con un notevole sottotitolo: "Alcuni dettagli sull'ultima venta dei Carbonari, rivelati in lo Stato Pontificio".
Creato quasi contemporaneamente al racconto "Rosso e Nero" "Vanina Vanini" nella sua poetica si discosta dal romanzo. Il profondo psicologismo, manifestato nei lunghi monologhi interni del protagonista, che rallentano il ritmo dell'azione esterna nel romanzo, era infatti controindicato per il racconto italiano, la sua stessa natura di genere e personaggi. L'estremo laconismo delle descrizioni dell'autore, il rapido flusso degli eventi, la violenta reazione dei personaggi con il loro temperamento meridionale: tutto ciò crea uno speciale dinamismo e drammaticità della narrazione.
Gli eroi del romanzo - il carbonario italiano Pietro Missirilli e l'aristocratica romana Vanina Vanini, che si sono incontrati per forza di cose e si sono innamorati l'uno dell'altro, scoprono lati completamente diversi e persino opposti del carattere nazionale italiano in una difficile situazione drammatica.
Pietro Missirilli è un giovane italiano, un uomo povero che ha ereditato i tratti migliori del suo popolo, risvegliato dalla Rivoluzione francese, fiero, coraggioso e indipendente. L'odio per la tirannia e l'oscurantismo, il dolore per la patria, la sofferenza sotto il pesante giogo degli stranieri e dei feudatari locali, lo conducono a una delle bocche dei carbonari. Essendo diventato il suo ispiratore e leader, Pietro vede il suo destino e la sua felicità nella lotta per la libertà della sua patria. (Il suo prototipo è un amico di Stendhal, l'eroe del movimento di liberazione in Italia, Giuseppe Wismar.). La devozione a una causa pericolosa ma buona per l'Italia, il patriottismo, l'onestà e l'altruismo insiti in Missirilli consentono di definire il suo carattere eroico.
Al giovane Carbonari nel racconto si oppone Vanina Vanini: una natura forte, luminosa, intera. Aristocratico romano che non conosce eguali per bellezza e nobiltà, il caso riunisce Pietro, ferito durante una fuga dal carcere, dove, dopo una fallita rivolta, viene gettato dalle autorità. In esso Vanina scopre quelle qualità di cui sono privi i giovani del suo ambiente, incapaci né di prodezze né di forti movimenti dell'anima.
Il racconto "Vanina Vanini" unisce caratteristiche romantiche e realistiche:
1. La trama romantica del romanzo si oppone all'inizio realistico del romanzo: "Accadde in una sera di primavera di 182 ... anni".
2. L'immagine del protagonista Pietro Missirilli è romantica nella sua essenza. È pronto a sacrificare la sua vita per il bene della Patria.
Le attività dei Carbonari appartengono ai tratti realistici del romanzo. Le informazioni su di loro sono fornite da una posizione realistica. Il carattere tipico dei Carbonari è privo di circostanze tipiche. Non è mostrato in attività.
L'immagine di Pietro unisce romantico e realistico. tratti. Questa è l'immagine di una persona intera. È un combattente per il benessere del popolo, per la liberazione della Patria.
3. Nonostante la disuguaglianza sociale dei personaggi, viene mostrata una collisione amorosa (romantica e realistica).
4. Al tratto romantico si può attribuire il travestimento da uomo di Vanina per salvare Pietro e per i propri interessi egoistici.
5. Realistico i tratti caratteriali degli eroi sono determinati dall'educazione e dall'ambiente.
6. I tentativi di Vanina di salvare Pietro sono realistici nei contenuti, ma romantici nella forma.
7. Si può anche notare che il finale del racconto è realistico nei contenuti.
Creando un alone quasi romantico attorno al protagonista Pietro, Stendhal, da realista, determina rigorosamente i lineamenti della sua personalità: la passione è dovuta al fatto che è italiano, l'autore spiega la nazionalità dell'eroe e il fatto che dopo la sconfitta si fa religioso e considera peccato il suo amore per Vanina, per il quale viene punito questa sconfitta. Il determinismo sociale del carattere convince l'eroe - amato e amorevole - a preferire la sua patria alla sua amata donna. La figlia del patrizio Vanina apprezza l'amore sopra ogni cosa. È intelligente, al di sopra del suo ambiente per i bisogni spirituali. La "non laicità" dell'eroina spiega l'originalità del suo personaggio. Tuttavia, la sua originalità basta solo a mandare a morte 19 carbonari in nome del suo amore. Ciascuno degli eroi del romanzo di Stendhal comprende la felicità a modo suo e si propone di cercarla a modo suo.
Determinando personaggi realisticamente brillanti, come quelli dei romantici, Stendhal costruisce la stessa complessa trama, utilizzando sorprese, eventi eccezionali: una fuga da una fortezza, l'apparizione di un misterioso sconosciuto. Tuttavia, il "grano" della trama - la lotta della Venta Carbonari e la sua morte - è stato suggerito allo scrittore dalla storia stessa dell'Italia dell'Ottocento. Pertanto, le tendenze del realismo e del romanticismo si intrecciano nel racconto, ma il principio realistico del determinismo sociale e temporale rimane dominante. In quest'opera Stendhal si mostra un maestro del racconto: è breve nel realizzare ritratti (della bellezza di Vanina si intuisce dal fatto che ha attirato l'attenzione di tutti al ballo, dove c'erano le donne più belle, e il suo la luminosità era trasmessa indicando occhi e capelli scintillanti, neri come l'ala di un corvo). Stendhal crea con sicurezza un intrigo romanzesco pieno di colpi di scena improvvisi e un finale romanzesco inaspettato, quando i Carbonari vogliono uccidere Vanina per il tradimento di cui è orgogliosa, e il suo matrimonio si inserisce in poche righe e
diventare quella sorpresa obbligata preparata nel racconto psicologico dalla logica interna dei personaggi.
Davanti a noi c'è un esempio del realismo psicologico di Stendhal. È affascinato dal processo di rappresentazione dei sentimenti. Gli eroi sono felici finché il loro amore è privo del minimo egoismo.
"Vanina Vanini" è dialetticamente connessa con "Rosso e Nero" Il motivo dell'amore tra un aristocratico e un plebeo è riprodotto nel racconto sotto l'aspetto di variazioni del carattere nazionale italiano.
Per nove anni (1830-1839), Stendhal creò le sue opere più perfette: i romanzi "Rosso e nero", "Lucien Leven" ("Rosso e bianco"), "Monastero di Parma". La fioritura creativa è stata preparata dall'intera vita di Henri Bayle. Ha estratto materiale da costruzione, studiando l'epoca, conoscendo sempre meglio i suoi contemporanei. Ha imparato a costruire in modo nuovo, sviluppando un metodo creativo innovativo, uno stile individuale. Cominciò a creare romanzi - belli in un modo nuovo - quando aveva già imparato a porre sotto di essi quella solida base che da tempo aveva cominciato a prendere forma in altri suoi lavori e articoli: la conoscenza della realtà politica.
Stendhal, criticando nelle sue opere giornalistiche il sistema sociale esistente, rispondeva sempre alla domanda: cosa ha dato ai giovani di tutte le classi, a tutti gli strati della società?
E ha creato le sue opere per i lettori democratici - per i giovani che si accalcano al sesto piano *.
* (In Francia, il piano inferiore della casa si chiama rez-de-chaussee (al piano terra), il secondo piano si chiama primo, ecc. sesto - studenti poveri, piccoli dipendenti.)
La gioventù è «la speranza della patria», scriveva Stendhal (Corr. II, 245), è il futuro della nazione. Qual è l'eredità dei giovani nati durante il regno di Napoleone o dopo la restaurazione dei Borboni? (SA, III, 440, ecc.). Quali percorsi verso la felicità possono prendere? Cosa vedono come loro dovere? Perché il loro percorso di vita è così drammatico? Cosa insegna la loro esperienza alle generazioni future? Dopo "Armans", Henri Bayle si rivolge ancora e ancora a questi motivi nei racconti, nelle opere incompiute e nei suoi capolavori.
Stendhal, a partire da "Armans", e Balzac, a partire da "Shagreen Leather", hanno ripetutamente risposto alla domanda: quale attività pratica può essere svolta nelle condizioni di una società capitalista, senza essere un "prudente" ladro di denaro piccolo-borghese ? Cosa può diventare un giovane senza adattarsi a condizioni che lo sfigurano gravemente intellettualmente e moralmente? Questo tema, uno dei principali nella letteratura realistica francese del XIX-XX secolo, è stato per la prima volta coraggiosamente e rabbiosamente, profondamente umano e spietatamente sobrio in "Rosso e nero".
Proprio nel momento in cui l'aristocratico Octave trascurò la sua posizione elevata nella società, nel 1827, un giovane povero e oscuro di bassa nascita - Julien Sorel ("Rosso e nero") decise di alzarsi a tutti i costi e quindi fu costretto ad adattarsi le classi dominanti accettando le loro regole del gioco.
Ai lettori che hanno accusato Julien di cinismo, ipocrisia, disonestà, Stendhal ha risposto: le condizioni esistenti sono tali che un personaggio energico ha un'opportunità di manifestarsi - in "qualche canaglia". "Vi assicuro che nessuno ha fatto una grande fortuna senza essere Julien" * .
* (Les plus belles lettres de Stendhal, pp. 79, 75.)
Un altro giovane, Lucien Leven (l'eroe dell'omonimo romanzo), sarà convinto che l'attività pratica nel servizio pubblico durante gli anni della monarchia di luglio richieda capacità e voglia di essere senza scrupoli, senza cuore, disonesti.
Il terzo giovane, l'italiano Fabrizio Del Dongo ("Monastero di Parma"), rinuncerà all'attività pratica e ucciderà in se stesso, insieme alla sua enorme energia, alla sua solare allegria.
"Iniziativa personale" nelle opere di Stendhal è sinonimo di ciò che lui chiamava furfante. L'autore di "Red and Black" deve aver in parte e per questo sempre ammirato "Tom Jones" che Fielding in questo romanzo comprendesse la poetica del romanzo picaresco in questo modo. In Stendhal, Balzac, Daumier, socialmente concreti, tipici dell'epoca, le immagini dei ladri diventano estremamente capienti nei contenuti...
Dopo che la rivoluzione ha risvegliato l'energia del popolo, i giovani hanno potuto mostrare talenti nell'attività politica, o difendere l'indipendenza della loro patria sui campi di battaglia, o nel campo dell'industria e della tecnologia, o nella letteratura, nell'ideologia (come Bayle e Giuseppe Rey).
Napoleone utilizzò abilmente questa energia a suo modo: l'esercito del conquistatore assorbì la giovinezza e la gloria militare fu poeticizzata come suo unico ideale possibile.
Sotto i Borboni, la carriera militare diventa un privilegio della nobiltà. E l'energia risvegliata negli anni '20, quando le relazioni sociali borghesi si stavano già sviluppando, ribolliva. L'industria e il commercio ne hanno più che mai bisogno: la massa degli sfruttati cresce di pari passo con la ricchezza delle persone intraprendenti. Ma i giovani di talento sognano un destino diverso. "Il desiderio di creare in tutti i campi è imperativo quanto la sete di libertà" e "il bisogno insoddisfatto di attività" trova una via d'uscita nella passione per la scienza, la letteratura e gli insegnamenti dei socialisti utopisti, afferma il critico letterario francese R. Picard * sulle giovani generazioni di quell'epoca. I figli di medici, avvocati, ufficiali napoleonici, persone dotate delle "classi inferiori" della società si precipitano a Parigi, sperando di ottenere il successo. Uno di loro, il figlio del generale della Repubblica, arrivato nella capitale con cinquantatré franchi in tasca e superando ogni ostacolo, ha reso famoso il suo nome - Alexandre Dumas. Ma non tutti possono diventare scrittori o scienziati (come V. Jacquemont). I fortunati si diplomano al Politecnico. E il cammino di tanti giovani, cosparso di frammenti di speranze e illusioni, è desolato. Loro - e soprattutto di mentalità repubblicana - si uniscono alle fila degli intellettuali impoveriti.
* (R. Picard, Le romanticisme social, p. 61.)
A queste persone si oppone la nobiltà, "ignorante e pigra" (Stendhal), insidiosi gesuiti, insaziabili predatori borghesi. Negli anni '20 e '30, i reazionari si difendevano dai giovani talentuosi ed energici, ostacolando la loro attività, che era pericolosa per il sistema esistente. "La nostra società si sforza di distruggere tutto ciò che si eleva al di sopra del limite", scrisse Stendhal nel 1831 (Corr. III, 25).
Ma è sempre più difficile soffocare le richieste dei giovani dotati da parte del popolo e dell'ambiente piccolo-borghese, è impossibile sopprimere in loro il senso della dignità e la consapevolezza che le loro esigenze sono giuste. La posizione intollerabile delle nuove generazioni e la paura della classe dirigente di fronte ad essa sono tratti tipici sia della situazione prerivoluzionaria alla fine degli anni '20 che dell'era successiva alla Rivoluzione di luglio. Nel finale di "Red and Black" Julien Sorel ha parlato accuratamente di queste caratteristiche della situazione politica, che hanno dato origine al dramma del conflitto tra l'individuo e la società e hanno reso la sorte di Julien così triste.
La lotta di un giovane ribelle contro una società ostile è uno dei temi preferiti dai romantici francesi nell'era della Restaurazione. Allo stesso tempo, non solo in romanzi come "Jean Sbogar" di Ch. Nodier, ma anche in "Eriane" di V. Hugo, le convenzioni dello scenario corrispondevano a una rappresentazione simile di immagini esotiche, strappate alle circostanze caratteristiche di modernità.
Gli eroi di Stendhal vivono in uno specifico ambiente politico; in una collisione con lei, i loro personaggi si sviluppano. Sono inseparabili dall'epoca, i suoi segni sono impressi nel loro aspetto spirituale, nell'originalità individuale dei loro sentimenti e delle loro azioni. Ognuno di loro è una personalità unica e un carattere generalizzato tipico del loro tempo. Il lettore non ha dubbi sul fatto che siano persone reali, tutto è affidabile sia nei loro percorsi di vita insoliti che nel quadro della società.
Stendhal prese come scrittore-storico un resoconto dettagliato del caso di Antoine Berthe, pubblicato alla fine di dicembre 1827 nella "Gazette des Tribunaux" ("Gazette della Corte") *. Il seminarista Berte, figlio di un contadino fabbro, precettore nella famiglia borghese di Mishu, fu onorato del favore della padrona di casa; poi è stato licenziato. Divenuto precettore nella famiglia di un aristocratico proprietario terriero, Berte iniziò una relazione con sua figlia e fu nuovamente licenziato. Decidendo che questa era colpa della signora Mishu, il giovane orgoglioso e vendicativo le ha sparato in chiesa. Fu processato a Grenoble e giustiziato nel 1828 nella stessa Place de Grenet, che dominava la casa di suo nonno Henri Beyle.
Questo racconto è una delle fonti per l'ideazione del romanzo su Julien Sorel, la cui versione originale ("Julien"), probabilmente scritta alla fine del 1829, non è sopravvissuta.
La seconda fonte del concetto di "rosso e nero" è il resoconto giudiziario del caso Laffargue, utilizzato e commentato da Stendhal in "Walks in Rome". Laffargue, ebanista, originario di un ambiente piccolo-borghese, amava molto il suo mestiere, amava la filosofia e la letteratura, era modesto, ma fiero e orgoglioso. Una ragazza frivola ha pensato di fare di lui il suo amante. Poi ha rotto rudemente con Laffargue e sua madre ha chiesto al pubblico ministero di proteggere sua figlia dalla sua persecuzione. Insultato da questo tradimento e da una chiamata alla polizia, stremato dalla gelosia, il giovane lavoratore ha deciso: punirà il cattivo, questo è richiesto dalla giustizia. Dopo aver ucciso la ragazza, ha tentato senza successo di suicidarsi.
Il critico letterario francese Claude Liprandi, nella sua monografia molto dettagliata sulle fonti del "Rosso e nero", ha citato molte prove che l'immagine di Juliève Sorel è senza dubbio più vicina alla personalità, carattere del romantico, nervoso e nobile (in l'immagine dei cronisti) Laffargue che alla piuttosto meschina Bertha *.
* (Claude Liprandi, Au coeur du "Rouge". L "affaire Laffargue et" Le Rouge et le Noir ".)
Ma Laffargue, come Berthe, non può essere identificato con Julien Sorel. Stendhal ha attinto sia al caso Berthe che al caso Laffargue, che gli hanno suggerito l'idea e la trama del romanzo; erano, per così dire, carburante per i suoi pensieri e fantasie, attivandoli.
Non ne consegue che si possa sottovalutare l'aiuto del materiale fattuale, che ha aiutato Henri Beyle a mettere in moto la sua esperienza di vita, a realizzare creativamente la sua conoscenza dell'epoca e del cuore umano.
Il dramma del caso Laffargue, l'atmosfera di passione in esso, interessarono moltissimo Stendhal e lo ricordarono. "Se ora le persone uccidono persone, è per amore, come Otello", si legge nel capitolo di "Passeggiate a Roma" dedicato a Laffargue*. E ora l'autore della "Storia della pittura in Italia" ha scoperto tra la gente le passioni di Shakespeare. E non per nulla chiamò Otello: il Moro divenne generale, necessario e utile alla nobiltà veneziana, ma gli si oppone come uno straniero venuto da un altro mondo - e la sorte di Julien Sorel sarebbe stata la stessa, anche se nulla aveva interferito con la sua brillante carriera.
* (E non per amore del denaro, che, come ha più volte ricordato Stendhal, era più caratteristico del diciannovesimo secolo borghese.)
Il riavvicinamento del popolo, della passione e di Shakespeare, come un diapason, predeterminava sia la tensione drammatica che il carattere antiborghese del romanzo. Per Henri Bayle, così come durante la stesura dei pamphlet "Racine and Shakespeare", il nome del drammaturgo inglese è sinonimo di naturalezza, nazionale, arte popolare, sinonimo di negazione delle convenzioni nate dall'esistenza delle classi superiori .
Ma l'immaginazione creativa non potrebbe fare affidamento sull'analogia con Otello: in base a essa, sorgerebbe solo lo schema più generale, che mancherebbe di concretezza.
È stato introdotto dalle riflessioni di Stendhal su Laffargue come tipo sociale post-rivoluzionario! era.
Hanno portato lo scrittore a un'altra analogia: non letteraria, ma storica.
I giovani come Laffargue, dice l'autore di Passeggiate a Roma, se riescono a ottenere una buona istruzione, sono costretti a lavorare ea lottare con un reale bisogno, e quindi conservano la capacità di sentimenti forti e di energie terrificanti. Tuttavia, hanno un ego facilmente vulnerabile. E poiché l'ambizione nasce spesso da una combinazione di energia e orgoglio, Stendhal ha concluso la caratterizzazione del giovane plebeo con la seguente osservazione: "Probabilmente, tutti i grandi personaggi d'ora in poi verranno dalla classe a cui appartiene M. Laffargue. Napoleone una volta unì il stesse caratteristiche: una buona educazione, una fervida immaginazione e un'estrema povertà".
Nelle "Memorie di Napoleone" di Stendhal, il tenente di artiglieria Bonaparte è raffigurato come un giovane povero, orgoglioso e insolitamente versatile con un cuore focoso e un'energia inesauribile. Difendendo il sistema repubblicano, ha saputo mostrare il talento di un comandante, la mente di uno statista. Una fervente immaginazione lo condusse sulla via dell'ambizione. Ha schiacciato la rivoluzione per prendere il potere nel paese. Il grande uomo divenne il "genio del dispotismo".
Napoleone, per così dire, è un tipo classico di un giovane oscuro ma eccezionale, un uomo ambizioso e solitario, in grado di superare qualsiasi ostacolo per ottenere il successo in una società possessiva: onore, fama, ricchezza, potere. Per questo lo scrittore, parlando di Laffargue, ricordava Napoleone. Quale sarà il destino di un povero ardente, energico e ambizioso nell'era della Restaurazione? Riuscirà un tale giovane, proveniente dall'ambiente a cui appartiene Laffargue, a diventare un "grande uomo"? Quali ostacoli dovrà superare per farlo nelle condizioni moderne? Quale dovrebbe essere il suo carattere in modo che possa raggiungere il successo completo?
Considerando i percorsi di vita di Berthe e Laffargue alla luce delle sue riflessioni sulla storia di Francia, Stendhal ha scoperto nei fatti della cronaca criminale la fonte di una grandiosa generalizzazione artistica e filosofica sulla natura della società moderna.
Allo stesso tempo, quando lo scrittore ha incarnato questa generalizzazione per immagini, nel dramma del romanzo politico "Rosso e nero", ha parlato del percorso di un altro giovane povero, orgoglioso e ardente del XIX secolo.
2
Per comprendere correttamente il personaggio complesso di Julien Sorel, bisogna vedere come sia internamente connesso con l'immagine di Pietro Missirili, l'eroe del racconto "Vanina Vanini", e allo stesso tempo - contrario a lui. Nel racconto "Vanina Vanini" e nel romanzo "Rosso e nero" troviamo due versioni dello sviluppo dello stesso problema.
Questo racconto è un'opera di "vero romanticismo", che Stendhal, "gli ussari della libertà", non ha identificato con il romanticismo francese.
Descrive la vera storia d'amore di una sublime passione per la libertà che esiste nella vita. Questa passione combatte nel cuore dell'eroe - con amore; il cuore dell'eroina è nel potere dell'amore, dell'orgoglio e della gelosia; sentimenti potenti e violenti fanno sì che l'eroe e l'eroina non esiti a trascurare il pericolo.
La storia d'amore dei sentimenti ardenti è rappresentata da Stendhal in modo realistico, con sorprendente naturalezza. L'eroe della novella, Pietro Missirili, è un personaggio romantico di Stendhal. Ma è incarnato da Stendhal il realista.
Missirili è inseparabile dal suo tempo. La situazione individuale in cui agisce è generata dalla situazione storica, politica in cui si è formato il suo carattere. Il conflitto individuale nel racconto è dovuto all'intensità della lotta politica.
Il sottotitolo del racconto parla della situazione politica: "Speciali circostanze dell'esposizione dell'ultima Venta carbonari nello Stato Pontificio".
Il sottotitolo nello stile di un articolo storico o di una cronaca di un giornale di incidenti, per così dire, sottolinea la realtà innegabile del contenuto insolito del romanzo. E, come un diapason, il sottotitolo dà alla prosa di Stendhal il suo tono generale: professionale, piuttosto secco, esteriormente impassibile.
BG Reizov ha mostrato che, sebbene nel sottotitolo e nello stile di "Vanina Vanini" ci sia un'ambientazione per il documentario, il contenuto del romanzo è lontano dallo "scherzo" su cui si basava la fantasia di Stendhal, trasformandola completamente. sarebbe più corretto dire non tanto sulle "fonti" di "Vanina Vanini" quanto sui materiali che hanno ispirato Stendhal e lo hanno aiutato nel suo lavoro creativo di pensiero e immaginazione "*. La conclusione che caratterizza lo stile dell'opera di Bayle non riguarda solo questo racconto, ma è anche vero in relazione ai capolavori di Stendhal - "Rosso e nero", "Lucien Leven", "Monastero di Parma".
* (BG Reizov, Sulla questione delle fonti del racconto di Stendhal "Vanina Vanini" .- Note scientifiche dell'Università di Leningrado, n. 299, una serie di scienze filologiche, n. 59, Filologia romanza L. 1961, p.171.)
"Vanina Vanini" è un dramma di un nuovo tipo, Stendhal, in forma di racconto-cronaca. L'azione in esso si sviluppa ancora più rapidamente che nei racconti di Merime scritti prima di lei. E anche tra la maggior parte delle opere di Stendhal, la prosa di "Vanina Vanini" spicca per la sua concisione ed energia. Questa impressione è rafforzata dalla sua capacità: l'autore è laconico, ma non ha perso una sola circostanza, non ha sacrificato un solo passaggio essenziale, sfumatura nelle esperienze e nei pensieri dei personaggi per brevità. Il lettore è sicuro sia dell'autenticità del dramma sia di aver imparato tutto al riguardo; più dettagli allevierebbe la sua tensione.
Maxim Gorky ha raccontato in una nota su Balzac quanto L. Tolstoj apprezzasse molto la capacità di Stendhal, Flaubert, Maupassant di "concentrare il contenuto" * . Quest'arte di Stendhal si è pienamente manifestata nel racconto "Vanina Vanini".
* (M. Gorkij, Sobr. operazione. in trenta volumi, v. 24, p. 140.)
L'esposizione, che occupa solo due pagine, caratterizza: la situazione politica, l'ambiente di appartenenza di Vanina, l'evento che divenne il presupposto per l'inizio del dramma (la fuga romantica di Missirili dal castello carcerario). L'esposizione fornisce anche una motivazione psicologica per gli schemi della trama, l'ulteriore sviluppo del dramma e del conflitto: Vanina è il personaggio di una nobile ragazza romantica, tipico delle opere di Stendhal, che disprezza i giovani aristocratici graziosi ma vuoti ed è in grado di riconoscere una persona intelligente, energica, coraggiosa dal popolo in quanto degna del suo rispetto e del suo amore.
Il culmine nello sviluppo dell'azione (il suo significato Stendhal sottolineato in corsivo) occupa solo sedici righe. In essi, con straordinario laconismo, si concentrano sia il conflitto in cui si scontrarono tragicamente Vanina e Missirili, sia i tratti salienti di queste immagini.
Il giovane carbonarius Missirili, un uomo povero, figlio di un chirurgo, e Vanina, distinti per la sua intelligenza, indipendenza di giudizio, straordinaria bellezza e posizione elevata nella società, si innamorarono l'uno dell'altro. Cosa c'è di nuovo in questi personaggi?
Maxim Gorky definì "la vera e unica eroina del libro di Stendhal" la volontà di vivere*. L'enorme vitalità e determinazione degli eroi delle opere di Henri Bayle si esprimono sempre nella volontà di vivere, non quella che le circostanze impongono loro, ma un'altra, bella nella loro immaginazione.
* ()
A Missirili tutto è soggetto alla sua volontà inflessibile: aiuterà a liberare e unire l'Italia. Questo è l'unico modo in cui vuole vivere: per la lotta e la vittoria. Non gli piace il sacrificio. Soffre insieme al suo popolo umiliato, e per lui un dovere verso la sua patria è un dovere verso se stesso. Lui, orgoglioso patriota e rivoluzionario, non si sottometterà mai! In Vanina, fiera della consapevolezza che la sua personalità è significativa, tutto è subordinato alla volontà di conquistare la felicità, che la società laica non può darle.
Vanina trova questa felicità nel suo amore per Missirili. Ha preferito a tutti la giovane Carbonari e sarà l'unica padrona del suo cuore, scalzando da lui la sua rivale Italia.
Ma questo è impossibile. Missirili è "spericolato". Lui, il "pazzo", preferisce la sorte del ribelle perseguitato alla felicità personale: nulla gli farà tradire il suo sacro dovere. Missirili, come Vanina, è un personaggio olistico.
Il conflitto è inevitabile.
Ricordando la promessa che le fece Missirili (la rivolta da lui organizzata sarà l'ultimo tentativo di liberare la patria), Vanina invia al legato pontificio l'elenco dei membri della venta; cancella prudentemente il nome del suo amante. Missirili viene a sapere che i suoi compagni sono stati arrestati. La sua disperazione e rabbia sono sconfinate. Chi è il traditore? È libero e sarà sospettato! Pertanto, deve consegnarsi immediatamente nelle mani del legato. Salutando Vanina, Missirili chiede: "Distruggi, distruggi il traditore, anche se è mio padre".
"Sì, punirò il vile traditore, ma prima bisogna restituire la libertà a Pietro", esclama Vanina, colta da un dolore crudele.
Questo è il climax di Corneille del dramma romantico di Stendhal.
Ma solo il personaggio di Missirili è a livello di grande tragedia. Con eroica onestà e franchezza, pronuncia su se stesso una dura sentenza: ha tradito il suo dovere, donando a una donna il suo cuore, che appartiene alla sua patria; ecco perché la rivolta è fallita. "Le richieste del dovere sono crudeli, amico mio", dice semplicemente, sinceramente, senza la minima ostentazione, "ma se potessero essere soddisfatte facilmente, quale sarebbe l'eroismo?"
Immagina che Vanina abbia mantenuto la sua parola, data da lei in un impeto di pentimento e dolore, e abbia punito il traditore: se stessa. Poi sarebbe diventata alla pari di Missirili. Come sarebbe scioccante la tragedia del suo destino! Questo sarebbe successo se Vanina fosse stata devota agli interessi della madrepatria come Missirili, e se non avesse potuto perdonarsi per l'orgoglio che l'aveva accecata. Ma è disperata solo perché, per sua colpa, Missirili si priva della sua libertà. La sua passione sconsiderata - pensa lei stessa - per i giovani carbonari è impareggiabile con l'amore-devozione che Stendhal ha ritratto in altre opere come una fusione appassionata e spirituale di due creature. Vanina si è lasciata trasportare e si comporta in modo sconsiderato, audace, ma non come il suo amante. Rimane una persona di un altro mondo, aliena e ostile a Missirili. L'amore per lui è solo un episodio straordinario, romantico e tragico nell'esistenza monotona, come un'eterna festa, serra di una nobile ragazza.
Stendhal ha ammesso in "Memorie di un egoista": non immagina "una persona reale non dotata almeno in piccola parte di coraggiosa energia * e resistenza, profondità di convinzione ...". Nel racconto "Vanina Vanini", lo scrittore ha creato un carattere poetico generalizzato di una persona così reale: un membro di una società rivoluzionaria segreta, coraggioso, inflessibile, sicuro di aver scelto la strada giusta. È molto importante che Missirili non sia un "superuomo", non un misterioso, raro eroe. Modesto, si considera uno dei tanti. Non è elevato al di sopra dei suoi compagni. Il suo stile di vita eroico è motivato e ritratto come "l'impavida coerenza di un uomo onesto, un vero patriota. E l'onesta accuratezza della retorica aliena del romanzo, lo stile della cronaca, la logica ferrea e la naturalezza nello sviluppo della sua azione drammatica sembrano inseparabili da l'aspetto dell'eroe del romanzo.L'armoniosa corrispondenza di stile e costruzione della trama ai personaggi, attraverso l'azione dei personaggi principali e continuerà ad essere un tratto distintivo dell'abilità realistica di Stendhal.
* (Stendhal corsivo.)
Un giovane avanzato del 19° secolo, Missirili non ha sbagliato a scegliere un obiettivo per il quale vale la pena dedicare la sua vita.
E in Francia negli anni della Restaurazione c'erano i carbonaria - "nobili pazzi" che scelsero la stessa meta di Missirili.
Il loro coetaneo, un altro giovane del 19° secolo, Julien Sorel, avendo preso una strada diversa, si è tragicamente sbagliato.
3
In The Life of Henri Brulard, Stendhal ha ricordato di essere stato felice nel 1830 mentre lavorava a Red and Black. L'editore ha ricevuto uno per uno modificato, integrato con nuovi episodi e dettagli del capitolo. Le pagine scritte alla vigilia della Rivoluzione di luglio venivano dattiloscritte e stampate in agosto: gli stampatori, secondo A. Martino, combattevano per le strade durante la rivolta.
In Rosso e nero, Stendhal ritrae la Francia "com'è nel 1830". Stendhal ha quindi sostituito il sottotitolo del romanzo "The Chronicle of 1830" con un altro - "The Chronicle of the 19th Century", che corrispondeva maggiormente alle parole dell'autore (in un discorso ai lettori) che il libro era stato scritto nel 1827, e la cronologia di "Rosso e nero" (la sua azione inizia nell'autunno del 1826 e termina nel luglio 1831, e nel finale, come ha scoperto A. Martino, che ha tracciato il tracciato cronologico del romanzo, ci sono incongruenze nella datazione di eventi).
"Vero. Verità amara." Queste parole sono l'epigrafe della prima parte di "Red and Black". Stendhal li ha attribuiti a Danton: in fondo, la verità è una forza rivoluzionaria.
Romano - uno specchio che si porta lungo la strada maestra - si legge in "Rosso e Nero"; riflette sia le pozzanghere che l'azzurro del cielo, sia basso che sublime. La parola "specchio" suona qui come sinonimo di realismo (ma non naturalismo). Il lavoro di Stendhal non è mai stato una copia speculare della realtà o della sua imitazione.
A Stendhal non piaceva descrivere la situazione, i costumi. E non ha considerato la plausibilità esterna delle descrizioni il raggiungimento della letteratura, che descrive accuratamente la vita. Ma quando creava un romanzo, faceva sempre affidamento sui fatti, sulla realtà. Come ha fatto?
Claude Liprandi, nella sua prima monografia su "Rosso e nero" * ha giustamente affermato che il sottotitolo di questo romanzo - "Cronaca del XIX secolo" - ha un carattere programmatico. Esprimendo fiducia che l'opera di Stendhal contenga molti accenni di eventi dell'epoca che non sono stati ancora svelati, che i fatti reali si nascondono dietro i "minimi dettagli", K. Liprandi ne ha citati alcuni, da lui decifrati. Le sue conclusioni: nella storia ("Rosso e Nero" la storia è raffigurata sia "come potrebbe essere" ("cosa potrebbe accadere"), sia "com'era" **. Esatto. Ma K. Liprandi ha torto e si contraddice quando dice che "Rosso e nero" è "non un romanzo politico" *** e che Stendhal ha rappresentato i tratti tipici della modernità, rimanendo neutrale, cioè usando oggettivamente i fatti, senza trasformarli.
* (Claude Liprandi, Stendhal, le "bord de l" eau" et la "note secrete", Avignone, 1949.)
** (Claude Liprandi, Stendhal, le "bord de l" eau" et la "note secrete", Avignone, 1949. p. 136.)
*** (Claude Liprandi, Stendhal, le "bord de l" eau" et la "note secrete", p. 188.)
La concretezza, l'accuratezza dell'incarnazione della realtà in "Red and Black" e in altre opere di Stendhal non ha nulla a che fare con l'oggettivismo. Studiando criticamente la vita della società, creandone un quadro realistico e generalizzato, lo scrittore ha fuso fatti reali nel suo laboratorio creativo, ha individuato le cose più importanti in essi, esaltato, caratterizzato e subordinato tutti i dettagli al suo piano.
"Dominic è un sostenitore dei dettagli ..." - scrisse Stendhal (M.I.M., II, 97,). I "piccoli fatti reali" (come li chiamava lui) sono i mattoni dell'autenticità da cui lo scrittore realista costruisce, descrive il movimento della vita. Sono collegati al concetto ideologico e aiutano lo sviluppo dell'azione. Dopo un lungo addestramento, Bayle imparò subito, "senza prepararsi in anticipo" (M. L., I, 157), a trovare i dettagli caratteristici necessari.
Sia i grandi fatti veri (tutto ciò che è legato al tema già storico di Napoleone, o rapporti di corte nella "Gazette des Tribunaux"), sia i "fatti" erano necessari a Stendhal come supporto per la sua immaginazione creativa. Sottolineò addirittura, avvenne, ai margini del manoscritto che tale e tale dettaglio non era stato inventato da lui (ad esempio, ai margini del "Monastero di Parma" annotò: vide la tavola musiva fiorentina, circa che aveva appena scritto, vide allora, là). Tali "fatti autentici" hanno facilitato il processo di reincarnazione di Stendhal, hanno contribuito a raggiungere la naturalezza dell'immagine.
L'esperienza ha anche convinto Stendhal che è utile per uno scrittore, mentre nutre immagini, scolpisce personaggi, immaginare persone reali che conosce bene *. Ricercatori francesi hanno scoperto che i personaggi di "Red and Black" avevano dei veri prototipi**. Lo stesso si può dire con certezza per altri episodi. Si è scoperto che anche il palazzo del marchese de la Mole era stato copiato dalla lussuosa casa di Talleyrand.
* ("Descrivendo un uomo, una donna, un luogo, pensa a persone reali, cose reali", consigliò l'aspirante scrittrice Madame Gauthier nel 1834 (Corr. III, 115).)
** (I prototipi di alcuni degli eroi di "Armans" furono nominati dallo stesso Stendhal.)
Ma i personaggi del romanzo non sono ritratti in movimento. Il carattere artisticamente e storicamente concreto di Julien Sorel è incomparabilmente più ampio, più profondo, più complesso, più significativo, più tipico e quindi più reale per noi rispetto alle persone concrete di tutti i giorni degli anni '20 del XIX secolo - Berthe e Laffargue, come appaiono in perizie giudiziarie e altro materiale. Il Palazzo del Marchese de la Mole non è una fotografia della casa di Talleyrand. E Verrières è un'immagine generalizzata di città di provincia. Prendendo costantemente materiale vitale dalle abbondanti riserve della memoria e senza mai trattenere l'immaginazione, Stendhal ha creato personaggi tipici, nuovi sia nei contenuti sociali che nella loro originalità artistica. Allo stesso tempo, hanno caratteristiche individuali e socialmente caratteristiche. Il nobile borghese di provincia de Renal, l'aristocratico parigino de la Mole, l'uomo semplice Fouquet sembrano persone di mondi diversi, sebbene siano tutti francesi dell'era della Restaurazione.
Per delineare la situazione principale - storica, prerivoluzionaria - del "Rosso e Nero", Stendhal dipinse nei capitoli dedicati alla nota segreta, la congiura degli ultrarealisti: prevedendo l'inevitabilità della rivoluzione, decidono di creare distaccamenti della Guardia Bianca e invitare gli interventisti stranieri a frenare i parigini e l'intero popolo francese. Ma, come sappiamo, la situazione politica tipica dell'epoca diede origine anche al conflitto centrale nel romanzo tra il povero Julien e il sistema sociale ostile ai poveri.
L'autore del romanzo non si nasconde: non è impassibile. Ma, amando e odiando, esamina sempre sobriamente i veri motivi dei suoi contemporanei. È grazie a questo tratto prezioso del realismo di Stendhal - la giustizia della sua "giustizia poetica" - che le immagini del romanzo sono così vitali e plastiche e la critica all'ordine sociale in esso contenuta è così innegabile.
L'eroe della Resistenza, il poeta Jacques Decors, ha affermato in un articolo sul "Rosso e nero" pubblicato dopo la sua morte: Stendhal ha rappresentato lo sviluppo del personaggio di Julien con la logica ferrea di un matematico, come se risolvesse un problema dopo l'altro. E l'intero romanzo conquista il lettore fin dalla prima pagina con una logica ferrea, con la quale ogni dettaglio prepara e mostra la condizionalità oggettiva dello sviluppo dell'azione drammatica.
Nel 1826 Henri Beyle osservò: un romanzo dovrebbe essere scritto in modo tale che quando leggi una pagina, "non potresti mai indovinare il contenuto della successiva" (SA, III, 155). Nel 1838 Stendhal consigliò a uno scrittore: dalla sesta all'ottava pagina del romanzo, dovrebbe iniziare "l'avventura" (azione). In "Red and Black" gli imprevisti del lettore si annidano in ogni pagina, e fin dalla prima pagina tutti i dettagli introducono l'ambiente ei personaggi in modo tale da preparare l'azione.
Iniziando a leggere il romanzo, scopriamo: i giardini del ricco signor de Renal, "dove tutto il muro sul muro", pressava la segheria di Sorel, il padre di Julien. Il paesaggio non è solo descritto. Partecipa attivamente al rapporto tra i personaggi e all'esposizione. Vediamo come la vanità del sindaco spavaldo Verrières (uno di quei borghesi che si sentono patriottici quando guardano con orgoglio i propri mobili; MIM, II, 92) e l'avidità del vecchio contadino - i tratti principali dei loro personaggi - appaiano nel trattative per l'acquisto del terreno di de Renal Sorel.
Nell'epigrafe al primo capitolo - l'immagine della cella; lo scrittore più di una volta in questo capitolo accenna ai muri che racchiudono i possedimenti privati, alla tirannia dell'«opinione pubblica» della borghesia provinciale. Il motivo dei muri, delle recinzioni, delle gabbie è la chiave del tema dell'essere proprietari e dei poveri in un paese di provincia, del tema dell'immobilità di questa vita, della generale disunione, della sfiducia, della costrizione. In questa gabbia prospera il signor de Renal, un nobile ultra che si vergogna di diventare un industriale, un proprietario soddisfatto di sé, con una casa eccellente e una moglie beneducata. Julien Sorel soffoca in questa gabbia.
4
A margine di "Armans" Stendhal scriveva: "il romanzo è creato dall'azione" (M.I.M., II, 76). Julien pensava molto alla vita, ma non lo sapeva. Ogni ora - nella casa del signor de Renal, in seminario, a Parigi - incontra circostanze che non aveva previsto, che lo costringono ad agire. La conoscenza della vita di Julien è efficace. Lo sviluppo del suo personaggio è associato a brusche svolte in azione.
L'autore di "Red and Black" dopo la pubblicazione di quest'opera ha più volte espresso rammarico per il fatto che l'odio per l'"eloquenza" languida e pretenziosa di Chateaubriand lo abbia spinto a rendere "asciutti" alcuni capitoli del romanzo e a preferire uno stile "acuto" , frasi "troppo compresse", "a scatti", "tritate" (MIM, II, 137, 140, 141, "La vita di Henri Brular"), rendendo difficile - temeva - la percezione della sua opera. È giusta questa autocritica? Ogni frase del romanzo sull'energia rovinata di un povero di talento è satura di energia, che è generata dal contenuto del libro. Questo stile laconico è completamente adattato alla rappresentazione dell'azione. L'importanza della statistica per la caratterizzazione dello stile non va esagerata; eppure non è un caso che in "Rosso e Nero" i sostantivi non predominano molto sui verbi *.
* (In Padre Goriot, Balzac ha il doppio dei nomi dei verbi. Come ha scoperto il famoso linguista francese Marcel Cohen, nella prosa romantica una frase senza verbo è abbastanza comune. Interessanti sono le conclusioni della ricercatrice sovietica N. N. Teterevnikova dalle sue osservazioni sullo stile di "Rosso e nero"; diventa "tagliato" e soprattutto laconico "nei momenti più drammatici dell'azione, come se portasse avanti gli eventi principali del romanzo, o nei momenti di massima tensione emotiva"; il ritmo della prosa in questo romanzo "come se obbedisse al ritmo dell'azione stessa, a volte al pensiero stesso del personaggio" (cioè l'azione interna. - Ya. F.); le caratteristiche dello stile di Stendhal sono giustificate dalla situazione, sono internamente legate al contenuto (NN Teterevnikova, Sullo stile di Stendhal (il ruolo stilistico di alcune forme di costruzione e combinazione di frasi). - Note scientifiche dell'Università di Leningrado, n. 299, una serie di scienze filologiche, n. 59, Filologia romanza, L. 1961, pp. 224-237).)
Il dialogo in "Red and Black" è ricco di azione. E Stendhal ha ampiamente, magistralmente utilizzato una scoperta innovativa - un monologo interno pieno di dramma per rappresentare tutte le sfumature nei pensieri e nelle esperienze di Julien, Madame de Renal e Mathilde de la Mole - un'azione interna, la cui continuazione sono azioni inseparabili da esso.
La psicologia dei personaggi del romanzo è complessa e contraddittoria. La loro relazione è inseparabile dalla lotta mentale. È nell'opera dei pensieri e dei movimenti spirituali di Julien che sia la sua effettiva lotta per un obiettivo che la lotta interiore che sperimenta allo stesso tempo sono incarnati con rilievo scultoreo. Probabilmente a questo aspetto più importante della maestria di Stendhal pensò il grande artista della "dialettica dell'anima" Lev Tolstoj quando, rileggendo "Rosso e nero", notò che, proprio come nei primi anni Quaranta, ed ora nel 1883, egli non mi è piaciuto tutto in questo romanzo, ma il "coraggio, affinità" di Stendhal con lui, Tolstoj, suscita simpatia per lui *.
* (LN Tolstoj, Poln. coll. soch., serie 3, Lettere, vol. 83. Goslitizdat, M. 1938, p. 410.)
Nell'aspetto profondamente intellettuale di Julien, un eroe caratterizzato da un intenso lavoro di pensiero, è impressa la vittoria finale di un nuovo modo di rappresentare le persone dopo "Armans". "Questa celebrazione della mente, resa possibile dalla nuova tecnica, è stata una rottura decisiva con la tradizione romantica, la moda", ha giustamente notato Jean Prevost nella sua opera "Creation at Stendhal". Julien, con lo sguardo penetrante del nemico, vede il mondo in cui vive, lo esplora e le sue stesse esperienze, penetra con il pensiero nel passato, cerca di discernere il suo futuro. Il lettore, insieme all'eroe del romanzo, comprende gli eventi e tutto gli è chiaro. "Quindi, il romanzo non è più una storia misteriosa, in cui l'epilogo fa chiarezza?" - ha scritto Jean Prevost, sviluppando la sua idea, contrapponendo "Red and Black" alla tradizione romantica *. L'eroe, critico nei confronti della sua vita, è apparso per la prima volta nell'opera dell'autore degli opuscoli "Racine and Shakespeare", il cui motto è "Exploring". Stendhal ha svolto il suo programma pionieristico. Ha sollevato, - ha affermato M. Gorky, - "un reato molto ordinario al livello di studio storico e filosofico del sistema sociale della borghesia all'inizio del XIX secolo" ** Stendhal stesso chiamato anche "Rosso e nero" "una narrativa filosofica".
* (Jean Prevost, Creation chez Stendhal, Parigi, 1951, p. 253.)
** (M. Gorkij, Sobr. operazione. in trenta volumi, v. 26, p. 219.)
Nel romanzo, come ha giustamente notato J. Prevost, due punti di vista si scontrano: il lettore vede tutto ciò che accade in "Red and Black", sia attraverso gli occhi di Julien, sia attraverso gli occhi dell'autore, i cui orizzonti sono incomparabilmente più ampi , chissà cosa non è chiaro al suo eroe, e dalla torre della sua visione del mondo esamina da vicino la situazione politica, la società e il percorso di Julien in essa. La tecnica della "doppia visione" è un mezzo visivo soggetto a vigile critiche e che crea l'impressione di completa obiettività; partecipa anche alla creazione della profondità corrispondente alla prospettiva nella pittura.
L'intenso lavoro di pensiero e l'acutezza dei sentimenti di Julien Sorel sono motivati dal fatto che il mondo dei proprietari e della nobiltà si presenta davanti all'eroe del romanzo come un'area dell'ignoto, piena di pericoli, come un paese sconosciuto a Julien con pendii vertiginosi e abissi profondi. La rappresentazione del percorso di vita di Julien Sorel come una straordinaria avventura nella sfera dei pensieri e delle esperienze è giustificata non solo psicologicamente, ma anche dall'origine sociale e plebea dell'eroe.
5
Quindi, in Francia, dove prevale la reazione, non c'è spazio per le persone di talento del popolo. Soffocano e muoiono, come in prigione. Chi è privato dei privilegi e della ricchezza deve, per autodifesa e, ancor più, per riuscire, adattarsi.
Il comportamento di Julien Sorel è condizionato dalla situazione politica. Lega in un tutto unico e inseparabile il quadro della morale, il dramma delle esperienze, il destino dell'eroe del romanzo.
Julien Sorel è un giovane del popolo. K. Liprandi trascrive dal romanzo le parole che caratterizzano Julien in termini sociali: "figlio di un contadino", "giovane contadino", "figlio di un operaio", "giovane operaio", "figlio di un falegname", "povero falegname". Infatti, il figlio di un contadino proprietario di una segheria deve lavorarci, proprio come suo padre, i fratelli. Secondo la sua posizione sociale, Julien è un lavoratore (ma non un impiegato); è estraneo nel mondo dei ricchi, colti, colti. Ma anche nella sua stessa famiglia, questo plebeo di talento con una "faccia sorprendentemente particolare" è come un brutto anatroccolo: suo padre e i suoi fratelli odiano il giovane "piccolo", inutile, sognante, impulsivo, incomprensibile. A diciannove anni sembra un ragazzo spaventato. E in esso si annida e ribolle un'enorme energia: il potere di una mente lucida, un carattere orgoglioso, una volontà inflessibile, una "sensibilità violenta". La sua anima e la sua immaginazione sono infuocate, nei suoi occhi c'è una fiamma.
Questo non è il ritratto di un eroe byronico come il Corsaro, Manfred. Il byronismo è stato a lungo dominato dagli snob dell'alta società, è diventato una posa che presto tornerà utile nei palazzi parigini e in Julien Sorel. L'eccessivo sviluppo romantico, per così dire, di tutti i tratti, qualità e abilità nel ritratto di Julien (in armonia con le svolte più acute dell'azione e situazioni incredibili) è di origine quotidiana e politica. Stendhal aveva bisogno che il lettore sentisse e vedesse quale enorme e preziosa energia umana, risvegliata nelle classi "basse" dall'era delle rivoluzioni francesi, travolge questo giovane dotato dal popolo e, non trovando via d'uscita, alimenta il "sacro fuoco" di ambizione che sempre più divampa in lui. . È sulla tragica inutilità di questa energia popolare nell'era reazionaria che è stato scritto il romanzo di Stendhal. Julien è in fondo alla scala sociale. Sente di essere capace di grandi azioni che lo eleverebbero. Ma le circostanze gli sono ostili.
Il critico letterario americano Michael Guggenheim ha accusato Aragon, Jean Varloo e alcuni altri scrittori comunisti francesi nell'articolo "I comunisti e Stendhal" di aver distorto l'immagine di Henri Beyle, dipingendolo come un democratico e un uomo avanzato dell'epoca. È solo nelle loro opere che "il sognatore tende la mano al proletario", ironicamente M. Guggenheim. Il critico letterario americano ha sostituito tutta la complessità dell'atteggiamento di Stendhal nei confronti delle masse con il suo "disgusto per il volgare" (che M. Guggenheim, a quanto pare, identifica completamente con il popolo).
L'approccio soggettivo di M. Guggenheim alla letteratura si è scontrato con l'obiettività scientifica dell'approccio di partito - ed è quello che è successo. Come potrebbe Aragon - esclama l'autore dell'articolo - chiamare il figlio del povero falegname Julien Sorel, che ha la sensibilità più fine! "Aragon si affrettò a dimenticare tutto ciò che avvicina l'eroe di" Rosso e Nero "insieme al giovane Henri Bayle (figlio di un ricco borghese). Se fosse significativo in Julien che è figlio di un povero falegname, lo farebbe non essere così vicino a Fabrizio o Lucien Leven, che appartengono alle migliori famiglie" * .
* (Michael Guggenheim, Les communistes et Stendhal.- "Simposio", vol. XI, n. 2, Autunno 1957, Syracuse, New York, pp. 258-259.)
L'autore di "Rosso e nero" più di una volta definì Julien "figlio di un falegname", "figlio di un operaio", "un povero falegname". Apparentemente, considerava molto significativo che il giovane "senza radici", un uomo del popolo, sia più intelligente, più sensibile, più nobile, più talentuoso della progenie dell'aristocrazia che incontra nel romanzo. Quanto alle "famiglie migliori", dovremo, guardando al futuro, ricordare che il padre di Lucien Levin (nel romanzo omonimo), un ricco banchiere, è raffigurato come il "furfante" più intelligente e affascinante, e il vecchio Del Dongo nel "Monastero di Parma" è descritto come una persona disgustosamente volgare e bassa (il lettore viene inoltre informato che il padre di Fabrizio non è lui, ma un ufficiale francese).
Così M. Guggenheim entrò in polemica non con Aragon e altri scrittori comunisti francesi, ma con Henri Beyle, figlio di un ricco borghese. L'autore dell'articolo è stato deluso dal suo biografismo primitivo, il modo sociologico volgare di analizzare la letteratura.
Julien lo sa per certo: vive nel campo dei nemici. Pertanto, è amareggiato, riservato e sempre diffidente. Nessuno sa quanto odi i ricchi arroganti: deve fingere. Nessuno sa cosa sogna con entusiasmo, rileggendo i suoi libri preferiti - Rousseau e "Memoriale di Sant'Elena" di Las Casa. Il suo eroe, divinità, maestro è Napoleone, luogotenente divenuto imperatore. Se Julien fosse nato prima, lui, soldato di Napoleone, avrebbe conquistato la gloria sui campi di battaglia. Il suo elemento è l'eroismo delle imprese. È apparso sulla terra in ritardo - nessuno ha bisogno di prodezze. Eppure, come un cucciolo di leone tra i lupi, solo, crede nelle proprie forze - e nient'altro. Julien è uno contro tutti. E nella sua immaginazione sta già sconfiggendo i suoi nemici - come Napoleone!
Nel 1838, Stendhal notò che l'immaginazione sfrenata di Julien è una delle caratteristiche più importanti del suo personaggio: "Dieci anni prima, l'autore, desiderando disegnare un giovane sensibile e onesto, lo rese, creando Julien Sorel, non solo ambizioso, ma anche con la testa traboccante di fantasia e di illusione» (ML, I, 235-236).
In questa combinazione (sensibilità e onestà accresciute, potere dell'immaginazione, ambizione e fede nell'illusione) - tutta l'originalità unica e individuale del personaggio di Julien, la cristallizzazione dei suoi sentimenti, la sua attraverso l'azione.
L'ardente immaginazione di Julien lo eleva al di sopra dell'ambiente, al di sopra dei limitati proprietari e funzionari, che possono solo sognare una nuova acquisizione, una nuova ricompensa. "Prudente" de Renal, Valno e simili, Julien si oppone come personaggio poetico, come "pazzo" che disprezza la prosa vile della loro esistenza. Caratterizzando Julien nel suo articolo inedito scritto per la rivista italiana "Antologia" ("Antologia"), Stendhal ha elogiato la rappresentazione delle "follie" di Julien Sorel: sono sorprendenti, ma tratteggiate con quella naturalezza in cui l'autore del romanzo vede l'ideale della bellezza nello stile (ML , II, 351).
Ma l'eroe di "Rosso e Nero" non è un "pazzo" come Pietro Missirili. E i giovani Carbonari dei suoi sogni sono elevati al di sopra dell'ambiente. E si oppone agli aristocratici e agli oppressori "prudenti" d'Italia come personaggio straordinario e poetico. Ma la "follia" di Pietro Missirili è nata dai suoi principi, dalla sua onesta coerenza di combattente per la libertà della sua patria.
In Julien Sorel, l'immaginazione è soggiogata da un'ambizione violenta.
L'ambizione di per sé non è una qualità negativa. La parola francese "ambizione" significa sia "ambizione" che "sete di gloria", "sete di onori" e "aspirazione", "aspirazione"; l'ambizione, - come diceva La Rochefoucauld, - non avviene con letargia spirituale, in essa - "vivicità e ardore dell'anima". L'ambizione fa sì che una persona sviluppi le sue capacità e superi le difficoltà.
Indipendentemente da ciò che Julien intraprende, la vivacità e l'ardore della sua anima fanno miracoli. La sua organizzazione psicofisiologica è un apparato notevole in termini di sensibilità, velocità e impeccabilità d'azione; Stendhal il fisiologo si è occupato di questo. Julien Sorel è come una nave attrezzata per un lungo viaggio, e il fuoco dell'ambizione in altre condizioni sociali, fornendo spazio all'energia creativa delle masse, lo aiuterebbe a superare il viaggio più difficile.
Ma ora le condizioni non favoriscono Julien e l'ambizione lo costringe ad adattarsi alle regole del gioco di qualcun altro: vede che per raggiungere il successo, comportamenti rigidamente egoistici, pretese e ipocrisie, sfiducia militante nei confronti delle persone e guadagnarsi la superiorità su di loro sono necessario.
Il giovane plebeo è nel potere dell'illusione: lui, solo contro tutti, ci riuscirà, come Napoleone! È ambizioso e non si fermerà davanti a nulla!
Ma l'onestà naturale, la generosità, la sensibilità che elevano Julien al di sopra dell'ambiente, sono in conflitto con ciò che l'ambizione gli impone nelle condizioni esistenti.
Sulla base di questa contraddizione si forma la complessità del personaggio, la personalità del giovane "pazzo"...
Alcuni romantici, esprimendo disgusto per la prosa vile del sistema borghese volgare, glorificavano l'alienazione dalla società. "La solitudine è sacra", esclamò Vigny. «Oh tre volte sacra solitudine!» gli fece eco Musei.
"La dipendenza reciproca e totale degli individui, indifferenti gli uni agli altri, forma il loro legame sociale"*, generato dall'economia capitalista. Gli individualisti romantici, poeticizzando (indifferenza reciproca), immaginavano di chiedere così la protezione dei diritti dell'individuo dalle relazioni sociali ostili, ribellandosi alla dipendenza da esse.In realtà, l'individualista sta solo cercando di adattarsi pienamente a queste relazioni. Tale individualismo era - e rimane - una personalità immaginaria di autodifesa dalla società, autoinganno generato dall'illusione.
* (K. Marx, Capitolo sul denaro, Archivio Marx ed Engels, Vol. IV, Partizdat, M. 1935. p. 87.)
Già prima della rivoluzione del 1830, osservatori obiettivi potevano vedere che anche nella stessa società borghese, disprezzata dai romantici individualisti, fioriva lo stesso individualismo, ma nella forma di una lotta di lupi per il successo. In Francia, "chagun pour soi" * è il fondamento della saggezza instillata nei bambini." "Questa esistenza per se stessi è la fonte primaria di tutti i mali che hanno colpito i francesi", leggiamo in una lettera dalla Francia, pubblicata nel 1829 nel Bollettino di Mosca di scienze naturali e medicina" (n. 7).
* (Ognuno per sé (francese).)
E per Julien, la solitudine è l'illusione della liberazione dalla gabbia. Ma, come già sappiamo, sogna la solitudine non per legittima difesa, ma per vittoria. "Ognuno per sé" - e il suo motto. In montagna, in piedi su un'alta scogliera, Julien invidia lo sparviero che vola sopra di lui, un predatore piumato. Se un giovane diventa come un falco, si alzerà davvero al di sopra di tutti. "Questo era il destino di Napoleone - forse lo stesso mi aspetta?" pensa Julien.
L'idea del destino di Napoleone è collegata nel romanzo con l'immagine di un falco (e non un'aquila o un falco). L'immagine di un'aquila di solito dà origine a un'idea poetica di grandezza, l'immagine di un falco - di coraggio. Bayle in gioventù chiamò Bonaparte "Aquilone", ma non un'aquila o un falco. Poi odiava il Primo Console, un tiranno estraneo alla vera grandezza, perché aveva rubato la libertà alla Francia. Sebbene ora il pubblicista Stendhal opponga con aria di sfida il "grande imperatore" ai nuovi insignificanti governanti, in un'opera d'arte la sua "giustizia poetica" gli dice il contrario: paragona ancora una volta il famoso carrierista, il cui esempio ha dato vita in Francia a "folle e, certo, sfortunata ambizione"*, non con il "re degli uccelli", ma semplicemente con un rapace.
* ("Passeggiate a Roma" (corsivo mio. - Ya. F.).)
Il falco sembra a Julien Sorel l'incarnazione della forza e della solitudine. Per uscire dalla gabbia, per sconfiggere innumerevoli nemici e avere successo, bisogna diventare soli e forti, come un predatore. E devi essere vigile, pronto ad attaccare in qualsiasi momento. Il motto di Julien: "Alle armi!" Al lettore, non sembra una fanfara da ragazzo: Julien è determinato e prende sempre molto sul serio le sue parole e le sue azioni. Solitudine e ambizione lo hanno privato del divertimento (solo in compagnia della sua amata donna, Madame de Renal, sa di cosa si tratta). Lo hanno privato della vera giovinezza: pesa con cura ogni parola, temendo la spontaneità involontaria, costretto a essere saggio come un serpente. La solitudine e l'orgoglio hanno insegnato a Julien ad apprezzare l'aiuto delle armi. E quando gli sembra di dover difendere il suo onore, rivolgerà la sua arma contro la signora de Renal! Ma non come predatore, ma come Sid, perché non ha dubbi che l'onore è la cosa più preziosa. Non sappiamo se Julien abbia letto la tragedia di Corneille; ma il giovane Henri Bayle l'ammirava.
L'azione dell'ambizioso Julien Sorel era tipica dell'epoca. Claude Liprandi osserva che molti pamphleter, storici, giornalisti e pubblicisti politici hanno scritto indignati durante gli anni della Restaurazione sul carrierismo, la lotta feroce per un posto al sole, come "l'abominio dell'epoca". L'eroe di "Rosso e nero", ricorda K. Liprandi, "è caratteristico del suo tempo", "profondamente veritiero". E gli scrittori dell'era Stendhal videro che l'immagine di Julien era "vera e moderna" * . Ma molti sono rimasti imbarazzati dal fatto che l'autore del romanzo abbia espresso in modo audace, insolitamente chiaro e vivido il significato storico dell'argomento, rendendo il suo eroe non un personaggio negativo, non un carrierista canaglia, ma un plebeo dotato e ribelle, che il social sistema privato di tutti i diritti e quindi costretto a battersi per loro. , a prescindere da qualsiasi cosa.
* (C. Liprandi, Au coeur du "Rouge", pp. 292-293.)
Stendhal contrasta consapevolmente e costantemente gli eccezionali talenti e la naturale nobiltà di Julien con la sua "sfortunata" ambizione. Vediamo quali circostanze oggettive sono responsabili della cristallizzazione dell'individualismo militante di un plebeo di talento. Siamo anche convinti di quanto sia stato disastroso per la personalità di Julien il percorso verso il quale la sua ambizione lo ha spinto.
6
Julien spicca a Verrières: la sua straordinaria memoria stupisce tutti. Pertanto, il ricco de Renal ne ha bisogno come un altro piacere di vanità, per Verrières è considerevole, sebbene più piccolo delle mura intorno ai giardini del sindaco. Inaspettatamente per se stesso, il giovane si stabilisce nella casa del nemico: è un tutore della famiglia de Renal...
Guai a chi è negligente nel campo dei nemici! Per non mostrare gentilezza, per essere vigili, attenti e spietati, si dice il discepolo di Napoleone. Nei monologhi interni, cerca ancora e ancora di penetrare nei pensieri segreti e veri di tutti coloro con cui la vita lo confronta e si critica costantemente, sviluppando una linea del suo comportamento: la tattica più corretta. Vuole essere sempre diretto verso il suo obiettivo, come una lama sguainata. Vincerà se vede attraverso i suoi avversari e non lo scoprono mai. Pertanto, non ci si dovrebbe fidare di nessuno e stare attenti all'amore, che offusca la sfiducia. La principale arma tattica di Julien dovrebbe essere la finzione.
Nel 1804, il critico teatrale reazionario Geoffrey attaccò con odio la commedia di Molière Tartuffe. Negli anni della Restaurazione Tartufo fu pubblicato spesso, anche in grande diffusione: ancora oggi partecipò alla lotta dei liberali contro gli ultrareazionari, alla Congregazione, e all'insidiosa ipocrisia dei Gesuiti. In quelle città dove i missionari erano particolarmente zelanti nel riportare gli abitanti in seno alla chiesa e invitarli sulla via del pentimento e dell'umiltà, i biglietti per le rappresentazioni del tartufo andarono esauriti molto rapidamente. Così è stato a Rouen, Lione, Brest. A Rouen e Brest, le autorità vietarono questo spettacolo e l'indignazione del pubblico fu così grande che furono chiamati i soldati e sgomberarono la sala del teatro, respingendo i cittadini con fucili a baionetta fissa. Niente del genere potrebbe succedere nemmeno alla prima "scandalosa" di "Ernani". La satira di "Tartuffe" suonava più d'attualità (ecco perché è stata bandita). Il tartufo, a differenza dei drammi di Marivaux, «vivrà nel 1922», scriveva Stendhal (Corr., II, 280).
Julien menziona due volte il suo secondo insegnante: Tartufo. Il giovane conosce il suo ruolo a memoria.
Julien, dice l'autore del romanzo, è nobile e coraggioso. E nel XIX secolo i potenti, se non uccidono i coraggiosi, li gettano in prigione, li condannano all'esilio, li sottopongono a umiliazioni insopportabili. Julien è solo e può contare solo sull'astuzia. Capisce che morirà, rivelando il suo volto, tradendo il suo segreto: l'ammirazione per Napoleone. Pertanto, pensa il giovane, è necessario combattere gli ipocriti con le proprie armi.
Il comportamento di Tartufo è "Gesuitismo in azione", scrisse Bayle, analizzando la commedia di Molière nel 1813*. Il regista francese moderno Roger Planchon, dopo aver messo in scena questo spettacolo nel suo teatro, ha mostrato che le azioni del gesuita sono un cinico avventurismo mascherato da finzione; questa interpretazione si avvicina all'analisi di "Tartuffe" nelle note di Henri Bayle. Così, per vincere nella lotta dell'uno contro tutti, Julien Sorel è pronto non solo a indossare una maschera, ma anche a soffocare in sé ciò che gli impedisce di diventare un ipocrita-avventuriero, come i suoi nemici (e nemici di Stendhal ) - i Gesuiti. Julien è pronto a tutto pur di avere successo. Se necessario, il gesuitismo sarà per sempre una seconda natura per lui! È solo nel campo dei nemici, è in guerra! Ma riuscirà a diventare Tartufo?
Un povero, un uomo semplice, non può più essere un ufficiale. E ora non ci riescono i militari, ma preti e bigotti in "tanacche corte". I discepoli di Joseph de Maistre sono penetrati in tutti i pori della società. Se i missionari operano nelle province, allora a Parigi ci sono predicatori "laici". In uno degli articoli di Stendhal per il New Monthly Magazine inglese c'è un laconico schizzo di un ballo in una casa aristocratica nel 1826: "Un bel giovane sacerdote pronuncia un sermone per quarantacinque minuti in un tono gentile e malinconico. Poi si ritira, e la palla inizia". Questo non è successo sul palcoscenico del teatro, non nel nuovo Tartufo, ma nella vita. Sorprendentemente simile a questo prete bello e squisitamente malinconico, il vescovo di Agde, la cui giovinezza ha stupito Julien: dopotutto, ha raggiunto senza sforzo una posizione "più alta nella società rispetto ai marescialli di Napoleone, bruciati dalla polvere da sparo di sanguinose battaglie! Quindi, la religione è un campo in cui Julien è obbligato a fare una brillante carriera!
Aveva già memorizzato il Nuovo Testamento in latino e il libro "Sul papa" di de Maistre ("crederlo poco" come il primo). Chi altro è capace di una tale impresa? Il benevolo e severo Abbé Chelan aiuterà Julien ad entrare in seminario.
Ma è estremamente difficile per un giovane orgoglioso, intelligente e appassionato indossare la maschera dell'umiltà e della stupida ipocrisia - l'"uniforme" di un uomo ambizioso senza radici nell'era della Restaurazione. Riuscirà sempre a fingere e avere successo, a prescindere da qualsiasi cosa? "O Napoleone, com'era meraviglioso il tuo tempo quando le persone hanno vinto la loro posizione nei pericoli della battaglia! Ma per sfondare la meschinità, aumentando le sofferenze dei poveri ..." Il nobile plebeo non è capace di questo.
Julien entra in seminario come una prigione. "Ci sono solo feroci nemici in giro. E che lavoro infernale è... - ipocrisia ogni minuto. Sì, metterà in ombra tutte le gesta di Ercole!" "Riuscì male nei suoi tentativi di ipocrisia con espressioni facciali e gesti ..." "Non poteva ottenere nulla, e ancor di più in un mestiere così vile". Si violenta senza pietà: non è facile diventare un gesuita Tartufo.
Stendhal considerava i capitoli dedicati al seminario - un'immagine satirica che dà l'impressione di uno studio oggettivo - i più riusciti del romanzo. Questa alta valutazione è probabilmente dovuta non solo al potere della satira, ma anche al fatto che lo scrittore ha rappresentato la vita di Julien in seminario con sorprendente plasticità e precisione come una battaglia in cui il giovane sconfigge se stesso. Solo una persona straordinaria è capace di tali sforzi, dice l'autore del romanzo. La volontà di ferro di Julien reprime il suo orgoglio violento, congela il suo spirito ardente. Per fare carriera, sarà il più impersonale dei seminaristi, impassibile e senz'anima, come un automa. Un giovane capace di atti eroici decide di suicidarsi moralmente.
La battaglia di Julien con se stesso è l'aspetto più importante del romanzo.
L'eroe de La regina di picche di Pushkin, Hermann è un giovane uomo ambizioso "con il profilo di Napoleone e l'anima di Mefistofele". E lui, come Julien, "aveva forti passioni e una fervida immaginazione". Ma la lotta interna gli è estranea. È prudente, crudele e con tutto il suo essere è diretto verso il suo obiettivo: la conquista della ricchezza. Non tiene davvero conto di nulla ed è come una lama sguainata.
Julien, forse, sarebbe diventato lo stesso se lui stesso non fosse apparso costantemente come un ostacolo di fronte a lui: il suo carattere nobile, ardente, orgoglioso, la sua onestà, la necessità di arrendersi ai sentimenti diretti, dimenticando la necessità di essere prudenti e ipocrita. La vita di Julien è la storia dei suoi tentativi falliti di adattarsi pienamente a condizioni sociali in cui trionfano gli interessi di base. La "primavera" del dramma nelle opere di Stendhal, i cui eroi sono giovani ambiziosi, dice lo scrittore francese Roger Vaillant nel suo libro "The Drama Experience", è interamente che questi eroi sono "costretti a forzare la loro ricca natura per svolgono il ruolo vile che essi stessi hanno imposto" * , Queste parole caratterizzano accuratamente il dramma dell'azione interna di "Rosso e Nero", che si basa sulla lotta mentale di Julien Sorel. Il pathos del romanzo sta nelle vicissitudini del tragico combattimento di Julien con se stesso, nella contraddizione tra il sublime (la natura di Julien) e il basso (la sua tattica dettata dalle relazioni sociali). Gli episodi più drammatici del romanzo (rappresentati il più delle volte attraverso il monologo interno e il dialogo) sono quelli in cui il bisogno di essere ipocriti e insidiosi - moralmente deformati, rende infelice Julien, e quelli in cui la natura del giovane prende il sopravvento . E vince più di una volta in situazioni importanti per lo sviluppo della trama ...
* (Roger Vailland, Experience du drama, Correa. Parigi, 1953, pp. 112-113.)
Stendhal, un amico di Methilde Dembowska, ha creato le immagini più poetiche della letteratura realistica francese di donne che sono pure e forti nello spirito, che affascinano per la profondità dell'esperienza e una mente sottile. La loro bellezza morale, per così dire, ricorda ai lettori che le relazioni sociali esistenti sono ostili alla fioritura della personalità della maggior parte delle persone; ma verrà il tempo in cui la norma della vita - tutto ciò che è veramente umano nelle persone - trionferà.
L'immagine della signora de Renal differisce da altri personaggi femminili poetici e sublimi nelle opere di Stendhal in quanto, in misura maggiore di loro, è quotidiana, inseparabile dalle circostanze specificamente rappresentate della vita provinciale. Eppure, corrisponde all'idea dello scrittore non della vanità del "carattere francese", ma dell'immediatezza dell'"italiano" e affine all'italiana Clelia ("Monastero di Parma"). Tali personaggi sono diventati possibili in Francia dopo un'era rivoluzionaria turbolenta, quando i sentimenti delle persone erano disinibiti.
Julien è nella casa del suo padrone - de Renal. È ostile diffidente, agitato e, quasi per la prima volta, insicuro di sé. La porta viene aperta da Madame de Renal. È gioiosamente stupita: un ragazzo bello e timido è quel formidabile tutore che d'ora in poi avrà potere sui suoi figli! Lui stesso è un ragazzo spaventato e ha bisogno di incoraggiamento!.. Da questo momento inizia il processo di cristallizzazione dell'amore di una donna sincera, ingenua che non conosce la vita per Julien.
Madame de Renal non è l'eroina dell'adulterio. Si è innamorata per la prima volta, davvero e per sempre. Julien, non de Renal, è il suo prescelto, il suo vero marito. La società considererà il suo amore illegale. Ma è dominato dall'ipocrisia e dalla falsità. Si è innamorata nonostante le false convenzioni e non si vergogna della sua passione. La felicità rivela la forza del carattere olistico di Madame de Renal, il cui fulcro è la sua capacità di essere infinitamente devota alla sua amata. È pronta a sfidare i pericoli ogni minuto. Questo è il coraggio della devozione. E questa è la "follia" di una donna, che il suo sentimento focoso ha elevato al di sopra della vile "prudenza" del prudente de Renal, suo rivale nella lotta per il successo - Valeno e altri pilastri della società di Verrier.
Ma davanti a Dio, ha peccato, rompendo il suo voto di fedeltà a de Renal. E quando il figlio più giovane si ammala, sa che Dio l'ha punita. Ma è devota ai suoi figli. Cosa sacrificare: la vita di un bambino o l'amore? .. L'accuratezza e la forza con cui sono raffigurati i tormenti di una donna sfortunata (e tuttavia felice, amorevole), la tangibilità fisica di tutte le sfumature dei sentimenti violenti, mai viste prima nella letteratura francese, è un vero trionfo della nuova letteratura.
L'autore del libro "On Love" ha già padroneggiato l'arte con una perfezione, inaccessibile ai romanzieri della sua epoca, per creare un personaggio forte e bello, il cui nucleo è un'azione interna, inseparabile dalla cristallizzazione dell'amore e la lotta di questo sentimento con circostanze ostili ...
All'inizio Julien sospetta di Madame de Renal: viene dal campo dei nemici. Il giovane si costringe a sedurla solo per dimostrare a se stesso di non essere un codardo. Ma poi, nella felicità di essere amato da una donna bella e nobile e di amarla appassionatamente, si dimentica della tattica. Fiducioso, come lei, spensierato, come un bambino, impara prima "la felicità di essere se stesso" comunicando con un'altra persona.
Ma questo è pericoloso: scartata la maschera, è disarmato! E ancora un altro Julien - freddo, amareggiato - ricorda: "Alle armi!" Deve essere insidioso, vivere in un mondo dove non c'è felicità spensierata...
L'orgoglio e l'intelletto di Julien si ribellano alla necessità di compiacere il compiaciuto signor de Renal, mascalzoni di successo come l'insolente ladro Valeno. Ma proprio perché non riesce a reprimere il suo orgoglio, a nascondere la forza del suo carattere, proprio perché in lui risplende continuamente la superiorità intellettuale e trionfano gli impulsi nobili, si distingue tra i borghesi di provincia, e tra i seminaristi, e tra gli eleganti ma aristocratici vuoti. Andrà lontano, madame de Renal, l'abate Pirard, il marchese de la Mole, Matilda pensano a Julien.
Julien, lasciando la casa di de Renal e Verrières per il seminario, e lei per Parigi, fa davvero una vertiginosa scalata nella scala sociale. E deve il suo favoloso successo più al suo carattere orgoglioso e audace, ai suoi talenti che alla tattica, all'ipocrisia.
Ma provò la felicità solo in quelle ore in cui, amando Madame de Renal, era lui stesso. Ora è soddisfatto un altro Julien, un uomo ambizioso, allievo di Napoleone.
La storia del rapporto tra il conquistatore plebeo e l'aristocratica Matilde, che, come Vanina Vanini, disprezza la giovane laica smidollata, non ha eguali nell'originalità, accuratezza e finezza del disegno, nella naturalezza con cui i sentimenti e le azioni dei personaggi sono rappresentati nelle situazioni più insolite.
Julien è follemente innamorato di Matilda, ma non dimentica nemmeno per un momento che si trova nell'odiato campo dei suoi nemici di classe. Matilda è consapevole della sua superiorità sull'ambiente ed è pronta alla "follia" per elevarsi al di sopra di esso. Ma la sua storia d'amore è pura testa. Decise che sarebbe diventata uguale al suo antenato, la cui vita era piena di amore e devozione, pericolo e rischio*. Così, a modo suo, ha percepito la poetizzazione del lontano passato storico nei circoli vicini a Carlo X. Per molto tempo, Julien può catturare il cuore di una ragazza razionale e ribelle solo spezzando il suo orgoglio. Per fare questo, devi nascondere la tua tenerezza, congelare la passione, applicare prudentemente le tattiche del dandy di grande esperienza Korazov. Julien si violenta: ancora una volta non deve essere se stesso. Alla fine, l'orgoglio arrogante di Matilda viene spezzato. Decide di sfidare la società e diventare la moglie di un plebeo, sicura che solo lui è degno del suo amore.
* (Alexandre Dumas, seguendo le orme di Stendhal, avrebbe poi descritto nel romanzo Queen Margot le avventure e la morte di questo antenato di Matilde, il conte de la Mole.)
Ma Julien, non credendo più nella costanza di Matilde, è ora costretto a recitare un ruolo. E fingere di essere felice è impossibile.
Ma il secondo Julien raggiunse la vetta, che sognava, in piedi su una scogliera.
7
Potrebbe Julien Sorel seguire la strada di Missirili, l'eroe del racconto "Vanina Vanini"?
Stendhal dice del suo eroe: "Sarebbe un degno compagno di quei cospiratori in guanti gialli che vogliono capovolgere tutto lo stile di vita di un grande paese e non vogliono avere il minimo graffio sulla loro coscienza" (Corsivo mio - Sì. F.).
A Verrières, Julien incontrò un solo "uomo rispettabile": "era un matematico di nome Gros, che aveva fama di giacobino". Solo nelle conversazioni con lui il giovane ha espresso apertamente i suoi pensieri. Gro è l'insegnante di geometria di Grenoble del ragazzo Bayle, un nobile povero, un uomo illuminato, un rivoluzionario giacobino impeccabile. Lo scrittore ha mantenuto un ricordo entusiasta di lui per il resto della sua vita. Ha avuto il piacere di parlare di Gro ne "La vita di Henri Brulard", di citarlo in "Walks in Rome" e di farne un personaggio in "Red and Black". E in tutti e tre i casi Stendhal ha lasciato Gros con il suo nome per perpetuare questa era buona, che ha avuto la fortuna di conoscere personalmente.
A Parigi Julien si avvicina all'emigrante Conte Altamira, carbonari italiano condannato a morte. Questo "cospiratore dai guanti gialli" ha lo stesso prototipo di base di Pietro Missirili, l'amico più anziano preferito di Stendhal, il rivoluzionario italiano Domenico Di Fiore. Ma i critici letterari francesi, non a caso, ritengono che Stendhal, creando l'immagine di Altamira, abbia ricordato anche l'altro suo amico, il carbonari Giuseppe Wismar. Convince anche la congettura di K. Liprandi che lo scrittore non poteva fare a meno di conoscere la biografia dell'ufficiale napoletano Antonio Galotti, condannato tre volte per reazione alla morte (ne hanno scritto su tutti i giornali). Le immagini create da Stendhal non sono mai state "copie".
Il carbonari spagnolo don Diego Bustos dice a Julien: "Altamira mi ha detto che sei uno dei nostri". Proprio come l'autore del romanzo, Altamira pensa che il vero posto di Julien sia tra i rivoluzionari.
Il tema dell'imminente rivoluzione è uno dei leitmotiv del romanzo. Anche Madame de Renal e Mathilde stanno pensando all'inevitabilità della rivoluzione, fiduciosi che quando scoppierà, Julien diventerà il nuovo Danton. Julien, parlando con Altamira (che esprime il pensiero dello stesso Stendhal), sente che il suo elemento è la rivoluzione. Non si farebbe intimidire dalla necessità di spargere sangue in nome del trionfo della giustizia; lui, a differenza di Altamira, potrebbe "eseguirne tre per salvarne quattro".
Ma questi sono sogni. Ma il percorso di vita di Julien è diverso. E il "nostro plebeo indignato" non è il modesto e disinteressato Missirili. Riflettendo sulla rivoluzione futura, sogna "gloria per se stesso e libertà per tutti". Gloria a te stesso - in primo luogo. E nei sogni di Missirili, Altamira e dello stesso Stendhal, il bene comune viene prima di tutto. Julien, più intelligente, più talentuoso e più forte di Missirili, odia la disuguaglianza. Ma dalla rupe discese ad Altamira, sulla quale invidiava la forza e la solitudine del falco. Discepolo di Napoleone, avvelenato dall'ambizione, sa: "ognuno è per sé in questo deserto dell'egoismo chiamato vita". E, facendo carriera, si abitua a essere arrogante e indifferente anche verso coloro che rispetta profondamente.
Lui, il segretario del potente marchese de la Mole, "trovò divertente" il fatto di poter ora fornire patrocinio. Ridendo, fece dell'anziano mascalzone de Cholain il direttore dell'ufficio della lotteria di Verrières. Non appena de Cholain fu nominato, Julien venne a sapere che una delegazione del dipartimento aveva già chiesto un posto per il "famoso matematico" Gros. Questo nobile donò parte della sua piccola rendita al dirigente d'ufficio recentemente scomparso, gravato da una famiglia numerosa. Avendo ricevuto un ufficio, Gro potrebbe mantenere la sua famiglia. "Come vivranno adesso?" - pensa Julien - quello che Altamira considera la sua persona simile. "Il suo cuore è affondato..." Ma poi il secondo Julien prende la parola - quello che sa: ognuno per sé. "È una sciocchezza", si disse, "non sai mai che devo commettere ogni sorta di ingiustizia se voglio avere successo..."
Julien Sorel avrebbe potuto prendere parte alla Rivoluzione di luglio se avesse seguito la strada di Altamira, Missirili. Ma il desiderio di riuscire e le circostanze spinsero l'uomo ambizioso su una strada diversa. Una settimana prima di quei “tre giorni gloriosi” del luglio 1830, quando i parigini presero d'assalto la monarchia borbonica, Julien Sorel prese d'assalto il palazzo del marchese de la Mole a modo suo: penetrò per la scala nella stanza della figlia del marchese e divenne il suo amante. Dopo la Rivoluzione di luglio, quando i democratici temevano che il popolo non si lasciasse ingannare dalla borghesia, Julien aveva le sue preoccupazioni: la ribelle Matilde aveva perso interesse per lui, lo odia! Nell'agosto - settembre 1830, Julien abilmente, audacemente, con incredibile autocontrollo e destrezza, svolge un pericoloso incarico dai leader dell'ultrapartito, che sono pronti a versare sangue sulla Francia. Internamente estraneo al campo dei nemici della rivoluzione, il giovane carrierista non esita a servirlo e legare a lui il suo destino. Una preziosa acquisizione per la decrepita classe aristocratica. E Julien, che si considera un sostenitore di Altamira, dovrebbe già essere chiaro che sta diventando sempre più invischiato nelle insidie delle circostanze e non diventerà il nuovo Danton. Il primo Julien è felice quando sogna segretamente la rivoluzione; è con i "pazzi" Altamira e Missirili. Il secondo Julien è chiaramente subordinato ai nemici della rivoluzione ea questi "pazzi". E gli ovvi trionfi.
Julien Sorel non è Pietro Missirili. L'orgoglio di un povero talentuoso e ambizioso e l'orgoglio di un povero, patriottico, rivoluzionario non sono la stessa cosa.
Tuttavia, ascoltiamo cosa dice l'autore del romanzo sull'eroe del romanzo: "Era ancora molto giovane, ma, secondo me, gli è stato posto molto bene"; mentre tante persone sensibili in gioventù diventano astute in seguito, Julien "avrebbe gradualmente acquisito con l'età una simpatica gentilezza ...". La reattività è la caratteristica principale di una persona reale, a cui, come il Gro giacobino, il bene comune è più caro di tutti.
In quali condizioni Julien, il cui personaggio si forma fino alla fine del romanzo, potrebbe diventare una persona del genere? Come genero dell'onnipotente marchese de la. Falena.- Un parvenu arrogante? Difficilmente.
Già dopo la Rivoluzione di luglio, nel marzo 1831, Stendhal parlava in una delle sue lettere di una nuova rivoluzione in arrivo, non borghese, ma popolare per contenuto e portata: è inevitabile, e "duecentomila Julien Sorel vivono in Francia" ( Corr., III, 42), plebei di talento che ricordano bene come il sottufficiale Augereau divenne generale dell'esercito repubblicano, e gli impiegati della procura - senatori e conti dell'Impero - si conquisteranno un posto nella vita, rovesciando il potere delle classi mediocri superiori.
E, partecipando a una tale rivoluzione - popolare -, Julien avrebbe sognato la "gloria per se stesso", e non solo la libertà per tutti. Ma allora avrebbero potuto trionfare i tratti nobili del suo carattere - quelli che furono cantati dopo la rivoluzione del 1830 dal poeta dei "duecentomila Julien Sorels" - Petrus Borel. Se tutto si fosse capovolto come nel 1793, la lotta rivoluzionaria del popolo che ha conquistato la libertà e l'ha difesa eroicamente avrebbe probabilmente rieducato progressivamente Julien.
Ma nel romanzo la rinascita di Julien resta una possibilità puramente speculativa. Le "follie" di Julien Sorel lo aiutano solo ad adattarsi alle relazioni sociali che sfigurano la sua natura...
"Rosso" non è solo i sogni irrealizzabili di Julien di imprese militari, gloria, ma anche l'anima orgogliosa e focosa di Julien, il fuoco della sua energia, il suo nobile sangue dei poveri versato dai ricchi. "Nero" non è solo l'oscurità della Restaurazione, dei Gesuiti, l'abbigliamento del seminarista Julien, ma anche l'ipocrisia, che il giovane voleva fare della sua seconda natura, sebbene gli fosse estranea, e che ne snaturasse la natura, ha paralizzato la sua vita. "Rosso" è anche l'ardore rivoluzionario dei sogni di Julien, amico di Altamira, "nero" è la sua partecipazione alla cospirazione segreta dell'ultrapartito... *
* (I critici letterari hanno cercato a lungo di decifrare il simbolismo del nome "Red and Black". Ecco tre interpretazioni delle più interessanti. prof. BG Reizov vede la fonte del titolo del romanzo nelle sue "scene profetiche": nella prima, avvenuta prima dell'inizio della carriera di Julien, un giovane legge su un pezzo di giornale, raccolto in una chiesa, dell'esecuzione di un certo Zhanrel; in questo momento, il sole, sfondando le tende cremisi delle finestre della chiesa, proietta un riflesso che dà all'acqua santa l'aspetto del sangue (predizione dell'omicidio); nella seconda scena - la prima apparizione di Matilda in profondo lutto, in cui sarà dopo l'esecuzione di Julien (profezia della punizione per omicidio) (Prof. B. Reizov, Perché Stendhal ha chiamato il suo romanzo "Rosso e nero".- "Nuovo Mondo", 1956, n. 8, pp. 275-278). Secondo lo scienziato italiano Luigi Foscolo Benedetto, "rosso" simboleggia lo stato d'animo di Julien, quando, in piedi su una scogliera, sogna di diventare un degno allievo di Napoleone; "nero" simboleggia il crollo delle illusioni di Julien, che è in prigione. Nel primo caso, scrive Benedetto, Julien sembra vedere la Francia napoleonica, le sue vittorie e la sua gloria, nel secondo - la Francia dei Gesuiti e le sue tenebre (Luigi Foscolo Benedetto, La Chartreuse noire. Comment naquait "La Chartreuse de Parme", Firenze, 1947, pp. 24-25). Accad. VV Vinogradov ha introdotto sia il titolo che il contenuto del romanzo "Red and Black" in una serie semantica associata ai motivi del "gioco" - "caso" - "fato", che è sfidata dal "giocatore": "La roulette o termine di carta nel titolo è già data la comprensione della realtà artistica nell'aspetto del gioco d'azzardo. E Julien Sorel, che voleva seguire la strada di Napoleone, perde tutte le scommesse in questo gioco "(VV Vinogradov, Stile della regina di picche . - "Pushkin. Provvisorio della Commissione Pushkin. Accademia delle scienze dell'URSS", 2, ed., Accademia delle scienze dell'URSS, Mosca-Leningrado 1936, pp. 100-101). L'ipotesi è spiritosa, ma semplifica il personaggio di Julien.)
Julien ha rifiutato l'opportunità di vivere in modo indipendente, lontano dai ricchi e dai nobili - ha rifiutato di diventare un compagno del suo devoto amico Fouche. Questo non era ciò che sognavano gli ambiziosi. E credeva nella sua stella. E ora è un brillante ufficiale, un dandy e un aristocratico dalla testa ai piedi, un uomo ricco. È Monsieur de la Verneuil, il fidanzato di Mathilde de la Mole. Ora facciano concorrenza a lui, alla sua energia vitale, giovani laici aggraziati e smidollati!
Una lettera falsa, che il pastore gesuita ha dettato a Madame de Renal, tormentato dalla gelosia, rovescia Julien da questa vetta. L'azione del romanzo si precipita a un tragico epilogo.
Se Julien fosse stato come l'eroe de La regina di picche, avrebbe potuto decidere, dopo aver preso dei soldi dal padre di Matilda, di partire per l'America. Ma è come posseduto e obbedisce solo al suo violento orgoglio. È stato insultato! Si vendicherà!
Julien l'ufficiale spara a Madame de Renal in chiesa. E subito «cessò lo stato di irritazione fisica e di semipazzia in cui si trovava, lasciando Parigi per Verrières». Dopo un'esplosione di energia infuocata, un sonno profondo dell'esausto Julien il prigioniero. Questo episodio è stato scritto dal fisiologo Stendhal, attento lettore di Pinel e Brousset, Mi che per un momento non dimentica la straordinaria sensibilità, ricettività, nervosismo di Julien, la sottigliezza, reattività, eccitabilità della sua organizzazione psicofisica.
È difficile abituarsi all'idea che tutto ciò che hai vissuto è finito. Ma è così. Julien è orgoglioso e quindi decide: deve pagare con la vita per il suo crimine. E ora, quando vuole solo morire con dignità, il secondo Julien - un uomo ambizioso - non ha più niente da sognare, niente da fare sulla terra. Per il prigioniero, tutto ciò che l'uomo ambizioso ha vinto con tali sforzi e improvvisamente perso è irreale. In carcere un giovane matura e allo stesso tempo diventa finalmente se stesso. È un bene che tu non debba più pensare a tattiche, astuzia, finzione!
All'inizio del romanzo - l'immagine di una cellula sociale. Negli ultimi capitoli - una cella di prigione. Il tema tragico della prigione in "Rosso e nero", la sua poesia cupa e orgogliosa sono collegati a uno dei motivi romantici nell'opera di Stendhal. In una cella di prigione, una persona reale, che odia l'ipocrisia e la crudeltà dei governanti e dei loro servi, si sente interiormente incomparabilmente più libera di coloro che si adattano a loro. Può acquisire chiarezza filosofica di pensiero, disprezzando il mondo della falsità e dell'oppressione. Il filosofo Van, che Julien ha visitato in una prigione di Londra, è "l'unica persona allegra" incontrata dall'eroe del romanzo in Inghilterra.
E Julien acquisisce gradualmente uno stato d'animo filosofico. Tutto ciò che è superficiale, brutto gli vola via come un guscio. Astuto come non mai, scruta la propria vita, si guarda sobriamente dall'esterno, calma Matilde, quasi sconvolta dal dolore e dalla gelosia, il cui amore è diventato anche passato.
Ogni giorno, per ore, Julien parla da solo. Dice a se stesso: divenuto marito di Mathilde de la Mole, in caso di guerra sarebbe stato colonnello ussaro, e in (tempo di pace - segretario dell'ambasciata, poi - ambasciatore a Vienna, Londra. Che meraviglia Ecco cosa avrebbe potuto sognare, se non fosse stato per l'incontro assolutamente urgente con la ghigliottina, il fatto che Julien, al solo pensiero, riesca a ridere "con tutto il cuore" è per Stendhal la prova più grande della forza e della grandezza dello spirito del figlio del falegname.
Secondo la legge della retribuzione per sacrilegio, Julien può essere severamente punito: ha tentato di uccidere in una chiesa. Ebbene, ha visto il re, presto vedrà il carnefice, il sostegno del trono. E già riconosceva i suoi contemporanei. Mentalmente, regola i conti con una società in cui i mascalzoni di successo sono circondati dall'onore. Quanto è superiore alla nobiltà l'uomo semplice Fouquet: onesto, schietto, altruista! Di chi ci si può fidare? Si rammarica di aver trascurato per amore dell'illusione la felicità di vivere in modo indipendente sulle montagne vicino a Verrières ...
Ora solo Julien si arrende, infatti, di nuovo disinteressatamente all'amore che gli è divampato nel cuore per Madame de Renal. Quando la sua ragazza è con lui, è spensierato come un bambino. "Facciamoci portare il prima possibile nella prigione, dove noi, come uccelli in gabbia, canteremo... così insieme vivremo e gioiremo", dice il re Lear, privato di tutto, a Cordelia dopo che i nemici sono stati catturati suo. "Pensateci, non sono mai stato così felice!", confessa Julien alla signora de Renal. Solo ora comprendeva l'arte di godersi la vita. La gabbia della società è terribile: anche in un dungeon, dicendo addio alla vita, puoi trovare più gioia che in quella prima gabbia!..
Il romanzo di Stendhal si conclude con l'illuminazione spirituale di Julien, che ora si è veramente innalzato al di sopra dei suoi nemici e di se stesso - com'era ieri - guarda la vita in un modo nuovo e vede il significato sociale del suo tragico destino.
Il diciannovenne Julien Sorel entrò tremante in seminario, come in un "inferno terrestre". Ha ventitré anni quando desidera maggiormente essere senza paura il giorno della sua esecuzione. L'inferno terrestre è più terribile della morte.
Julien viene informato che quasi nessuno vuole la sua morte. Potrebbe ottenere la grazia. Ma per questo bisognerebbe pentirsi, chiedere, umiliarsi. No, è meglio perdere la testa che piegarla davanti a un mascalzone trionfante e trionfante: il barone Valno, presidente di giuria! E Julien chiede di essere sepolto in montagna, non lontano dalla sua rupe, nella sua grotta, dove sognava la solitudine e la forza, le imprese e la vittoria. Lì, insieme a un plebeo di talento che credeva a Napoleone, le sue illusioni saranno sepolte.
Anche il gesuita Frieler ammette dopo il processo che la morte di Julien Sorel sarebbe stata "una specie di suicidio". Ma al processo, l'eroe de Il Rosso e il Nero, che per tanto tempo si è imposto l'ipocrisia, getta tutta la verità in faccia ai suoi nemici, agli aristocratici e ai borghesi; il primo Julien - ora l'unico - dice: viene giustiziato perché è un popolano che ha osato ribellarsi alla sua povera sorte; in questo modo vogliono "punire e spezzare una volta per tutte" tutti quei "giovani di bassa nascita" che sono riusciti a ottenere una buona educazione ea penetrare in un ambiente "che l'arroganza dei ricchi chiama buona società".
Sappiamo quale fosse l'implicazione per Stendhal in queste parole: le classi superiori hanno paura di "duecentomila Julien Sorel"; sono pericolosi anche quando cercano di adattarsi alle condizioni sociali esistenti. I giudici ascoltarono l'orgoglioso plebeo come se fosse uno di quelli che combatterono sulle barricate alla fine di luglio del 1830, che poi si risentirono senza fine della "folla" nelle città della Francia. E giustiziarono Julien, volendo vendicarsi di molti *.
* (In "Rosso e nero" c'è una sola data associata a un determinato evento: il 25 febbraio 1830, giorno della prima di "Ernani". Datando approssimativamente gli episodi del romanzo in cui si svolge l'azione prima di questo giorno e dopo di esso, e sugli intervalli di tempo tra i quali si trovano indicazioni nel testo, A. Martino ha costruito uno schema cronologico di "Rosso e Nero" - da settembre 1826 al 25 luglio 1831 (giorno di esecuzione di Julien Sorel). Pertanto, se questa data è approssimativamente corretta, Julien fu processato durante gli scioperi e i disordini a Parigi e nelle regioni industriali della Francia, e fu ghigliottinato esattamente un anno dopo la Rivoluzione di luglio. E inoltre - quasi otto mesi e mezzo dopo la pubblicazione del romanzo, di cui Julien è l'eroe! Questa data della morte di Julien Sorel non è solo spettacolare; Insolito, anche per un romanzo realistico estraneo alla copia, un salto nel futuro prossimo si inserisce senza esagerazione nella dialettica dello sviluppo della trama, nel significato sociale del "rosso e nero" e nella dialettica degli eventi reali. Questa data acuisce il sottotesto oggettivo della vita del finale: i ricchi odiano nella persona di Julien tutti i poveri coraggiosi e ribelli, i proletari che sanno ribellarsi.)
Il plebeo ribelle non poteva diventare un "eroe alla moda". Nei salotti su "Rosso e Nero" taceva. Donne e ragazze non hanno osato leggere quest'opera nemmeno di nascosto: la critica reazionaria ha riconosciuto la veridicità del romanzo politico di Stendhal come oscenamente cinica.
* (Solo una frase arrabbiata "senza tatto" di Julien sull'ambiente, "che l'arroganza dei ricchi chiama (corsivo mio - Y.F.) buona società" è stata sufficiente per irritare e dispiacere i conoscenti di Stendhal di questa stessa "buona società". Quelle signore che in precedenza avevano detto che questo irrequieto Bayle era rozzo, provinciale, decisero che Julien era il suo autoritratto.)
I giovani abitanti del sesto piano, invece, si sono chinati a lungo su Rosso e Nero nelle sale di lettura.
Il romanzo "Rosso e nero", forse il più insolito nella letteratura francese del XIX secolo, suonava come un terribile avvertimento: verrà il momento in cui i Julien Sorelis, giovani plebei che possono sognare appassionatamente un futuro migliore e combattere senza paura per il loro felicità - sarà in grado di trovare la strada giusta!
Così Stendhal si oppose al processo iniquo dei ricchi e dei nobili in "Rosso e nero" con la giustizia della sua "giustizia poetica".
8
Estratti dei primi capitoli del romanzo furono pubblicati il 4 novembre 1830 dal parigino "La Gazette litteraire" ("Gazette letteraria"), e dieci giorni dopo apparve la prima edizione in due volumi di "Rosso e nero", datata 1831 (750 copie). La rumorosa prima di "Ernani", avvenuta nello stesso 1830, è un trionfo del romanticismo francese; L'edizione del romanzo politico di Stendhal, non notata da tutti, è una vittoria del realismo francese del XIX secolo*.
* (Balzac nel 1830 stampa "Gobsek", nel 1831 - "Shagreen leather", nel 1832 - "Colonnello Chabert", e solo nel 1834 scrive "Father Goriot" - un'opera che può eguagliare la potenza del realismo con "Red and Black" . Nel 1831 Daumier iniziò a creare le sue litografie politiche.)
Nel 1830 il potere della grande borghesia fu formalizzato politicamente e, per così dire, consacrato dalle istituzioni della Monarchia di Luglio, che prese il posto dei Borboni. Il romanzo Rosso e nero, pubblicato dopo questo trionfo dei capitalisti, suonava come una condanna del loro dominio, innegabilmente motivato storicamente e politicamente, dalle circostanze del dramma e dal suo significato sociale, dalla logica irresistibile nello sviluppo della trama e personaggi, dall'attualità di questa cronaca moderna. Sorprendentemente perspicace e coraggioso, umano e quindi esigente nei confronti della società, di una persona, il realismo francese del XIX secolo è entrato nella vita delle persone. E l'esperienza di decenni ha confermato che questa letteratura è necessaria per generazioni, una dopo l'altra.
Ma non è così: pensavano molti dei contemporanei di Stendhal, compresi gli scrittori illuminati. Ad esempio, Jules Janin subito dopo l'apparizione di "Rosso e nero" ha classificato questo romanzo tra le cupe manifestazioni del soggettivismo, soggetto a ipocondria e malizia. In un articolo pubblicato dal quotidiano "Journal des Debats" nel dicembre 1830, J. Janin informò i lettori che Stendhal in "Red and Black" cospargeva "con il suo veleno" "tutto ciò che incontra: giovinezza, bellezza, illusioni ... fiori"; il mondo rappresentato da Stendhal è così brutto che sarebbe impossibile viverci.
In questa recensione, J. Janin ha continuato la controversia letteraria iniziata un anno prima nel romanzo The Dead Ass, or the Guillotine Woman (1829). Partendo da Stern e parodiando il sentimentalismo, narrando con ironia e naturalezza, Jeanin sviluppò alcuni dei temi tipici dei saggi fisiologici e alcuni dei motivi che sarebbero diventati puramente melodrammatici nei Segreti di Parigi di Eugene Sue. Come sfogliando un album con schizzi e minuscole miniature, J. Janin ha parlato in modo vivido e divertente di coloro che esistono, per così dire, al di fuori della società (della "ragazza della gioia", la cui storia è il fulcro della trama del libro, di un mendicante ereditario che è stato arrestato perché non aveva alcun brevetto per mendicare, sui custodi del bordello, sulle rispettabili madri di famiglia, contando il reddito, ecc.). Nel 1829, questo avrebbe dovuto suonare fresco e tagliente (il che probabilmente spiega la recensione di approvazione di Pushkin del romanzo di Janin).
Allo stesso tempo, la natura caleidoscopica e il tono delle chiacchiere leggere conferiscono all'"Asino morto" il carattere di una fiaba semi-feuilleton sulla vita invisibile di una grande città, e i sentimenti, le azioni dei personaggi, persino la morte dell'eroina sul patibolo, non obbligano il lettore a prenderle sul serio - proprio come inseriscono "barzellette" e parabole. Il romanzo di Zhanen è un'opera letteraria che pretende solo di essere divertente e parodica.
La controversia è anche associata alla parodia. Appare nella prefazione e passare nel testo del romanzo, è un programma feuilleton-pamphlet inserito in esso. Attacca gli scrittori che ignorano l'immaginazione e sono ossessionati dalla "passione di essere sinceri", raffigurando ciò che vedono e vedono solo ciò che provoca disgusto. Parodizzando francamente romantici violenti, e un saggio fisiologico, e un dramma genuino, alla ricerca di un realismo profondo, appianando così le differenze tra loro, Janin con un sorriso mostra le immagini dei pasticci parigini e dell'obitorio (ecco il dramma!), si accumulano " terribili" motivi (omicidio, esecuzione, ecc.). I francobolli sono solitamente parodiati. Janin ha voluto creare l'impressione che la verità della vita, il dramma, in quanto tale, siano cliché letterari, niente di più.
La veridicità è sempre ostile all'immaginazione, - esclama ripetutamente Janin, - questa è la tendenza a cercare gli "orrori", inventarli, "pervertire tutto nel mondo senza pietà e misericordia - trasformare la bellezza in bruttezza, la virtù in vizio, il giorno in notte...". Queste parole sembrano essere tratte dalla recensione di Janin di "Red and Black". Non c'è da stupirsi: dopo tutto, il motto dell'autore di questo romanzo è "Verità, amara verità", la sua immaginazione è amica della ricerca e ha rappresentato seriamente, profondamente e audacemente il dramma che ha trovato nella vita reale della società.
Pagina corrente: 1 (il libro totale ha 2 pagine)
Stendhal
Vanina Vanini
F.Stendal (Henri Beyle)
Vanina Vanini
Traduzione dal francese di N. Nemchinova.
Vanina Vanini
o Particolari dell'ultimo vente dei Carbonari,
scoperto nello Stato Pontificio
Accadde una sera di primavera del 182.... L'intera Roma era sommersa dall'eccitazione: il famigerato banchiere Duca de B. stava dando un ballo nel suo nuovo palazzo in Piazza Veneziana. La decorazione di questo palazzo combinava tutto lo splendore dell'arte italiana e tutti i trucchi del lusso londinese e parigino. Sono venuti molti ospiti. Aristocratici inglesi: le rigide bellezze bionde consideravano un onore apparire al ballo del banchiere. Si accalcarono in un intero sciame. Le donne più belle di Roma gareggiavano con loro in bellezza.
Una fanciulla entrò nella sala, a braccetto con il padre: occhi e capelli scintillanti, neri come un'ala di corvo, rivelavano in lei una donna romana; tutti gli occhi si girarono su di lei. Uno straordinario orgoglio brillava in ogni suo movimento.
Gli ospiti stranieri sono rimasti stupiti dallo splendore di questo ballo. "Nessuna festa dei monarchi d'Europa può essere paragonata ad essa", hanno detto.
I monarchi d'Europa non hanno palazzi creati dall'architettura italiana; sono costretti a invitare le loro dame di corte, mentre il duca de B. invitava solo belle donne. Questa sera la sua scelta è stata particolarmente vincente: gli uomini sono stati accecati. Si sono radunate così tante donne affascinanti che era difficile decidere a chi dare il palmo. Ma dopo qualche esitazione, la principessa Vanina Vanini, una ragazza dai capelli neri e dallo sguardo focoso, è stata proclamata all'unanimità regina del ballo. Immediatamente stranieri e giovani romani, usciti dai salotti, si affollarono nella sala da ballo.
Il padre della ragazza, il principe Azdrubale Vanini, desiderava che ballasse prima di tutto con due o tre principi sovrani tedeschi. Poi accettò l'invito di diversi inglesi, molto belli e molto nobili, ma il loro aspetto inamidato la annoiava. Sembrava provare più piacere a torturare il giovane Livio Savelli, che sembrava innamorarsi appassionatamente di lei. Livio fu uno dei giovani più brillanti della società romana e deteneva anche un titolo principesco; ma se gli fosse stato dato un romanzo da leggere, avrebbe buttato via il libro alla ventesima pagina, dichiarando che aveva mal di testa; agli occhi di Vanina, questo era un grosso svantaggio.
Intorno a mezzanotte, al ballo si è diffusa la notizia, che ha fatto molto parlare. Quella stessa sera, dalla fortezza del Santo Angelo [Fortezza del Santo Angelo - antica prigione a Roma.] fuggì vestito a festa un giovane carbonarii che fu imprigionato; giunti già agli ultimi cancelli della prigione, in preda a un romantico coraggio attaccò con un pugnale i soldati della guardia, ma fu ferito anche lui. Sbirs [Gli sbir sono guardie di polizia.] lo stanno inseguendo su sentieri insanguinati e sperano di catturarlo.
Mentre tutti parlavano di questa fuga, don Livio Savelli, deliziato dal fascino e dal successo di Vanina, quasi pazzo d'amore, esclamò, scortandola in poltrona dopo il ballo:
- Ma dimmi, per l'amor di Dio, chi potrebbe farti piacere?
“Il giovane Carbonari che oggi è scappato dalla rocca. Almeno ha fatto qualcosa, e non solo si è dato la briga di nascere.
Il principe Azdrubale si avvicinò a sua figlia. Questo uomo ricco per vent'anni non ha avuto bisogno di un conto dal suo maggiordomo, e gli ha prestato i suoi soldi a interessi molto alti. Se incontrassi il principe per strada, lo scambieresti per un vecchio attore; non ti accorgeresti nemmeno che le sue dita sono tempestate di anelli massicci con diamanti molto grandi. Entrambi i suoi figli entrarono nell'ordine dei Gesuiti [I Gesuiti sono un potente ordine monastico cattolico fondato nel XII secolo], poi impazzirono e morirono. Li ha dimenticati e si è arrabbiato con la sua unica figlia Vanina per non essersi sposata. La ragazza ha già diciannove anni e rifiuta le feste più brillanti. Qual è la ragione? Il motivo fu lo stesso che spinse Silla [Sulla (138-78 aC) - Generale romano, oppositore del partito popolare.] ad abdicare: disprezzo per i romani.
La mattina dopo, dopo il ballo, Vanina notò che suo padre, un uomo insolitamente spensierato che non aveva mai raccolto una chiave in vita sua, chiuse con estrema diligenza la porta della stretta scalinata che conduceva alle stanze situate al quarto piano del palazzo . Le finestre di queste stanze si affacciavano su una terrazza fiancheggiata da aranci in vaso.
Vanina si recò in città in visita; quando tornò, il portico anteriore era ingombra di luminarie e la carrozza attraversò il cortile sul retro. Vanina alzò gli occhi e, con sua sorpresa, vide che in una delle stanze, che suo padre aveva così accuratamente chiuso a chiave, era aperta una finestra. Liberatasi della sua compagna, salì in soffitta e, dopo aver cercato, vi trovò una finestrella sbarrata di fronte al terrazzo con gli aranci. La finestra aperta che la incuriosiva era a due passi. Qualcuno ovviamente si è trasferito nella stanza. Ma chi?
Il giorno dopo, Vanina riuscì a ottenere la chiave della porta che dava sul terrazzo con gli aranci. Di nascosto, andò alla finestra: era ancora aperta. Vanina si nascose dietro una persiana a grata. In fondo alla stanza, vide un letto. Qualcuno era sopra di lei. Vanina era imbarazzata, voleva scappare, ma improvvisamente notò un vestito da donna gettato su una sedia. Guardando da vicino, distinse una testa bionda sul cuscino; il suo viso sembrava molto giovane. Adesso non dubitava più che fosse una donna. L'abito gettato sulla sedia era coperto di sangue; il sangue era incrostato sulle scarpe da donna che stavano sul tavolo. Lo sconosciuto si mosse, e allora Vanina si accorse che era ferita: il suo petto era teso da una benda di lino, sulla quale si stendeva una macchia sanguinolenta; la benda era trattenuta da una specie di nastri: era chiaro che non era affatto realizzata dalle mani di un chirurgo.
Vanina cominciò a notare che ora suo padre si chiudeva nelle sue stanze tutti i giorni verso le quattro del pomeriggio, e poi andava a trovare uno sconosciuto; stette con lei per brevissimo tempo e, ritornato, salì subito in carrozza e si recò dalla contessa Vitelleschi. Appena uscito, Vanina salì sul terrazzino e osservò lo sconosciuto. Provò profonda compassione e simpatia per una donna così giovane e così sfortunata e cercò di svelare la sua storia. L'abito macchiato di sangue, gettato su una sedia, sembrava essere stato lacerato da colpi di pugnale. Vanina poteva contare i buchi.
Un giorno vide lo sconosciuto più chiaramente: giaceva immobile, gli occhi azzurri fissi nel cielo, come in preghiera, e all'improvviso i suoi begli occhi si riempirono di lacrime. In quel momento la principessa riuscì a malapena a trattenersi dal parlarle.
Il giorno successivo, Vanina decise di nascondersi sulla terrazza prima che apparisse suo padre. Vide come don Azrubale entrò nello straniero; portava in mano un cesto di provviste. Il principe era evidentemente allarmato, parlava poco e così piano che Vanina non sentiva nulla, anche se non chiudeva la porta a vetri. Presto se ne andò.
"Questa poveretta deve avere nemici molto pericolosi", pensò Vanina, poiché mio padre, persona così sbadato, non osa fidarsi di nessuno e ogni giorno sale lui stesso qui lungo una ripida scalinata di centoventi gradini.
Una sera, quando Vanina si avvicinò con cautela e sbirciò attraverso la finestra, il suo sguardo incontrò quello di un estraneo e tutto si rivelò. Vanina si gettò in ginocchio ed esclamò:
- Ti amo, sono tuo amico!
Lo sconosciuto le fece cenno di entrare.
"Perdonami, perdonami, per favore", ripeté Vanina. «Forse trovi offensiva la mia stupida curiosità. Giuro che manterrò tutto segreto e, se lo desideri, non tornerò mai più.
"Chi non sarebbe felice di vederti!" - disse lo sconosciuto. Vivi qui in questo palazzo?
"Certo", rispose Vanina. - Ma tu, a quanto pare, non mi conosci: sono Vanina, la figlia del principe Azdrubale.
Lo sconosciuto la guardò sorpreso e, arrossendo profondamente, aggiunse:
“Lasciami sperare che verrai ogni giorno, ma non vorrei che il principe lo sapesse.
Il cuore di Vanya batteva veloce. Tutti i modi dello straniero le sembravano pieni di dignità. Questa sfortunata giovane donna deve aver offeso una persona potente, o forse, in un impeto di gelosia, ucciso il suo amante. Vanina non permise il pensiero che la causa delle sue disgrazie potesse essere ordinaria. Lo sconosciuto ha detto che era stata ferita alla spalla e al torace e stava soffrendo molto. Spesso sanguina in gola.
"E non hai invitato un chirurgo?" esclamò Vanina.
«Sapete che a Roma», disse lo sconosciuto, «i chirurghi sono tenuti a denunciare immediatamente alla polizia tutti i feriti che curano. Il principe è così misericordioso che fascia le mie ferite con questo panno.
Lo sconosciuto con nobile moderazione evitava di lamentarsi delle sue disgrazie. Vanina era pazza di lei. Solo una cosa sorprese molto la principessa: notò più di una volta che durante una conversazione seria lo sconosciuto trattenne un improvviso desiderio di ridere.
"Vorrei sapere il tuo nome", disse la principessa.
Mi chiamo Clementina.
«Allora, cara Clementina, domani alle cinque verrò a trovarti.
Il giorno successivo, Vanina vide che la sua nuova amica stava peggiorando.
"Chiamerò un chirurgo per vederti", disse Vanina, baciandola.
No, è meglio morire! obiettò lo sconosciuto. “Non accetterei mai di ferire i miei benefattori.
- Attesa! Chirurgo di monsignor Savelli Catanzar, governatore di Roma, figlio di uno dei nostri servi», disse in fretta Vanina. “E' attaccato a noi e per la sua posizione non può avere paura di nessuno. Invano mio padre diffida della sua devozione. Lo manderò a chiamare ora.
- Non farlo, non farlo! esclamò lo sconosciuto, con un'emozione che sorprese Vanina. “Vieni a trovarmi, e se Dio mi chiama a Lui, sarò felice di morire tra le tue braccia”.
Il giorno successivo, lo sconosciuto si ammalò gravemente.
"Se mi ami", le disse Vanina congedandosi, "accetta di ricevere il chirurgo".
- Se viene, la mia felicità crollerà.
«Manderò a chiamare un chirurgo» insistette Vanina.
Lo sconosciuto, senza rispondere, la trattenne e premette le labbra sulla sua mano. Ci fu un lungo silenzio; Lo sconosciuto aveva le lacrime agli occhi. Alla fine lasciò andare la mano di Vanina, e con uno sguardo come se stesse per morire, disse:
«Te lo devo confessare: l'altro ieri ho mentito chiamandomi Clementina. Sono uno sfortunato carbonari...
Vanina la guardò sorpresa, si allontanò e si alzò dalla sedia.
«Sento», continuavano i Carbonari, «che con questa confessione mi sono privato dell'unica consolazione che ancora mi lega alla vita. Ma non voglio ingannarti, non è degno di me. Mi chiamo Pietro Missirilli, ho diciannove anni; mio padre è un povero chirurgo a Sant'Angelo in Vado; Sono un carbonari. Il nostro cancello è stato aperto. Fui condotto in catene dalla Romagna a Roma, gettato in una casamatta buia, illuminata giorno e notte solo da una piccola lampada; lì ho trascorso tredici mesi. Un'anima compassionevole ha pensato di salvarmi. Ero vestito con abiti da donna. Quando fui uscito dal carcere ed ero già giunto all'ultima porta, una delle guardie abusò vilmente dei carbonari; L'ho schiaffeggiato. Ti assicuro che non l'ho fatto per abilità senza scopo - me ne sono semplicemente dimenticato. A causa della mia incoscienza, sono stato inseguito per le strade di Roma, e così, nel buio della notte, ferito dalle baionette, perdendo le forze per la perdita di sangue, mi sono precipitato attraverso la porta aperta della casa di qualcuno. Sento soldati che corrono su per le scale dietro di me. Sono saltato dalla finestra nel giardino e sono caduto a pochi passi da una donna che stava passeggiando lungo il vicolo.
"Contessa Vitelleschi?" L'amico di mio padre? ha detto Vanina.
- Come! Te l'ha detto? esclamò Missirilli. “Chiunque fosse questa signora, mi ha salvato la vita; il suo nome non dovrebbe mai essere pronunciato. Quando i soldati sono entrati per prendermi, tuo padre mi stava già portando via con la sua carrozza... Mi sento male, molto male: per diversi giorni una baionetta alla spalla non mi ha permesso di respirare. Presto morirò e morirò nella disperazione perché non ti rivedrò più...
Vanina lo ascoltò con impazienza e corse via; Missirilli non vedeva pietà nei suoi begli occhi, feriva solo l'orgoglio.
Di notte venne da lui un chirurgo; è venuto da solo. Missirilli era disperato: aveva paura di non rivedere mai più Vanina. Cominciò a interrogare il chirurgo; lo ha dissanguato, ma non ha risposto alle domande. Lo stesso silenzio nei giorni seguenti. Pietro non distolse lo sguardo dalla porta a vetri, attraverso la quale Vanina entrava di solito dal terrazzo. Si sentiva profondamente infelice. Un giorno, verso mezzanotte, gli parve che qualcuno si trovasse al buio sul terrazzo. È Vanina?
Vanina veniva tutte le sere e, appoggiata alla porta a vetri, lo guardava.
Se gli parlo, pensò, sono persa!No, non lo devo rivedere mai più.
Ma, contrariamente alla sua decisione, Vanina ha involontariamente ricordato che tipo di amicizia provava per questo giovane quando lo considerava così innocentemente una donna. E dopo tanta intimità da dimenticarlo? Nei momenti di prudenza, Vanina era spaventata dal fatto che tutto fosse in qualche modo stranamente cambiato per lei da quando Missirilli aveva rivelato il suo nome: tutto ciò a cui aveva pensato in precedenza, tutto ciò che vedeva costantemente in giro, era andato da qualche parte, avvolto nella nebbia.
Non era trascorsa nemmeno una settimana quando Vanina, pallida e tremante, entrò nella stanza della carbonaria con il chirurgo. Venne a dire che era necessario persuadere il principe a trasferire le cure dei malati a uno dei servi. Rimase solo un minuto, ma pochi giorni dopo tornò con il chirurgo, per un sentimento di filantropia. Una sera, sebbene Missirilli stesse già molto meglio e Vanina non avesse più motivo di temere per la sua vita, osò venire da sola. Nel vederla, Missirilli si sentì sopra la felicità, ma cercò di nascondere il suo amore: soprattutto, non voleva perdere la sua dignità, come si addice a un uomo. Vanina entrò nella sua stanza, bruciante di vergogna, paura di sentire discorsi d'amore, e fu molto rattristato che l'avesse incontrata con parole di amicizia, amicizia nobile, devota, ma senza una sola scintilla di tenerezza.
Quando stava per partire, Pietro non ha nemmeno provato a trattenerla.
Pochi giorni dopo è tornata. L'incontro fu esattamente lo stesso: le stesse rispettose assicurazioni di devozione e di eterna gratitudine. Vanina ormai non si sforzava affatto di raffreddare gli entusiasmi della giovane Carbonari: anzi, temeva che non condividesse il suo amore. La ragazza, che prima era stata così orgogliosa, sentì amaramente quanto fosse grande la sua follia. Cercò di sembrare allegra, persino indifferente, iniziò a visitare meno spesso, ma non riusciva a decidersi a rifiutarsi completamente di visitare il paziente.
Missirilli ardeva d'amore, ma, ricordando la sua bassa nascita e proteggendo la sua dignità, decise che si sarebbe permesso di parlare d'amore solo se non avesse visto Vanina per un'intera settimana. L'orgogliosa principessa si difese con fermezza.
"Bene," si disse.
Rimase a lungo con il paziente, e lui le parlava come se venti persone le stessero ascoltando. Una sera, dopo che Vanina lo aveva odiato tutto il giorno e aveva promesso a se stessa di trattarlo ancora più freddamente, anche più severamente del solito, gli disse improvvisamente che lo amava. Ben presto si arresero completamente ai loro sentimenti.
Quindi, la follia di Vanina si è rivelata incommensurabile, ma, devo ammettere, era completamente felice. Missirilli non cercava più di proteggere la sua virilità: amava, come si ama con un primo amore a diciannove anni, come si ama in Italia. Con la sincerità della passione disinteressata, ha persino confessato all'orgogliosa principessa quali tattiche usava per ottenere la sua reciprocità. Era felice e si meravigliava che fosse possibile essere così felici.
Quattro mesi sono volati inosservati. E poi venne il giorno in cui il chirurgo restituì la libertà al paziente.
"Cosa devo fare adesso?" pensò Missirilli. "Ti nascondo ancora con una delle donne più belle di Roma? Sei davvero infelice se i tuoi figli riescono a lasciarti così facilmente!"
Vanina non aveva dubbi che sarebbe stata la più grande felicità per Pietro rimanere per sempre con lei: sembrava davvero molto felice. Ma lo scherzo malvagio del generale Bonaparte risuonava come un amaro rimprovero nell'anima di questo giovane e influenzò il suo atteggiamento verso le donne. Nel 1796, quando il generale Bonaparte stava lasciando Brescia [Brescia è una città della Lombardia (Nord Italia).], le autorità cittadine, che lo accompagnarono all'avamposto, gli dissero che i bresciani onorano la libertà più di tutti gli altri italiani.
"Sì", ha risposto, "adorano sfogarsi con i loro amanti".
Pietro disse a Vanina alquanto imbarazzato:
“Oggi, appena fa buio, devo uscire di qui.
Per favore, cerca di tornare prima dell'alba. Ti aspetterò.
«All'alba sarò a poche miglia da Roma.
- Ecco come! disse freddamente Vanina. - Dove stai andando?
“In Romagna, per vendicarmi”.
"Sono ricca", continuò Vanina con il tono più calmo. “Spero che accetti armi e denaro da me.
Missirilli la guardò negli occhi per alcuni istanti, poi improvvisamente la prese tra le sue braccia.
Anima mia, vita mia! Mi farai dimenticare tutto, anche il mio dovere, disse. “Ma hai un cuore così nobile, devi capirmi.
Vanina pianse molte lacrime, e fu deciso che avrebbe lasciato la Roma solo dopo un giorno.
«Pietro», disse il giorno dopo, «mi hai detto più volte che un uomo di grande fama - ecco, per esempio, un principe romano - e, inoltre, di grande ricchezza, potrebbe rendere grandi servigi alla causa della libertà se L'Austria è mai entrata in una guerra seria lontano dai nostri confini.
«Certo», disse Pietro sorpreso.
- Così! Sei una persona coraggiosa, ti manca solo una posizione elevata; Ti offro la mia mano e duecentomila lire di rendita. Otterrò il consenso di mio padre.
Pietro si gettò ai suoi piedi. Vanina era raggiante di gioia.
“Ti amo appassionatamente”, ha detto, “ma sono un povero uomo e sono un servo della mia patria. Più l'Italia è infelice, più devo esserle fedele. Avrei dovuto recitare un ruolo miserabile per diversi anni per ottenere il consenso di don Azdrubala. Vanina, ti rifiuto!
Missirilli si affrettò a legarsi con queste parole: il suo coraggio si stava affievolendo.
"Con mia disgrazia", esclamò, "ti amo più della vita stessa, e lasciare Roma è per me più terribile della tortura!" Oh, perché l'Italia non si è ancora liberata dei barbari! Con quale gioia verrei con te in America.
Vanina si è raffreddata. La sua mano è stata rifiutata! Il suo orgoglio era ferito. Ma un minuto dopo si gettò tra le braccia di Missirilli.
“Non mi sei mai stato così caro! - esclamò. – Sì, sono tuo per sempre... Mio caro dottore del villaggio, sei grande quanto i nostri antichi romani!
- Tutte le preoccupazioni per il futuro, tutti i consigli ottusi della prudenza sono stati dimenticati. È stato un momento di puro amore. E quando già poterono parlare con giudizio, Vanina disse:
“Arriverò in Romagna quasi contemporaneamente a te. Ordinerò di prescrivermi un trattamento sulle acque di Poretto [Poretto è una località vicino a Forlì, in Romagna.]. Mi fermerò al nostro castello di San Nicolò, vicino a Forlì
- E lì la mia vita sarà unita alla tua! esclamò Missirilli.
"D'ora in poi, il mio destino è osare tutto", disse Vanina con un sospiro. "Rovinerò il mio onore per te, ma comunque... amerai una ragazza disonorata?"
- Non sei mia moglie? esclamò Missirilli. - Adorabile moglie! Ti amerò per sempre e sarò in grado di difenderti.
Vanina doveva andare a trovarla. Non appena Missirilli fu lasciato solo, il suo comportamento gli parve barbaro. "Cos'è una patria?" si chiedeva. il mio mantello: abiti utili che devo comprare, a meno che non li abbia ereditati da mio padre. In sostanza, amo la mia patria e la libertà perché mi sono utili. E se non lo faccio t servono, se per me sono come un caldo mantello nel caldo dell'estate, perché dovrei comprarli, e anche a un prezzo così alto? Vanina è così buona e così straordinaria! Si prenderà cura di lei, lo farà dimenticami. Quale donna ha un solo amante? Da cittadina disprezzo tutti questi principi romani, ma hanno tanti vantaggi su di me! Devono essere irresistibili! Sì, se me ne vado, lei mi dimenticherà e io perderò lei per sempre."
Di notte Vanina venne a trovarlo. Pietro le raccontò delle sue esitazioni e di come, sotto l'influsso dell'amore per lei, fosse sorta nella sua anima una strana disputa sulla grande parola "patria". Vanina si rallegrò.
Se avesse dovuto scegliere tra me e la sua patria, pensò, mi avrebbe preferito.
Erano le tre nel campanile vicino. È l'ora dell'ultimo saluto. Pietro si è liberato dalle braccia della sua ragazza.
Aveva già cominciato a scendere le scale, quando improvvisamente Vanina, trattenendo le lacrime, gli disse con un sorriso:
“Senti, se qualche donna del villaggio si prendesse cura di te durante la tua malattia, non la ringrazieresti in alcun modo? Non proverebbe a pagarla? Il futuro è così sbagliato! Stai partendo, ci saranno così tanti nemici intorno a te in arrivo! Dammi tre giorni, pagami per le mie cure, come fossi una povera contadina.
Missirilli rimase.
Infine lasciò Roma e, grazie a un passaporto acquistato da un'ambasciata straniera, raggiunse la casa dei genitori. Fu una grande gioia per la famiglia: era già considerato morto.
Gli amici hanno voluto festeggiare il suo ritorno sicuro uccidendo due o tre carabinieri (così vengono chiamati i gendarmi nello Stato Pontificio).
"Non uccidiamo italiani che sanno usare le armi se non strettamente necessario", ha obiettato Missirilli. - La nostra patria non è un'isola, come la fortunata Inghilterra; per resistere all'invasione dei monarchi europei, avremo bisogno di soldati.
Qualche tempo dopo Missirilli, in fuga dall'inseguimento, uccise due carabinieri con le pistole dategli da Vanina.
Una taglia gli è stata messa in testa.
Vanina ancora non è venuta in Romagna. Missirilli pensava che fosse stato dimenticato. Il suo orgoglio era ferito; pensava spesso ora che la differenza di posizione sociale avesse eretto una barriera tra lui e la sua amata. Una volta, in un momento di amari rimpianti per la felicità passata, gli venne in mente di tornare a Roma, per scoprire cosa stesse facendo Vanina. Questo pensiero stravagante quasi ebbe la meglio sulla coscienza del dovere, ma all'improvviso, al tramonto, la campana della chiesa suonò in montagna per i Vespri, ed era così strano che la distrazione assalì la suoneria. Questo fu il segnale per la riunione della venta, alla quale Missirilli si unì appena rientrato in Romagna. Nella stessa notte, tutti i Carbonari si ritrovarono nella foresta, nella dimora di due eremiti. Entrambi dormivano profondamente sotto l'effetto dell'oppio e non sospettavano nemmeno per quale scopo fosse usata la loro capanna. Missirilli venne molto triste, e poi gli fu detto che il capo dei Venta era stato arrestato e che avevano deciso di eleggerlo, Pietro, un giovane di vent'anni, come loro nuovo capo dei Carbonari, sebbene tra loro c'erano cinquanta vecchi - persone che avevano partecipato a cospirazioni sin dai tempi della campagna di Murat nel 1815. Accettando questo onore inaspettato, Pietro si sentì battere il cuore. Appena rimasto solo, decise di non pensare più alla giovane romana, che così presto l'aveva dimenticato, e di dedicare tutti i suoi pensieri al debito di liberare l'Italia dai barbari.
Due giorni dopo Missirilli lesse nell'elenco degli arrivi e delle partenze, che gli era stato consegnato come capo della venta, che la principessa Vanina era arrivata al suo castello di San Nicolò. Questo nome portava gioia e confusione nella sua anima. Invano, per devozione alla patria, represse il desiderio quella sera di precipitarsi al castello di San Nicolò: il pensiero di Vanina, che trascurava, non gli permetteva di concentrarsi sui suoi doveri. Il giorno successivo si incontrarono; Vanina lo amava lo stesso. Rimase a Roma perché suo padre, volendola sposare, non l'avrebbe lasciata andare. Ha portato con i suoi duemila lustrini [Tsekhin è una vecchia moneta veneziana d'oro.].
Questo supporto inaspettato aiutò notevolmente Missirilli ad adempiere ai suoi nuovi doveri onorari. Nell'isola di Corfù [Corfù è un'isola nel Mar Mediterraneo, non lontano dall'Italia.] ordinarono pugnali, corruppero il segretario personale del legato [Legate è un rappresentante pontificio dotato di grandi poteri.], che guidò la persecuzione di i Carbonari, e così ottenne un elenco di sacerdoti che erano spie del governo.
Proprio in quel momento si preparava una congiura, una delle meno (?) avventate che fossero mai sorte nell'Italia longanime. Non entrerò nei dettagli, ma dirò solo che se ci fosse riuscito, Missirilli avrebbe avuto una buona parte della fama. Grazie a lui diverse migliaia di ribelli si sarebbero sollevati a questo segnale con le armi in mano e avrebbero aspettato l'arrivo dei capi. Il momento decisivo si avvicinava e all'improvviso, come sempre accade, il complotto fallì a causa dell'arresto dei capi.
Appena Vanina arrivò in Romagna, le sembrò che l'amore per la sua terra eclissasse ogni altra passione nel cuore di Missirilli. L'orgoglio della giovane romana era indignato. Invano cercò di ragionare con se stessa: una cupa malinconia la tormentava e si sorprese a maledire la libertà. Un giorno, quando venne a Forlì per vedere Missirilli, non riuscì a controllarsi, anche se fino ad allora l'orgoglio l'aveva sempre aiutata a nascondere il suo dolore.
"Mi ami davvero come un marito", ha detto. - Non me l'aspettavo.
Scoppiò in lacrime, ma pianse solo per la vergogna di essersi chinata a rimproverare. Missirilli la consolò; ma era evidente che era preoccupato per le sue stesse preoccupazioni. E improvvisamente Vanina ha avuto l'idea di lasciarlo e tornare a Roma. Pensò con crudele gioia che questa sarebbe stata la sua punizione per la debolezza: perché lamentarsi! In un momento di silenzio, la sua intenzione si rafforzò, Vanina si sarebbe considerata indegna di Missirilli se non lo avesse abbandonato. Pensò con piacere alla sua amara sorpresa quando l'avrebbe aspettata invano, cercandola qui. Ma presto fu profondamente turbata dal pensiero di non essere stata in grado di mantenere l'amore di quest'uomo, per amore del quale aveva commesso tante follie. Rompendo il silenzio, gli parlò. Ha fatto del suo meglio per ottenere almeno una parola d'amore. Pietro le rispose affettuosamente, teneramente, ma così distrattamente... Ma che sentimento profondo risuonò nella sua voce quando, toccando i suoi progetti politici, esclamò mesto:
"Oh, se falliamo ancora, se si scopre anche questa trama, lascerò l'Italia!"
Vanina si immobilizzò: ogni minuto era sempre più tormentata dalla paura di vedere per l'ultima volta la sua amata. Le sue parole hanno acceso una scintilla fatale nei suoi pensieri.
"I Carbonari hanno ricevuto da me diverse migliaia di lustrini. Nessuno può dubitare della mia simpatia per la congiura..." Interrompendo la sua meditazione, disse a Pietro:
- Ti prego, andiamo con me a San Nicolò, solo per un giorno! Non c'è bisogno che tu partecipi alla riunione di Venta stasera. E domani mattina saremo già a San Nicolò, vagheremo per i campi; ti riposerai, ti calmerai, e quindi hai bisogno di tutta la tua forza e autocontrollo: dopotutto, i grandi eventi si stanno avvicinando.
Pietro acconsentì.
Vanina lo lasciò per prepararsi al viaggio e, come al solito, chiuse a chiave la stanza dove lo nascondeva. Si precipitò dalla sua ex cameriera, che si era sposata e che ora gestiva un negozio a Forlì. Correndo verso questa donna, Vanina scrisse frettolosamente ai margini del Libro d'Ore [Ore è un libro di chiesa in cui, oltre alle preghiere, ci sono anche inni di chiesa.], che compariva nella stanza, poche righe, indicando esattamente il luogo dove i carbonari venta avrebbero dovuto raccogliersi di notte. Ha concluso la denuncia con le seguenti parole: "Venta è composta da diciannove persone. Ecco i loro nomi e indirizzi". Dopo aver fatto un elenco completo, dove mancava solo il nome di Missirilli, disse a questa donna che godeva della sua fiducia:
- Portare il libro al cardinale legato [Il cardinale è il grado spirituale più alto dopo il papa tra i cattolici. Un legato cardinalizio è un rappresentante del papa, dotato di poteri speciali.]. Lascia che legga ciò che è scritto a margine e te lo restituisca. Ecco, prendi dieci lustrini. Se mai il legato pronuncerà il tuo nome, non sfuggirai alla morte; ma se gli fai leggere la pagina scritta, mi salverai la vita.
Tutto ha funzionato alla grande. Il legato era così spaventato che perse tutta la sua grandezza. Permise a un cittadino comune che voleva parlargli di una questione segreta di non togliersi la maschera, ma ordinò di legarle le mani. In questa forma, il negoziante apparve davanti a questo alto dignitario; non osò lasciare l'enorme tavola coperta di tovaglia verde.
Il legato lesse la pagina scritta, tenendo molto lontano da sé il Libro delle Ore, per paura che il libro fosse saturo di una specie di veleno. Quindi restituì il Libro d'Ore al negoziante e non mandò nemmeno spie a seguirne le tracce. Non erano passati nemmeno quaranta minuti da quando Vanina era uscita di casa, e aveva già visto la cameriera che tornava ed era corsa da Missirilli, credendo fermamente che d'ora in poi lui le appartenesse completamente. Gli disse che c'era un traffico insolito in città, le pattuglie erano ovunque, anche lungo strade dove non erano mai state viste.
Missirilli acconsentì. Uscirono dalla città; non lontano dall'avamposto, una carrozza aspettava Vanina, dove sedeva la sua compagna, confidente silenziosa e generosamente pagata. Giunta a San Nicolò, la Vanina, costernata del suo gesto mostruoso, si strinse teneramente a Pietro. Ma quando gli rivolgeva parole d'amore, le sembrava di recitare in una commedia. Il giorno prima, commettendo un tradimento, si era dimenticata del rimorso. Abbracciando il suo amante, pensò: "Ora vale la pena che qualcuno dica una parola a Pietro, una sola parola - e mi odierà per sempre...".
A tarda notte, uno dei domestici di Vanina entrò nella camera da letto. Quest'uomo era un carbonari, cosa che lei non sospettava. Quindi Missirilli aveva dei segreti con lei anche su questo? Lei rabbrividì. Venne un servitore ad avvertire i Missirilli che quella notte le case dei diciannove Carbonari erano state transennate a Forlì, ed essi stessi furono arrestati di ritorno da una riunione dei Venta. Furono colti di sorpresa, ma ancora nove Carbonari riuscirono a scappare. I dieci carabinieri rimasti furono condotti nella fortezza. Entrando nel cortile della prigione, uno degli arrestati si gettò in un pozzo profondo e morì. Il volto di Vanina cambiò; fortunatamente per lei, Pietro non se ne accorse: poteva leggere nei suoi occhi il delitto che aveva commesso...